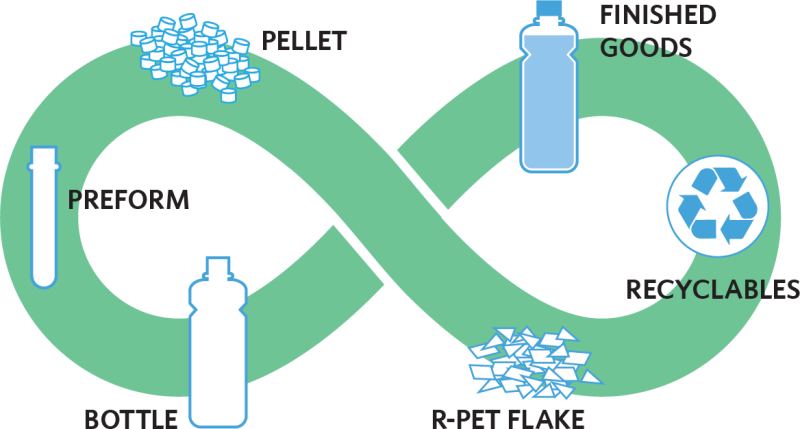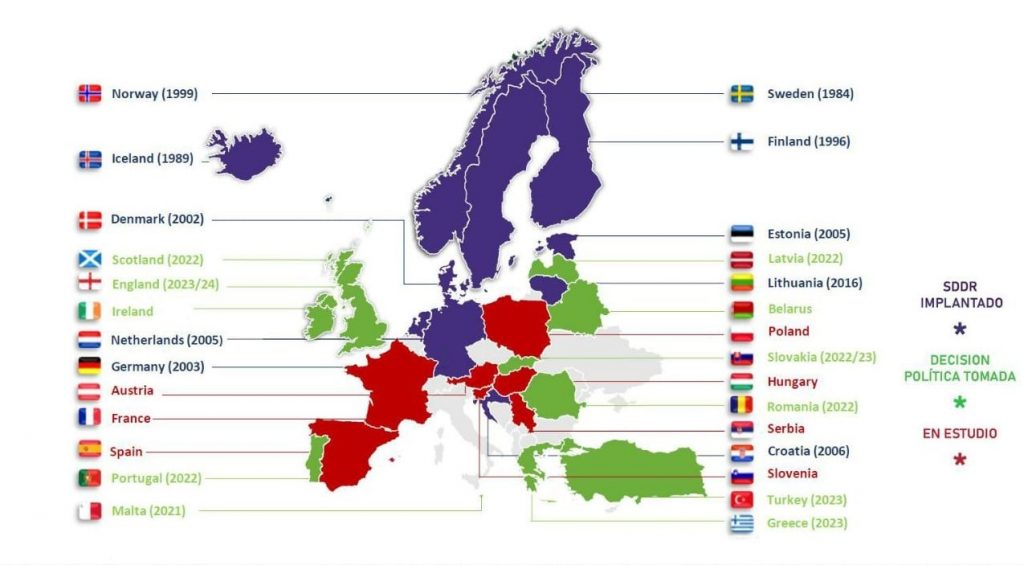Qualcuno, tra i più creduloni, se ne potrà stupire, ma quando si tratta di spianare la strada alla “libera” circolazione delle merci, la difesa dei “nostri” interessi, dei prodotti del “suolo patrio”, della salute degli italiani e dei diritti di chi lavora, si piegano ancora come canne al vento.

A metà dicembre, il Parlamento europeo – con i voti di M5S, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e di gran parte del Pd – ha dato il via libera allo Jefta, l’accordo di libero scambio tra Ue e Giappone che ha la stessa struttura e gli stessi problemi di CETA e TTIP e che entrerà subito in vigore senza il vaglio dei parlamenti nazionali. Per puro amore di cronaca, c’è da ricordare che prima delle ultime elezioni il M5S, addirittura nella piattaforma on line, e la Lega si erano impegnati a non votare accordi non sottoposti al voto dei parlamenti nazionali e a favorire un’attenta valutazione di costi e benefici. A proposito dei quali, la strenua opposizione di associazioni, movimenti e sindacati si spiega con il rischio elevato di gravi problemi per la protezione dei servizi pubblici, del principio di precauzione, la custodia dei dati personali, i diritti sindacali e del lavoro, la contraffazione dei prodotti italiani e zero tutele contro i cambiamenti climatici. Senza contare che il Giappone è il paese con la maggior parte delle colture Ogm approvate, sia per alimenti che per mangimi animali, e che la soglia per la presenza accidentale di materiale OGM negli alimenti è del 5% contro lo 0,9 europeo. Il Giappone non ha ratificato, inoltre, nessuna delle Convenzioni internazionali sul Lavoro ILO, nemmeno quelle per l’abolizione del lavoro schiavo e della non discriminazione sul lavoro

L’Italia sovranista e in difesa del popolo, e quella strenuamente antisovranista e antipopulista, in pieno accordo cuore a cuore, hanno dato insieme l’ok a Strasburgo all’accordo di liberalizzazione commerciale tra Europa e Giappone JEFTA che, nelle previsioni migliori, pur valendo il 30% dell’intero mercato globale, porterà a un aumento del Pil europeo di un misero 0,14% entro il 2035, a nessun sensibile effetto sull’occupazione, con gravi problemi per i diritti di tutti noi, ma anche per le nostre taschei. Se, infatti, dazi e tariffe sui prodotti europei esportati in Giappone erano già in media bassi, il Jefta comporterà una perdita di dazi per gli Stati membri stimata dalla Commissione Europea in 970 milioni di euro all’entrata in vigore dell’accordo.Dopo che l’accordo sarà stato pienamente applicato, trascorsi 15 anni dalla sua entrata in vigore, la perdita annuale di dazi per le casse pubbliche raggiungerà i 2,084 miliardi di euro l’annoii
Nonostante tutto questo, il Parlamento europeo, con i voti di M5S, Lega, gran parte del Pd, Forza Italia e dell’unico membro eletto da Fdi, ha dato il via libera all’accordo, che ha la stessa struttura e gli stessi problemi di CETA e TTIP e che entrerà subito in vigore senza essere sottoposto al vaglio dei parlamenti nazionali.
Poco è importato che Strasburgo fosse appena stata colpita da un sanguinoso attentato, e che associazioni, sindacati, movimenti, gli stessi che si battono contro CETA e TTIP, dall’inizio del negoziato nel marzo 2013 sostenessero che un accordo con gravi problemi per la protezione dei servizi pubblici, del principio di precauzione, la custodia dei dati personali, i diritti sindacali e del lavoro, la contraffazione dei prodotti italiani e zero tutele contro i cambiamenti climatici, con una potenza commerciale globale come il Giappone, non andasse approvato. Poco importa che il M5S e la Lega si fossero impegnati prima delle elezioni – i primi addirittura nella propria piattaforma online – a non approvare mai più accordi che non fossero sottoposti al voto dei Parlamenti nazionali e che non fossero stati preceduti da un’attenta valutazione costi benefici.
Nulla è importato, in questo caso, che la Commissione abbia cucinato il JEFTA senza che i Parlamentari lo leggessero mai prima della sua firma, cinque anni dopo, e con riunioni che per l’86% hanno coinvolto imprese e corporation, e solo per il 4% sindacati, associazioni e enti locali. Probabilmente ha contato di più la voce dei comitati di affari europei e giapponesi -Japan Business Council, BusinessEurope, Keidanren, SMEunited, Copa Cogeca, Eurochambers and the European Business Council – che pochi giorni fa hanno scritto ai parlamentari di “ratificare l’accordo il più velocemente possibile”iii. E infatti così è stato.
Questo “buon accordo”, come è stato definito da tutti i suoi sostenitori, non è buono per niente. Proprio come il CETA, il JEFTA limita la capacità degli Stati membri di creare, ampliare e regolamentare i servizi pubblici o di invertire (o intervenire) processi di liberalizzazioni falliti. Tutto ciò che non sia specificamente nella lista negativa inclusa nel trattato, è aperto alla concorrenza da parte delle imprese giapponesi e, quindi, potenzialmente disponibile alla privatizzazione. Rispetto all’acqua, in particolare, l’Italia non ha previsto una riserva relativa alla gestione futura dei servizi igienico-sanitari (che comprende la gestione delle acque reflue), inclusa la riserva di adottare o mantenere qualsiasi misura relativa all’operazione di monopoli o fornitori pubblici di servizi esclusivi.

Il JEFTA non protegge il principio di precauzione europeo: lo cita nel capitolo sullo Sviluppo sostenibile che non è vincolante ne’ prevede sanzioni nel caso non sia protetto. Come il CETA, inoltre, è un “trattato vivente” che mette al lavoro ben 11 comitati che lavoreranno ad accelerare gli scambi tra Giappone e Europa avendo come principio-chiave quello dell’aumento dei profitti e non del rispetto di diritti e convenzioni.
Il Jefta impone di non ripetere più in Europa i controlli sanitari su alimenti e mangimi in arrivo dal Giappone, nonostante le infrazioni più consistenti alle normative anti-Ogm europee siano a carico di merci giapponesi, da ultimo il caso francese che ha interessato anche l’Italia. A livello mondiale, il Giappone è il paese con la maggior parte delle colture Ogm approvate sia per alimenti che per mangimi animali, e quindi il rischio di un aumento delle contaminazioni, in presenza di un trattato che abbatte il numero di controlli alle frontiere d’arrivo, è innegabile. In Europa, per di più, la soglia per la presenza accidentale di materiale OGM negli alimenti è fissata allo 0,9 per cento, mentre nei regolamenti giapponesi è prevista una soglia del 5%, che rappresenta uno dei limiti più alti del mondo per l’etichettatura OGM in caso di contaminazione involontaria. I prodotti trasformati in Giappone non richiedono l’etichettatura OGM visto che il DNA modificato o le proteine derivate da tale DNA non possono essere rilevati dopo la trasformazione: anche se c’erano degli OGM tra gli ingredienti originali, nessuno in Giappone lo segnalerà e in Europa essi potranno entrare senza essere individuati.
Anche presenza di “gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza o alla salute dell’uomo, degli animali o delle piante o alle misure proposte o attuate dall’altra Parte, una Parte può richiedere consultazioni tecniche” prima di intervenire con misure urgenti. Di più: si devono “fornire le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi o a raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile”.
Il Giappone non ha ratificato nessuna delle Convenzioni internazionali sul Lavoro ILO, nemmeno quelle per l’abolizione del lavoro schiavo e della non discriminazione sul lavoro, ed è difficile che lo faccia, nonostante le pressioni ricevute dal Parlamento europeo, visto che il trattato su questo non pone condizioni vincolanti o sanzioni in caso di violazioni e fino ad oggi le risposte in merito del governo Abe sono state cortesi ma evasive.
Dopo l’entrata in vigore del Jefta, ogni regolamento tecnico, le norme e le procedure di valutazione della conformità che Europa, Giappone e i loro Stati membri volessero far entrare in vigore su prodotti alimentari e non di tutti i tipi – dall’etichettatura ai marchi di sicurezza, da procedure qualitative, alle certificazioni agli standard, dovranno essere notificati all’altra parte, non porre in essere indebiti ostacoli agli scambi, e bisognerà obbligatoriamente confrontarsi con il Giappone per “ridurre gli indebiti effetti negativi sugli scambi derivanti dalle misure di questo tipo”. Alla faccia della sovranità nazionale e dell’eccellenza regolatoria europea.
In un momento in cui la comunità internazionale viene richiamata dalla scienza a una lotta più serrata a inquinamento e cambiamenti climatici, il Jefta cita l’Accordo di Parigi come obiettivo condiviso da Europa e Giappone nel capitolo sullo Sviluppo sostenibile, ma non prevede sanzioni per chi ne violi o disattenda le previsioni o aumenti i suoi livelli di inquinamento . A chi sottolinea che il JEFTA non include il meccanismo ISDS per la protezione degli investimenti esteri, va fatto notare che prevede esplicitamente che dopo la firma si avvii un negoziato specifico che lo introdurrà il più rapidamente possibile, nonostante sia pendente un giudizio sulla sua compatibilità con i trattati europei alla Corte europea di Giustiziav
. A chi sottolinea che il JEFTA non include il meccanismo ISDS per la protezione degli investimenti esteri, va fatto notare che prevede esplicitamente che dopo la firma si avvii un negoziato specifico che lo introdurrà il più rapidamente possibile, nonostante sia pendente un giudizio sulla sua compatibilità con i trattati europei alla Corte europea di Giustiziav
Rispetto alla sicurezza alimentare, il Jefta vincola i suoi membri al Codex Alimentarius, e alle prescrizioni generali già garantite in ambito WTO, fallendo l’obiettivo di allineare i livelli di garanzie agli standard più avanzati già presenti in alcuni dei Paesi membri dell’Ue, a partire dall’Italia.
Il trattato va a proteggere solo 19 Indicazioni geografiche relative a prodotti di qualità italiani e 28 su vini e alcolici, su un totale di 205 IG europee protette. Il capitolo sui prodotti d’eccellenza è il più debole di quelli mai letti in un trattato internazionale, e non dovrebbe esserlo visto che il Giappone è tra le principali centrali di smistamento per l’Italian sounding nel mercato asiatico. Si prevede la coesistenza per Asiago, Fontina e Gorgonzola italiani e giapponesi per sette anni. Durante questo periodo l’utilizzo dei nomi deve essere accompagnato dall’indicazione dell’origine in etichetta. ln Giappone dopo il JEFTA qualsiasi persona potrà utilizzare o registrare un marchio contenente il termine “parmesan” o da esso costituito per indicare un formaggio a pasta dura, che coesisterà serenamente con il nostro Parmigiano, a patto che non induca in errore rispetto alla sua origine italiana.

Il “Grana Padano” è tutelato solo come dicitura unica, mentre le diciture “Grana” e “Padano” potranno essere indicate in etichetta da sole senza per questo prevedere il sequestro del prodotto. Anche la “Mortadella Bologna” verrà protetta solo come dicitura unica, mentre “Mortadella” e Grana potranno essere utilizzate separatamente. Non è richiesta dal JEFTA la tutela degli elementi “mozzarella” e “mozzarella di bufala” dell’indicazione geografica composta “Mozzarella di Bufala Campana”, che verrà protetta solo come dicitura unica. Stesso destino tocca ai “Pecorino Toscano” e “Pecorino Romano” e al “Provolone Valpadana”. Storia a sé invece la fa il Prosciutto di Parma al quale, se registrato con marchio giapponese al momento di entrata in vigore del trattato, non si applica la tutela come Indicazione geografica italiana e si procede alla coesistenza.
Il Giappone difende ben 48 IG tra cui una specie di castagne, una specie di pesce palla, una specie di vongola d’acqua dolce, il salmone argentato, la pianta medicinale bardana, il tè verde in polvere Nishio no Matcha, diversi tipi di manzo tra cui il Kobe, un tipo di pesci bianchetti, alcune paste di Miso per condimenti e zuppe e i cachi giapponesi essiccati.
Il trattato prevede la garanzia che le Parti abbiano in vigore una Procedura amministrativa che consenta di verificare la consistenza dell’indicazione geografica, e Procedure di opposizione e cancellazione, per difendere eventuali terzi. Per sette anni dall’entrata in vigore del trattato, però, anche per i prodotti identificati dalla stessa indicazione geografica di un prodotto protetto, potranno essere “effettuate nel territorio del Giappone operazioni di grattugiatura, affettatura e confezionamento, compresi il taglio in porzioni e l’imballaggio interno, purché il prodotto in questione sia destinato al mercato giapponese e non alla riesportazione”. Quando un marchio sia stato registrato in buona fede in Europa o in Giappone prima dell’entrata in vigore del JEFTA, quindi fino al 12 dicembre 2018, il marchio sarà ritenuto ammissibile e la sua registrazione valida come il suo diritto d’uso, anche se fosse identico o simile a una indicazione geografica italiana.
Infine, e solo avendo citato le problematiche più macroscopiche, Una disposizione sui flussi di dati nell’area dei servizi finanziari contenuta nel Jefta all’interno del capitolo dei servizi finanziari stabilisce, forzando il quadro normativo sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR), la libertà di cross-border di informazioni e dati nell’ambito delle attività di servizi finanziari a entrambe le parti. Nulla in queste disposizioni limita il diritto delle parti a proteggere i dati personali, la privacy personale e la confidenzialità dei singoli registri e dei conti, si aggiunge, purché tale diritto non limiti il flusso degli scambi dei servizi, mettendo ancora una volta diritti e interessi in diretta competizione.
Anche solo da questi pochi elementi è abbastanza risibile che il JEFTA, come il CETA, venga propagandato come un accordo progressista, avanzato e accettabile, quando contiene le solite, stesse, pericolose pretese che i grandi gruppi industriali europei ripresentano su tutti i tavoli. Chi ha cambiato idea rispetto agli impegni assunti nella campagna elettorale italiana, dovrà chiarire e bene le sue priorità e convinzioni prima delle prossime scadenze elettorali perché il cambiamento si dimostra tale solo non se continua, business as usual, a votare le stesse cose di sempre. E soprattutto se li vota insieme a chi quegli sporchi, vecchi affari li ha sempre sponsorizzati e proposti.
Monica Di Sisto
vicepresidente di Fairwatch, portavoce della campagna Stop TTIP/CETA Italia