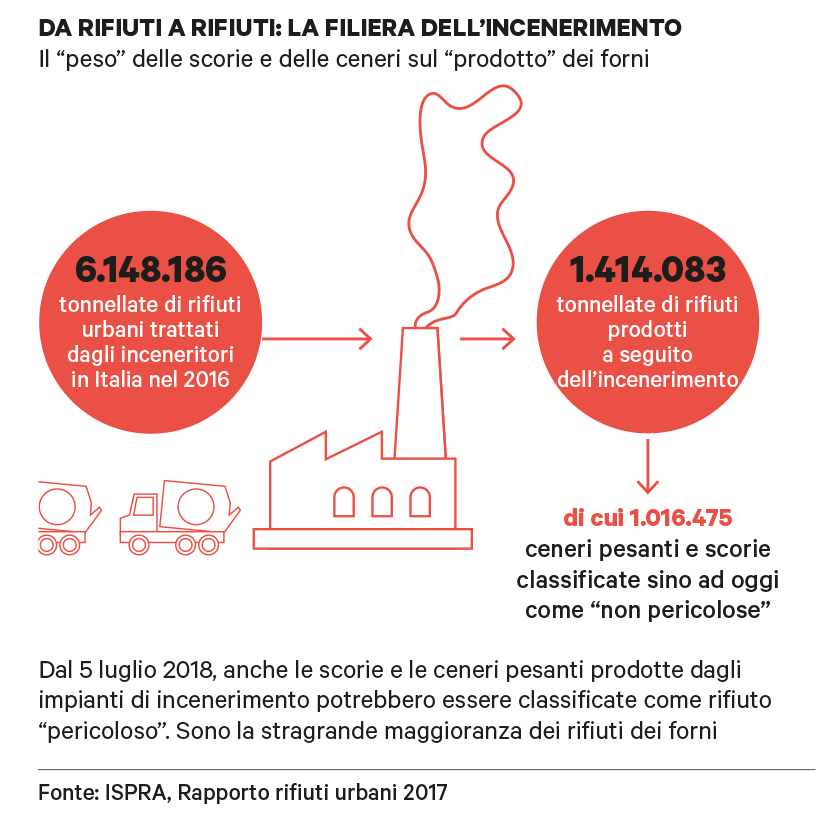Secondo Ecopneus, l'utilizzo nei campi sportivi in erba sintetica risponde già ai limiti sugli IPA che entreranno in vigore l'anno prossimo.
Il polverino di gomma ottenuto dal riciclo di pneumatici fuori uso (PFU) può essere utilizzato come intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in altri utilizzi in forma sfusa, anche alla luce del nuovo Regolamento UE 2021/1199
(leggi articolo), che fissa limiti più restrittivi alla presenza di di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).
Ad affermarlo è Ecopneus, società consortile senza scopo di lucro per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) in Italia, che cita i risultati di uno studio condotto cinque anni fa con il supporto scientifico dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e della società Waste and Chemicals (leggi articolo).

I risultati sui campioni analizzati evidenziarono infatti che la somma degli otto IPA soggetti alla restrizione 28 del Regolamento REACh era compresa tra 5 e 20 mg/kg, quindi sotto la nuova soglia di 20 mg/kg che entrerà in vigore il il 10 agosto 2022, nonché inferiore ai limiti introdotti dal decreto End of waste per la gomma granulare vulcanizzata (DM 178/2020).
" Il Regolamento (UE) 2021/1199 – sostiene Federico Dossena, Direttore Generale di Ecopneus - introduce riferimenti importanti per la salute degli sportivi e cittadini cui la gomma riciclata risponde già, anche con sistemi di campionamento e controllo sugli impianti di produzione definiti dal decreto End of waste, a differenza di altri materiali polimerici che, proveniendo da filiere non altrettanto controllate, possono introdurre sul mercato materiali fuori limite e spesso erroneamente confusi con la gomma riciclata, creando pericolosa confusione per le aziende, il sistema e per i cittadini".
fonte: www.polimerica.it
" Il Regolamento (UE) 2021/1199 – sostiene Federico Dossena, Direttore Generale di Ecopneus - introduce riferimenti importanti per la salute degli sportivi e cittadini cui la gomma riciclata risponde già, anche con sistemi di campionamento e controllo sugli impianti di produzione definiti dal decreto End of waste, a differenza di altri materiali polimerici che, proveniendo da filiere non altrettanto controllate, possono introdurre sul mercato materiali fuori limite e spesso erroneamente confusi con la gomma riciclata, creando pericolosa confusione per le aziende, il sistema e per i cittadini".
fonte: www.polimerica.it
#Iscriviti QUI alla #Associazione COORDINAMENTO REGIONALE UMBRIA RIFIUTI ZERO (CRU-RZ)
=> Seguici su Blogger
https://rifiutizeroumbria.blogspot.com
=> Seguici su Facebook
=> Seguici su Facebook