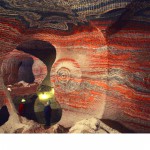È un costo complessivo compreso tra gli 81 e i 99 miliardi di euro, in pratica la metà del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quello che l’Italia potrebbe essere costretta a sostenere a causa della perdita dei servizi ecosistemici dovuta al consumo di suolo tra il 2012 e il 2030. Se la velocità di copertura artificiale rimanesse quella di 2 mq al secondo registrata nel 2020 i danni costerebbero cari e non solo in termini economici. Dal 2012 ad oggi il suolo non ha potuto garantire la fornitura di 4 milioni e 155 mila quintali di prodotti agricoli, l’infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana (che ora scorrono in superficie aumentando la pericolosità idraulica dei nostri territori) e lo stoccaggio di quasi tre milioni di tonnellate di carbonio, l’equivalente di oltre un milione di macchine in più circolanti nello stesso periodo per un totale di più di 90 miliardi di km. In altre parole due milioni di volte il giro della terra.
È la situazione attuale e quella futura analizzata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente nell’edizione 2021 del Rapporto sul “Consumo di Suolo in Italia”. Il Rapporto è stato presentato nel corso di un webinar il 14 luglio. Disponibile anche la video inchiesta dal titolo “Speciale Roma e Milano: neanche il Covid19 ferma il consumo di suolo” promossa da Ispra.
A livello nazionale le colate di cemento non rallentano neanche nel 2020, nonostante i mesi di blocco di gran parte delle attività durante il lockdown, e ricoprono quasi 60 chilometri quadrati, impermeabilizzando ormai il 7,11% del territorio nazionale. Ogni italiano ha a disposizione circa 360 mq di cemento (erano 160 negli anni ’50).
L’incremento maggiore quest’anno è in Lombardia, che torna al primo posto tra le regioni con 765 ettari in più in 12 mesi, seguita da Veneto (+682 ettari), Puglia (+493), Piemonte (+439) e Lazio (+431).
Nelle aree a pericolosità idraulica la percentuale supera al 9% per quelle a pericolosità media e il 6 % per quelle a pericolosità elevata. Il confronto tra i dati 2019 e 2020 mostra che 767 ettari del consumo di suolo annuale si sono concentrati all’interno delle aree a pericolosità idraulica media e 285 in quelle a pericolosità da frana, di cui 20 ettari in aree a pericolosità molto elevata (P4) e 62 a pericolosità elevata. Le percentuali si confermano alte anche nei territori a pericolosità sismica alta dove il 7% del suolo risulta ormai cementificato.
Consumo di suolo e isole di calore. A livello nazionale superano i 2300 gli ettari consumati all’interno delle città e nelle aree produttive (il 46% del totale) negli ultimi 12 mesi. Per questo le nostre città sono sempre più calde, con temperature estive, già più alte di 2°C, che possono arrivare anche a 6°C in più rispetto alle aree limitrofe non urbanizzate.
Transizione ecologica e fotovoltaico, meglio sui tetti che a terra: solo in Sardegna ricoperti più di un milione di mq di suolo, il 58% del totale nazionale dell’ultimo anno. E si prevede un aumento al 2030 compreso tra i 200 e i 400 kmq di nuove installazioni a terra che invece potrebbero essere realizzate su edifici esistenti. Il suolo perso in un anno a causa dell’installazione di questa tipologia di impianti sfiora i 180 ettari. Dopo la Sardegna è la Puglia la regione italiana che consuma di più con tale modalità, con 66 ettari (circa il 37%).
E con la logistica l’Italia perde ancora più terreno. Invece di rigenerare e riqualificare spazi già edificati, sono stati consumati in sette anni 700 ettari di suolo agricolo e il trend è in crescita. In Veneto le maggiori trasformazioni (181 ettari dal 2012 al 2019, di cui il 95% negli ultimi 3 anni) dovute alla logistica, seguita da Lombardia (131 ettari) ed Emilia-Romagna (119).
fonte: www.snpambiente.it/
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
#Iscriviti QUI alla #Associazione COORDINAMENTO REGIONALE UMBRIA RIFIUTI ZERO (CRU-RZ)
=> Seguici su Blogger
https://rifiutizeroumbria.blogspot.com
=> Seguici su Facebook
=> Seguici su Facebook