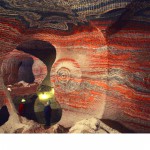Visualizzazione post con etichetta #Deforestazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta #Deforestazione. Mostra tutti i post
Stefano Zamagni a Circonomia: agire su crisi economica e ambientale, altrimenti rischio di nuova emergenza tra un decennio
Labels:
#Ambiente,
#CambiamentoRadicale,
#Circonomia,
#Clima,
#COP26,
#Deforestazione,
#Disuguaglianza,
#Ecologia,
#Economia,
#EconomiaCircolare,
#EmergenzaClima,
#ImpattoAmbientale,
#ImpattoSociale,
#Pandemie
"I biocarburanti dell'Ue hanno causato la deforestazione di un'area grande come l'Olanda"
La stessa Commissione europea ha ammesso che il biodiesel derivato dagli oli vegetali di palma e soia inquina dalle due alle tre volte di più rispetto al diesel fossile

Negli ultimi dieci anni, i biocarburanti voluti dall’Ue per rimpiazzare i combustibili fossili hanno causato la scomparsa di un’area totale di foresta pari alla superficie dell’Olanda e hanno emesso fino a tre volte più CO2 rispetto al diesel che hanno sostituito. Queste le conclusioni poco incoraggianti dello studio condotto da Transport & Environment (T&E), un’organizzazione attiva sui temi della mobilità sostenibile. Il documento mette in evidenza, oltre alle scelte discutibili fatte da Bruxelles, quali sono i Paesi che hanno scommesso di più sui carburanti di nuova generazione. Nel 2020, l’Italia è stata la terza produttrice europea di biodiesel, alle spalle di Spagna e Paesi Bassi, e la quarta per consumi.
“Nel 2009 - si ricorda nello studio - è stata introdotta la direttiva Ue sulle energie rinnovabili (Red) per promuovere l’uso” delle fonti alternative a quelle fossili “nel settore dei trasporti”. La norma ha obbligato “gli Stati membri, entro il 2020, a rispettare una quota del 10% di energia rinnovabile nel consumo finale di energia dei trasporti”. Tuttavia, tali regole “hanno trascurato le salvaguardie della sostenibilità e non hanno tenuto conto dell'intero ciclo di vita delle emissioni legate alla catena di approvvigionamento del carburante e all'uso del suolo”. In altre parole, “il consumo della gran parte di biocarburanti” ha portato ad “emissioni complessive di gas serra superiori rispetto ai combustibili fossili”.

Ad esempio, la domanda di biodiesel dell’Ue ha richiesto la coltivazione di 1,1 milioni di ettari di palme nel sud-est asiatico e di 2,9 milioni di ettari di semi di soia in Sud America. Superfici strappate ai preziosi milioni di ettari di foresta, riconvertita alle monocolture necessarie per le produzione dei carburanti. Il documento di T&E ricorda che nel 2012 e nel 2016 la Commissione europea ha pubblicato due studi che hanno quantificato le emissioni di biocarburanti legate all'uso del suolo. In entrambe le occasioni, l’esecutivo Ue ha ammesso “che quando si prendono in considerazione le emissioni previste per il cambiamento indiretto della destinazione del suolo, tutti i biodiesel a base di olio vegetale comportano più emissioni del diesel fossile”. “Il rapporto più recente - si precisa - ha mostrato che le emissioni sono particolarmente elevate per l'olio di palma e di soia, che causano rispettivamente tre e due volte le emissioni del diesel fossile”.
“Una politica che avrebbe dovuto salvare il pianeta in realtà lo sta distruggendo”, è il commento di Laura Buffet, direttrice energetica di T&E. “Gli sforzi per sostituire i combustibili inquinanti come il diesel con i biocarburanti stanno paradossalmente aumentando le emissioni di anidride carbonica che riscaldano il pianeta”, ha concluso Buffet.


GALLERY






#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

Negli ultimi dieci anni, i biocarburanti voluti dall’Ue per rimpiazzare i combustibili fossili hanno causato la scomparsa di un’area totale di foresta pari alla superficie dell’Olanda e hanno emesso fino a tre volte più CO2 rispetto al diesel che hanno sostituito. Queste le conclusioni poco incoraggianti dello studio condotto da Transport & Environment (T&E), un’organizzazione attiva sui temi della mobilità sostenibile. Il documento mette in evidenza, oltre alle scelte discutibili fatte da Bruxelles, quali sono i Paesi che hanno scommesso di più sui carburanti di nuova generazione. Nel 2020, l’Italia è stata la terza produttrice europea di biodiesel, alle spalle di Spagna e Paesi Bassi, e la quarta per consumi.
“Nel 2009 - si ricorda nello studio - è stata introdotta la direttiva Ue sulle energie rinnovabili (Red) per promuovere l’uso” delle fonti alternative a quelle fossili “nel settore dei trasporti”. La norma ha obbligato “gli Stati membri, entro il 2020, a rispettare una quota del 10% di energia rinnovabile nel consumo finale di energia dei trasporti”. Tuttavia, tali regole “hanno trascurato le salvaguardie della sostenibilità e non hanno tenuto conto dell'intero ciclo di vita delle emissioni legate alla catena di approvvigionamento del carburante e all'uso del suolo”. In altre parole, “il consumo della gran parte di biocarburanti” ha portato ad “emissioni complessive di gas serra superiori rispetto ai combustibili fossili”.

Ad esempio, la domanda di biodiesel dell’Ue ha richiesto la coltivazione di 1,1 milioni di ettari di palme nel sud-est asiatico e di 2,9 milioni di ettari di semi di soia in Sud America. Superfici strappate ai preziosi milioni di ettari di foresta, riconvertita alle monocolture necessarie per le produzione dei carburanti. Il documento di T&E ricorda che nel 2012 e nel 2016 la Commissione europea ha pubblicato due studi che hanno quantificato le emissioni di biocarburanti legate all'uso del suolo. In entrambe le occasioni, l’esecutivo Ue ha ammesso “che quando si prendono in considerazione le emissioni previste per il cambiamento indiretto della destinazione del suolo, tutti i biodiesel a base di olio vegetale comportano più emissioni del diesel fossile”. “Il rapporto più recente - si precisa - ha mostrato che le emissioni sono particolarmente elevate per l'olio di palma e di soia, che causano rispettivamente tre e due volte le emissioni del diesel fossile”.
“Una politica che avrebbe dovuto salvare il pianeta in realtà lo sta distruggendo”, è il commento di Laura Buffet, direttrice energetica di T&E. “Gli sforzi per sostituire i combustibili inquinanti come il diesel con i biocarburanti stanno paradossalmente aumentando le emissioni di anidride carbonica che riscaldano il pianeta”, ha concluso Buffet.

GALLERY






fonte: europa.today.it/
#Iscriviti QUI alla #Associazione COORDINAMENTO REGIONALE UMBRIA RIFIUTI ZERO (CRU-RZ)
=> Seguici su Blogger
https://rifiutizeroumbria.blogspot.com
=> Seguici su Facebook
=> Seguici su Facebook
Alessandra Prampolini, Wwf Italia. Per salvare la Terra dobbiamo fermare lo sfruttamento nascosto

Quest’anno il tema della Giornata mondiale della Terra è il ripristino degli ecosistemi. Ne abbiamo parlato con Alessandra Prampolini che, dallo scorso gennaio, è direttrice generale del Wwf Italia, prima donna a ricoprire questa carica nell’associazione. Dal consumo di cibo non più sostenibile all’agricoltura, dall’allevamento fino alla deforestazione, Alessandra Prampolini invita ad analizzare la crisi climatica e quella della biodiversità come fenomeni interconnessi, rispetto ai quali vanno messe in campo azioni integrate e trasversali. In quest’ottica, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che l’Italia si appresta a presentare a Bruxelles costituisce uno snodo fondamentale, perché le modalità con le quali decideremo di declinarlo tracceranno il solco lungo il quale ci muoveremo nei prossimi anni.
In occasione della Giornata mondiale della Terra il Wwf ha lanciato la campagna Food4Future. Qual è il messaggio principale che volete veicolare?
Dobbiamo modificare i sistemi agroalimentari sia dal punto di vista della produzione che da quello del consumo. Per come sono oggi, hanno impatti eccessivi sul pianeta e non sono efficienti: né per quanto riguarda la distribuzione – pensiamo al tema dei rifiuti e a quello della fame nel mondo –né per quanto concerne la salute, perché la gran parte del cibo che produciamo non è salutare. I sistemi agroalimentari vanno rivisti alla luce delle necessità umane e dei limiti del pianeta.
Alessandra Prampolini è direttore generale del Wwf Italia dallo scorso mese di gennaio © Giovanna Quaglieri
Quali sono gli impatti negativi sull’ecosistema di un consumo di cibo poco sostenibile?
Quali sono gli impatti negativi sull’ecosistema di un consumo di cibo poco sostenibile?
Clima e biodiversità sono crisi planetarie che rappresentano due facce della stessa medaglia: l’80 per cento della perdita di biodiversità è causata dall’agricoltura e dall’allevamento, che sono responsabili anche del 24 per cento delle emissioni nocive. C’è poi il grande tema del consumo del suolo: abbiamo già consumato i tre quarti delle terre emerse e la prima causa della deforestazione sono proprio le nuove coltivazioni e l’allevamento, che già occupano il 40 per cento delle terre emerse. Un altro punto importante è quello dei cicli biogeochimici: consumiamo fertilizzanti minerali in numero dieci volte maggiore rispetto a 50 anni fa, e ciò si traduce in inquinamento, degrado del suolo e peggiore qualità delle acque. In proposito, l’uso scorretto della risorsa idrica ha portato a un consumo triplicato in 50 anni dell’acqua destinata all’agricoltura, senza dimenticare che l’80 per cento dei laghi italiani versa in uno stato ecologico non buono.
Abbiamo già consumato i tre quarti delle terre emerse e la prima causa della deforestazione sono proprio le nuove coltivazioni e l’allevamento, che già occupano il 40 per cento delle terre emerse.
Il tema della Giornata della Terra 2021 è il ripristino degli ecosistemi. In proposito, un vostro recente report ha quantificato gli impatti sulla deforestazione legati al commercio internazionale. Cosa emerge in particolare da questo lavoro?
Emerge l’enorme impatto della deforestazione importata, nascosta nelle nostre abitudini di consumo e in quello che mangiamo. Un tempo le foreste si utilizzavano principalmente per realizzare utensili in legno o per il riscaldamento domestico, mentre ora la produzione di soia, olio di palma e carne bovina è la principale responsabile della deforestazione. Il Wwf sta lavorando con l’Unione europea a una proposta legislativa per ridurre l’impronta dei consumi, ponendo limiti all’importazione di prodotti che abbiano origine forestale o che siano legati alla deforestazione. Quella nascosta pesa ormai per l’80 per cento rispetto alla deforestazione in tutto il mondo; l’Europa è seconda solo alla Cina in termini di deforestazione importata, e l’Italia figura al secondo posto in Europa.

La deforestazione dell’Amazzonia brasiliana © Mario Tama/Getty Images
Sempre in riferimento anche al cibo che arriva sulle nostre tavole, stiamo perdendo il prezioso esercito degli insetti impollinatori. Qual è il quadro e quali sono le conseguenze?
Sempre in riferimento anche al cibo che arriva sulle nostre tavole, stiamo perdendo il prezioso esercito degli insetti impollinatori. Qual è il quadro e quali sono le conseguenze?
Si tratta di una delle crisi più drammatiche a livello globale, di un fenomeno che procede a velocità spaventosa e che spesso in passato è stato ignorato. Il numero dei volatori in Europa si è ridotto del 70 per cento negli ultimi 30 anni, e oggi a livello globale il 40 per cento degli insetti più comuni come api selvatiche, farfalle e coleotteri rischiano l’estinzione. Ben l’80 per cento delle 1.400 piante da cui si produce cibo nel mondo richiede l’impollinazione: il venir meno di questo servizio ecosistemico fa crollare le possibilità di portare in tavola alimenti che garantiscono la nostra salute e il nostro sostentamento. La riduzione di cibi legati a una dieta sana come frutta, verdura, noci e semi, aumenta i rischi di diabete e di malattie cardiovascolari; anche perché al contempo si assiste alla crescita di colture alimentari povere di nutrienti come riso, soia, mais e patate.
Tra le principali cause dell’estinzione degli impollinatori ci sono anche i cambiamenti climatici. A livello globale si sta facendo abbastanza per contrastarne gli effetti?
Ancora no, purtroppo. Come Unione europea ci siamo posti l’obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e target progressivi intermedi con orizzonte al 2030. A fronte dell’Accordo di Parigi, manca però l’implementazione di un piano di azione vincolante per i diversi Paesi: gli obiettivi devono essere legati alla riduzione delle emissioni e a un aumento delle energie rinnovabili, e al contempo serve una chiara scansione temporale per il loro raggiungimento. Lo scorso anno non ha aiutato lo slittamento della Cop26 a causa dell’emergenza pandemica, perché avrebbe rappresentato un importante momento di confronto a cinque anni dagli accordi di Parigi.
L’agricoltura intensiva e il dissennato utilizzo di pesticidi hanno causato un allarmante declino degli insetti impollinatori, tra cui le api © Ingimage
Il Wwf ha rimarcato le “enormi prospettive di collaborazione” che esistono tra uomo e natura nel contrasto ai cambiamenti climatici.
Un aumento delle temperature causa una perdita di biodiversità, ma è bene rimarcare che è vero anche il contrario: ci sono tante specie animali che sono preziose alleate nel contrasto al cambiamento climatico. Faccio qualche esempio. Elefanti, gibboni e macachi svolgono un ruolo essenziale per diffondere i semi di molte specie arboree, e in questo modo contribuiscono all’espansione della biodiversità in habitat anche molto diversi fra di loro. In vita, le balene accumulano carbonio nei tessuti e quando muoiono lo depositano sui fondali marini: ogni balena adulta cattura in media 33 tonnellate di CO2. Anche le formiche, con il loro instancabile lavoro, generano una serie di reazioni chimiche che facilitano assorbimento della CO2 da parte del suolo: i suoli abitati da formiche hanno una capacità di assorbimento 300 volte superiore rispetto agli altri.
Il Next Generation Eu può rappresentare una svolta per la transizione ecologica dell’Europa?
Il Wwf ha rimarcato le “enormi prospettive di collaborazione” che esistono tra uomo e natura nel contrasto ai cambiamenti climatici.
Un aumento delle temperature causa una perdita di biodiversità, ma è bene rimarcare che è vero anche il contrario: ci sono tante specie animali che sono preziose alleate nel contrasto al cambiamento climatico. Faccio qualche esempio. Elefanti, gibboni e macachi svolgono un ruolo essenziale per diffondere i semi di molte specie arboree, e in questo modo contribuiscono all’espansione della biodiversità in habitat anche molto diversi fra di loro. In vita, le balene accumulano carbonio nei tessuti e quando muoiono lo depositano sui fondali marini: ogni balena adulta cattura in media 33 tonnellate di CO2. Anche le formiche, con il loro instancabile lavoro, generano una serie di reazioni chimiche che facilitano assorbimento della CO2 da parte del suolo: i suoli abitati da formiche hanno una capacità di assorbimento 300 volte superiore rispetto agli altri.
Il Next Generation Eu può rappresentare una svolta per la transizione ecologica dell’Europa?
Il Next Generation Eu è lo strumento del secolo e le modalità con le quali decideremo di utilizzarlo daranno l’impronta dei prossimi anni. Rappresenta insomma un’occasione unica e come Wwf stiamo chiedendo che l’approccio sia quello della transizione ecologica, a patto che lo sia realmente. Il primo principio è che il valore della natura deve essere, con un approccio trasversale, incorporato in tutti i processi decisionali.
In Italia si avrebbe entro il 2030 la creazione di 163 mila nuovi posti di lavoro grazie alle rinnovabili © Nicholas Doherty, Unsplash
Alessandra Prampolini, il 30 aprile l’Italia dovrà presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza all’Ue, su cosa si dovrebbe puntare con maggiore decisione?
Alessandra Prampolini, il 30 aprile l’Italia dovrà presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza all’Ue, su cosa si dovrebbe puntare con maggiore decisione?
Almeno il 37 per cento delle risorse deve essere destinato in azioni in difesa del clima e a tutela della biodiversità. In secondo luogo, l’azione di rilancio del nostro Paese deve prevedere un rinnovamento della strategia industriale, il cui fine ultimo deve essere la completa decarbonizzazione: ciò potrà avvenire solo con target di riduzione delle emissioni molto chiari e con investimenti massicci sulle energie rinnovabili. Va infine riqualificata la natura: in Italia abbiamo uno dei patrimoni più importanti in Europa, ma anni di consumo incauto di suolo hanno fatto sì che siano sopravvissute piccole isole di biodiversità, non collegate fra di loro, che oltretutto si stanno riducendo. Servono quindi azioni per la tutela, il ripristino e la riconnessione delle tante aree che il nostro Paese ospita: ciò a vantaggio non solo del turismo, ma anche di attività come l’agricoltura e la pesca.
fonte: www.lifegate.it
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Labels:
#AccordoClimaParigi,
#Ambiente,
#Api,
#Biodiversità,
#Clima,
#ConsumoSuolo,
#CrisiEcosistemica,
#Deforestazione,
#Ecosistema,
#Food4Future,
#PianetaTerra,
#PNRR,
#SalvaguardiaAgroalimentare,
#WWF
WWF: l'Amazzonia è a rischio "estinzione"
WWF: "In 10 anni abbiamo perso una superficie di foresta amazzonica pari all’Italia e a luglio 2020, solo nell’Amazzonia brasiliana, gli incendi sono aumentati del 28% rispetto allo stesso periodo del 2019".

Con l’attenzione dell’opinione pubblica concentrata sulla gravissima pandemia provocata dal Covid 19 rischia di passare in secondo piano un’altra grave emergenza, quella dei grandi incendi forestali, oggi sempre più frequenti e che sembrano destinare il 2020 ad una nuova stagione di fiamme e roghi, ancora più lunga e terribile rispetto a quella vissuta lo scorso anno.
A dimostrarlo è il nuovo report "Fuochi, foreste e futuro: Una crisi fuori controllo?" realizzato dal WWF, insieme al Boston Consulting Group (BCG), dove si scopre che già ad aprile, il numero di incendi segnalati in tutto il mondo- dall’Amazzonia all’Australia passando per la Russia - era aumentato del 13% rispetto allo scorso anno. I fattori principali sono il clima sempre più caldo e secco, dovuto al cambiamento climatico, e la deforestazione, quest’ultima causata principalmente dalla conversione dei terreni per l'agricoltura. L'espansione dell'agricoltura, la conversione delle foreste in piantagioni di alberi e in pascoli, la deforestazione illegale, infatti, continuano a guidare la conversione e il degrado degli ecosistemi naturali, aumentando così il rischio di incendi, che per il 75% sono responsabilità dell’uomo.
Ma per l’Amazzonia in particolare questo non sarà solo un altro anno di incendi. Negli ultimi 10 anni, sono stati persi circa 300.000 chilometri quadrati di foresta amazzonica, pari all’intera superficie dell’Italia. Nello steso arco di tempo sono stati tagliati, andati in fumo o degradati oltre 170.000 km quadrati di foresta primaria, quella più preziosa e ricca di biodiversità, la maggior parte della quale in Brasile. Il 2019 è stato l’anno horribilis degli incendi nel mondo, con 12 milioni di ettari (120.000 chilometri quadrati) di foresta amazzonica andati in fumo. Il tasso di deforestazione, però, è ancora in costante aumento nell'Amazzonia brasiliana, dove da agosto 2019 a luglio 2020 è stato registrato un numero di alert superiore del 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Gli ultimi dati, poi, mostrano che nel 2020, gli incendi nell'Amazzonia brasiliana superano di oltre il 52% la media decennale, e di quasi un quarto (del 24%) quelli degli ultimi tre anni. Nel mese di luglio, l'Istituto brasiliano di ricerca spaziale (INPE), ha registrato nella sola Amazzonia brasiliana, un aumento del 28% del numero di incendi rispetto allo stesso periodo del 2019 (6.803 incendi registrati rispetto ai 5.318 roghi di luglio 2019), principalmente causati dall'impennata dei livelli di deforestazione illegale.
La foresta ridotta e degradata è più soggetta ad incendi, alla perdita di biodiversità e perde la capacità di fornirci quei servizi irrinunciabili che ci fornisce. La foresta amazzonica genera infatti piogge, raffredda la Terra, assorbe gas serra, immagazzina carbonio, custodisce il 10% della biodiversità mondiale, contrasta la desertificazione, produce acqua, cibo e medicine; oltre a custodire ancora comunità indigene senza le quali, spesso, molte aree della foresta amazzonia non sarebbero protette e custodite.
Il WWF chiede l'attuazione di misure urgenti per far fronte all’emergenza e che fra queste venga immediatamente realizzata una conferenza internazionale per proteggere la foresta Amazzonica, bene imprescindibile dell’umanità.
fonte: www.greencity.it
RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Con l’attenzione dell’opinione pubblica concentrata sulla gravissima pandemia provocata dal Covid 19 rischia di passare in secondo piano un’altra grave emergenza, quella dei grandi incendi forestali, oggi sempre più frequenti e che sembrano destinare il 2020 ad una nuova stagione di fiamme e roghi, ancora più lunga e terribile rispetto a quella vissuta lo scorso anno.
A dimostrarlo è il nuovo report "Fuochi, foreste e futuro: Una crisi fuori controllo?" realizzato dal WWF, insieme al Boston Consulting Group (BCG), dove si scopre che già ad aprile, il numero di incendi segnalati in tutto il mondo- dall’Amazzonia all’Australia passando per la Russia - era aumentato del 13% rispetto allo scorso anno. I fattori principali sono il clima sempre più caldo e secco, dovuto al cambiamento climatico, e la deforestazione, quest’ultima causata principalmente dalla conversione dei terreni per l'agricoltura. L'espansione dell'agricoltura, la conversione delle foreste in piantagioni di alberi e in pascoli, la deforestazione illegale, infatti, continuano a guidare la conversione e il degrado degli ecosistemi naturali, aumentando così il rischio di incendi, che per il 75% sono responsabilità dell’uomo.
Ma per l’Amazzonia in particolare questo non sarà solo un altro anno di incendi. Negli ultimi 10 anni, sono stati persi circa 300.000 chilometri quadrati di foresta amazzonica, pari all’intera superficie dell’Italia. Nello steso arco di tempo sono stati tagliati, andati in fumo o degradati oltre 170.000 km quadrati di foresta primaria, quella più preziosa e ricca di biodiversità, la maggior parte della quale in Brasile. Il 2019 è stato l’anno horribilis degli incendi nel mondo, con 12 milioni di ettari (120.000 chilometri quadrati) di foresta amazzonica andati in fumo. Il tasso di deforestazione, però, è ancora in costante aumento nell'Amazzonia brasiliana, dove da agosto 2019 a luglio 2020 è stato registrato un numero di alert superiore del 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Gli ultimi dati, poi, mostrano che nel 2020, gli incendi nell'Amazzonia brasiliana superano di oltre il 52% la media decennale, e di quasi un quarto (del 24%) quelli degli ultimi tre anni. Nel mese di luglio, l'Istituto brasiliano di ricerca spaziale (INPE), ha registrato nella sola Amazzonia brasiliana, un aumento del 28% del numero di incendi rispetto allo stesso periodo del 2019 (6.803 incendi registrati rispetto ai 5.318 roghi di luglio 2019), principalmente causati dall'impennata dei livelli di deforestazione illegale.
La foresta ridotta e degradata è più soggetta ad incendi, alla perdita di biodiversità e perde la capacità di fornirci quei servizi irrinunciabili che ci fornisce. La foresta amazzonica genera infatti piogge, raffredda la Terra, assorbe gas serra, immagazzina carbonio, custodisce il 10% della biodiversità mondiale, contrasta la desertificazione, produce acqua, cibo e medicine; oltre a custodire ancora comunità indigene senza le quali, spesso, molte aree della foresta amazzonia non sarebbero protette e custodite.
Il WWF chiede l'attuazione di misure urgenti per far fronte all’emergenza e che fra queste venga immediatamente realizzata una conferenza internazionale per proteggere la foresta Amazzonica, bene imprescindibile dell’umanità.
fonte: www.greencity.it
RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Proteggere la biodiversità per prevenire la prossima pandemia. E costerebbe molto meno
Basterebbe un investimento annuale di 30 miliardi di dollari per la prevenzione di futuri focolai, quanto l'1 - 2% della spesa militare annuale dei 10 Paesi più ricchi del mondo

Finora, la pandemia di Covid-19 è costata all’economia mondiale almeno 2,6 trilioni di dollari e alla fine – mentre sta dilagando nei Paesi in via di sviluppo – potrebbe costare 10 volte di più. Quanto costerebbe evitare che tutto questo accada di nuovo? E quali sono le principali azioni che devono essere intraprese per riuscirci? A queste domande hanno cercato di rispondere Andrew Dobson, professore di ecologia e biologia evoluzionistica alla Princeton University e Stuart Pimm della Duke University e per farlo hanno messo insieme un team multidisciplinare di epidemiologi, biologi delle malattie della fauna selvatica, professionisti della conservazione, ecologi ed economisti che ora scritto su Science – Policy Forum l’articolo “Ecology and economics for pandemic prevention” nel quale si sostiene che una nuova pandemia zoonotica potrebbe essere evitata con «un investimento annuale di 30 miliardi di dollari che si ripagherà rapidamente».
Pimm ricorda che «Fino ad ora, ci sono stati almeno altri 4 agenti patogeni virali che sono emersi nella popolazione umana in questo secolo. In futuro, gli investimenti nella prevenzione potrebbero essere la migliore polizza assicurativa per la salute umana e l’economia globale».
Le principali cause della possibile e incombente diffusione dei patogeni emergenti sono la distruzione delle foreste tropicali e il commercio della fauna selvatica. Alla Princeton evidenziano che «Ciascuna ha contribuito a due delle quattro malattie emergenti che sono comparse negli ultimi 50 anni: Covid, Ebola, SARS, HIV. Sia la deforestazione che il commercio di animali selvatici causano anche danni diffusi all’ambiente su più fronti, quindi ci sono diversi benefici associati alla loro riduzione. L’aumento del monitoraggio e della sorveglianza di queste attività consentirebbe di rilevare i futuri virus emergenti in una fase molto precoce, quando il controllo potrebbe impedire un’ulteriore diffusione».
Tutte le prove genetiche credibili indicano che il Covid-19 sta emergendo da una specie di pipistrello commercializzata come cibo in Cina e i ricercatori sottolineano che «Il commercio di animali selvatici è una componente importante dell’economia globale, interessando i principali prodotti economici tra cui cibo, medicine, animali domestici, abbigliamento e mobili. Alcuni di questi vengono scambiati come beni di lusso, il che può creare un’associazione stretta che aumenta il rischio di trasmissione di agenti patogeni dal commerciante o all’acquirente. I mercati della fauna selvatica sono invariabilmente mal regolati e antigienici».
Di fronte a questa rete globale e a questi rischi crescenti, la Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES), ha un bilancio globale netto di appena 6 milioni di dollari e Dobson fa notare che «Molti dei 183 firmatari hanno arretrati di diversi anni per i loro pagamenti».
Invece, gli autori dell’articolo sostengono che «Il monitoraggio di questo commercio deve essere ampliato. In particolare, gli scienziati hanno bisogno di informazioni vitali sui patogeni virali che circolano nelle specie potenzialmente da cibo o da compagnia» e, per monitorare la salute degli animali, suggeriscono di «utilizzare gruppi di monitoraggio regionali e nazionali del commercio di specie selvatiche, integrati con le organizzazioni internazionali.Il monitoraggio e la regolamentazione di questo commercio non solo garantiranno una protezione più forte per le molte specie minacciate dal commercio, ma creeranno anche un archivio ampiamente accessibile di campioni genetici che possono essere utilizzati per identificare nuovi agenti patogeni quando emergono. Produrrà anche una libreria genetica di virus con due ruoli chiave: identificare più rapidamente l’origine e la posizione dei futuri patogeni emergenti e sviluppare i test necessari per monitorare i futuri focolai. In definitiva, questa biblioteca conterrà le informazioni necessarie per accelerare lo sviluppo di futuri vaccini».
Sebbene continuino gli appelli a chiudere i “mercati umidi” nei quali vengono venduti animali selvatici e domestici, per prevenire futuri focolai di agenti patogeni emergenti, il team di scienziati riconosce che «molte persone dipendono da alimenti e medicine di provenienza selvatica» e suggeriscono che sarebbe meglio chiedere una migliore sorveglianza sanitaria dei mercati nazionali: «Se più persone vengono formate per il monitoraggio, il rischio che emergano nuovi virus può essere mitigato con l’individuazione precoce e il controllo dei patogeni nel commercio di specie selvatiche e lavorando con le comunità locali per ridurre al minimo i rischi di esposizione e trasmissione».
Uno degli autori dell’articolo, Binbin Li dela Duke Kunshan University di Jiangsu, spiega che «In Cina, ad esempio, ci sono troppo pochi veterinari per la fauna selvatica e la maggior parte lavora in zoo e cliniche per animali. I veterinari sono in prima linea nella difesa contro i patogeni emergenti e nel mondo abbiamo un disperato bisogno di più persone formate con queste capacità».
Secondo il team di Dobson e Pimm, estendere e sviluppare modi migliori per monitorare e regolamentare il commercio della fauna selvatica potrebbe essere fatto per circa 500 milioni di dollari all’anno, «Un costo insignificante rispetto agli attuali costi del Covid, soprattutto se si considerano vantaggi aggiuntivi come frenare il consumo di fauna selvatica e sostenere la biodiversità».
Il rallentamento della deforestazione tropicale rallenterebbe anche l’emergenza virale, inoltre ridurrebbe l’apporto di carbonio nell’atmosfera proveniente dagli incendi boschivi e proteggerebbe la biodiversità forestale. D’altra parte, riduce i ricavi provenienti da legname, pascolo e agricoltura. Vale la pena rinunciare a questi benefici tangibili, ma f economicamente concentrati? Gli autori affrontano questa parte della loro analisi costi-benefici da due prospettive economiche complementari: prima ignorando e poi includendo i benefici del carbonio stoccato come copertura assicurativa contro i cambiamenti climatici e non facendo alcun tentativo di valorizzare la perdita di biodiversità.
L’articolo su Science – Policy Forum si concentra soprattutto sui costi pubblici necessari per prevenire la prossma pandemia tipo Covid-19.
Un altro autore, l’epidemiologo di Ecohealth Alliance Peter Daszak, richiama i risultati di numerosi studi: «L’emergenza per agenti patogeni è essenzialmente un evento regolare quanto le elezioni nazionali: una volta ogni quattro o cinque anni». Amy Ando, che insegna economia agricola e dei consumi all’università dell’Illinois-Urbana Champaign, aggiunge: «I nuovi agenti patogeni sono apparsi all’incirca allo stesso ritmo di nuovi presidenti, deputati, senatori e primi ministri! Potremmo vedere i costi del Covid salire da oltre 8 a 15 trilioni di dollari, con molti milioni di persone disoccupate e che vivono in lockdown».
Il costo annuale per la prevenzione di futuri focolai è paragonabile approssimativamente all’1-2% della spesa militare annuale dei 10 paesi più ricchi del mondo. Dobson conclude: «Se consideriamo la continua battaglia contro gli agenti patogeni emergenti come il Covid-19 come una guerra che tutti dobbiamo vincere, l’investimento nella prevenzione sembra avere un valore eccezionale».
Ma evidentemente una parte dell’umanità preferisce armarsi e spararsi che salvare sé stessa e la biodiversità del pianeta.
fonte: www.greenreport.it
#RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Finora, la pandemia di Covid-19 è costata all’economia mondiale almeno 2,6 trilioni di dollari e alla fine – mentre sta dilagando nei Paesi in via di sviluppo – potrebbe costare 10 volte di più. Quanto costerebbe evitare che tutto questo accada di nuovo? E quali sono le principali azioni che devono essere intraprese per riuscirci? A queste domande hanno cercato di rispondere Andrew Dobson, professore di ecologia e biologia evoluzionistica alla Princeton University e Stuart Pimm della Duke University e per farlo hanno messo insieme un team multidisciplinare di epidemiologi, biologi delle malattie della fauna selvatica, professionisti della conservazione, ecologi ed economisti che ora scritto su Science – Policy Forum l’articolo “Ecology and economics for pandemic prevention” nel quale si sostiene che una nuova pandemia zoonotica potrebbe essere evitata con «un investimento annuale di 30 miliardi di dollari che si ripagherà rapidamente».
Pimm ricorda che «Fino ad ora, ci sono stati almeno altri 4 agenti patogeni virali che sono emersi nella popolazione umana in questo secolo. In futuro, gli investimenti nella prevenzione potrebbero essere la migliore polizza assicurativa per la salute umana e l’economia globale».
Le principali cause della possibile e incombente diffusione dei patogeni emergenti sono la distruzione delle foreste tropicali e il commercio della fauna selvatica. Alla Princeton evidenziano che «Ciascuna ha contribuito a due delle quattro malattie emergenti che sono comparse negli ultimi 50 anni: Covid, Ebola, SARS, HIV. Sia la deforestazione che il commercio di animali selvatici causano anche danni diffusi all’ambiente su più fronti, quindi ci sono diversi benefici associati alla loro riduzione. L’aumento del monitoraggio e della sorveglianza di queste attività consentirebbe di rilevare i futuri virus emergenti in una fase molto precoce, quando il controllo potrebbe impedire un’ulteriore diffusione».
Tutte le prove genetiche credibili indicano che il Covid-19 sta emergendo da una specie di pipistrello commercializzata come cibo in Cina e i ricercatori sottolineano che «Il commercio di animali selvatici è una componente importante dell’economia globale, interessando i principali prodotti economici tra cui cibo, medicine, animali domestici, abbigliamento e mobili. Alcuni di questi vengono scambiati come beni di lusso, il che può creare un’associazione stretta che aumenta il rischio di trasmissione di agenti patogeni dal commerciante o all’acquirente. I mercati della fauna selvatica sono invariabilmente mal regolati e antigienici».
Di fronte a questa rete globale e a questi rischi crescenti, la Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES), ha un bilancio globale netto di appena 6 milioni di dollari e Dobson fa notare che «Molti dei 183 firmatari hanno arretrati di diversi anni per i loro pagamenti».
Invece, gli autori dell’articolo sostengono che «Il monitoraggio di questo commercio deve essere ampliato. In particolare, gli scienziati hanno bisogno di informazioni vitali sui patogeni virali che circolano nelle specie potenzialmente da cibo o da compagnia» e, per monitorare la salute degli animali, suggeriscono di «utilizzare gruppi di monitoraggio regionali e nazionali del commercio di specie selvatiche, integrati con le organizzazioni internazionali.Il monitoraggio e la regolamentazione di questo commercio non solo garantiranno una protezione più forte per le molte specie minacciate dal commercio, ma creeranno anche un archivio ampiamente accessibile di campioni genetici che possono essere utilizzati per identificare nuovi agenti patogeni quando emergono. Produrrà anche una libreria genetica di virus con due ruoli chiave: identificare più rapidamente l’origine e la posizione dei futuri patogeni emergenti e sviluppare i test necessari per monitorare i futuri focolai. In definitiva, questa biblioteca conterrà le informazioni necessarie per accelerare lo sviluppo di futuri vaccini».
Sebbene continuino gli appelli a chiudere i “mercati umidi” nei quali vengono venduti animali selvatici e domestici, per prevenire futuri focolai di agenti patogeni emergenti, il team di scienziati riconosce che «molte persone dipendono da alimenti e medicine di provenienza selvatica» e suggeriscono che sarebbe meglio chiedere una migliore sorveglianza sanitaria dei mercati nazionali: «Se più persone vengono formate per il monitoraggio, il rischio che emergano nuovi virus può essere mitigato con l’individuazione precoce e il controllo dei patogeni nel commercio di specie selvatiche e lavorando con le comunità locali per ridurre al minimo i rischi di esposizione e trasmissione».
Uno degli autori dell’articolo, Binbin Li dela Duke Kunshan University di Jiangsu, spiega che «In Cina, ad esempio, ci sono troppo pochi veterinari per la fauna selvatica e la maggior parte lavora in zoo e cliniche per animali. I veterinari sono in prima linea nella difesa contro i patogeni emergenti e nel mondo abbiamo un disperato bisogno di più persone formate con queste capacità».
Secondo il team di Dobson e Pimm, estendere e sviluppare modi migliori per monitorare e regolamentare il commercio della fauna selvatica potrebbe essere fatto per circa 500 milioni di dollari all’anno, «Un costo insignificante rispetto agli attuali costi del Covid, soprattutto se si considerano vantaggi aggiuntivi come frenare il consumo di fauna selvatica e sostenere la biodiversità».
Il rallentamento della deforestazione tropicale rallenterebbe anche l’emergenza virale, inoltre ridurrebbe l’apporto di carbonio nell’atmosfera proveniente dagli incendi boschivi e proteggerebbe la biodiversità forestale. D’altra parte, riduce i ricavi provenienti da legname, pascolo e agricoltura. Vale la pena rinunciare a questi benefici tangibili, ma f economicamente concentrati? Gli autori affrontano questa parte della loro analisi costi-benefici da due prospettive economiche complementari: prima ignorando e poi includendo i benefici del carbonio stoccato come copertura assicurativa contro i cambiamenti climatici e non facendo alcun tentativo di valorizzare la perdita di biodiversità.
L’articolo su Science – Policy Forum si concentra soprattutto sui costi pubblici necessari per prevenire la prossma pandemia tipo Covid-19.
Un altro autore, l’epidemiologo di Ecohealth Alliance Peter Daszak, richiama i risultati di numerosi studi: «L’emergenza per agenti patogeni è essenzialmente un evento regolare quanto le elezioni nazionali: una volta ogni quattro o cinque anni». Amy Ando, che insegna economia agricola e dei consumi all’università dell’Illinois-Urbana Champaign, aggiunge: «I nuovi agenti patogeni sono apparsi all’incirca allo stesso ritmo di nuovi presidenti, deputati, senatori e primi ministri! Potremmo vedere i costi del Covid salire da oltre 8 a 15 trilioni di dollari, con molti milioni di persone disoccupate e che vivono in lockdown».
Il costo annuale per la prevenzione di futuri focolai è paragonabile approssimativamente all’1-2% della spesa militare annuale dei 10 paesi più ricchi del mondo. Dobson conclude: «Se consideriamo la continua battaglia contro gli agenti patogeni emergenti come il Covid-19 come una guerra che tutti dobbiamo vincere, l’investimento nella prevenzione sembra avere un valore eccezionale».
Ma evidentemente una parte dell’umanità preferisce armarsi e spararsi che salvare sé stessa e la biodiversità del pianeta.
fonte: www.greenreport.it
#RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Nel 2019 abbiamo perso un’area di foreste primarie grande come la Svizzera
Il rapporto annuale di Global forest watch illustra le gravi perdite patite nel 2019 dalle foreste di tutto il mondo. A partire da quelle del Brasile.

Nel corso del 2019 le attività umane e gli incendi hanno provocato la distruzione di 38mila chilometri quadrati di foreste vergini, ovvero considerate incontaminate. Per tradurre le cifre in termini più comprensibili, il rapporto annuale dell’organizzazione non governativa Global forest watch ha spiegato che abbiamo perso l’equivalente di un campo di calcio ogni sei secondi. Ovvero un’area grande come la Svizzera. Il che fa dello scorso anno il terzo più negativo di sempre in termini di perdita di foreste primarie nel corso degli ultimi due decenni.
Le perdite più gravi in Brasile e nella Repubblica Democratica del Congo
Il documento è stato pubblicato il 2 giugno scorso e sottolinea come più di un terzo delle foreste distrutte sia concentrato in un’unica nazione: il Brasile. Al secondo e al terzo posto figurano invece la Repubblica Democratica del Congo e l’Indonesia. Seguono poi Perù, Malesia, Colombia, Laos, Messico e Cambogia.
“Un tasso di perdita così elevato è molto preoccupante e arriva in barba agli sforzi condotti da diversi paesi e aziende al fine di ridurre la deforestazione”, ha spiegato Mikaela Weisse, direttrice di Global forest watch, il cui lavoro è stato condotto per conto del think tank americano World resources institute (Wri).

In termini di peggioramento anno su anno, invece, la nazione che presenta i dati più allarmanti è la Bolivia. Il paese latinoamericano ha infatti visto aumentare il tasso di deforestazione dell’80 per cento rispetto al 2018. Ciò in particolare a causa degli incendi, degli allevamenti e della coltura intensiva di soia. Al contrario, in Indonesia si è registrato un calo del 5 per cento (ma i numeri complessivi restano preoccupanti).
Occorreranno decenni, se non secoli, per rigenerare le foreste
Se si considera tuttavia la superficie totale di foreste distrutte, i dati, rispetto a quelle primarie, vanno triplicati. Raggiungendo i 119mila chilometri quadrati. L’attenzione è tuttavia concentrata proprio sulle foreste vergini, in quanto particolarmente preziose, non soltanto per la quantità di biodiversità che ospitano, ma anche per il contributo che garantiscono in termini di assorbimento della CO2 dispersa nel mondo a causa delle attività antropiche. Ad inquietare inoltre è il fatto che gli effetti della deforestazione peseranno a lungo sul Pianeta: “Occorreranno dei decenni, se non dei secoli, prima che tali aree possano tornare al loro stato di origine”, ha aggiunto Mikaela Weisse.
A causare la distruzione delle foreste sono stati in particolare gli incendi. Quelli che hanno devastato il Brasile hanno riempito le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, per via della loro vastità. Ma a quelle legate ai roghi, è probabile che nel 2020 possano aggiungersi altre minacce.
I rischi legati alla ripresa economica post-coronavirus
Il governo guidato dall’ultra-conservatore Jair Bolsonaro ha deciso infatti di rendere più facili le estrazioni minerarie, petrolifere e di gas in aree protette. Così come la conversione di zone boschive in aree adibite ad agricoltura intensiva. Ciò attraverso un progetto di legge approvato a febbraio e che probabilmente peserà fortemente sull’anno in corso.
Non a caso, l’8 maggio scorso l’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe), aveva indicato che nei primi quattro mesi del 2020 sono stati rasi al suolo 1.202 chilometri quadrati di foresta. Il 55 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Prendendo inoltre in considerazione unicamente l’area disboscata nel mese di aprile di quest’anno, pari a circa 405 chilometri quadrati, l’incremento rispetto allo stesso periodo del 2019 è stato del 64 per cento.

Come se non bastasse, poi, la pandemia di Covid-19 potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. “Dal mondo intero ci arriva l’eco di un aumento dello sfruttamento delle aree ricoperte da foreste – spiega Frances Seymour, del Wri -, anche per progetti minerari illegali”. Il rischio è che la necessità di riavviare le economie prevalga anche sulla salvaguardia dei territori. Il che conferma che il mondo è ad un bivio: o scegliere la strada della ripresa ad ogni costo o scegliere una svolta sostenibile. Mai come oggi il destino delle generazioni future è nelle nostre mani.
fonte: www.lifegate.it
#RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Nel corso del 2019 le attività umane e gli incendi hanno provocato la distruzione di 38mila chilometri quadrati di foreste vergini, ovvero considerate incontaminate. Per tradurre le cifre in termini più comprensibili, il rapporto annuale dell’organizzazione non governativa Global forest watch ha spiegato che abbiamo perso l’equivalente di un campo di calcio ogni sei secondi. Ovvero un’area grande come la Svizzera. Il che fa dello scorso anno il terzo più negativo di sempre in termini di perdita di foreste primarie nel corso degli ultimi due decenni.
Le perdite più gravi in Brasile e nella Repubblica Democratica del Congo
Il documento è stato pubblicato il 2 giugno scorso e sottolinea come più di un terzo delle foreste distrutte sia concentrato in un’unica nazione: il Brasile. Al secondo e al terzo posto figurano invece la Repubblica Democratica del Congo e l’Indonesia. Seguono poi Perù, Malesia, Colombia, Laos, Messico e Cambogia.
“Un tasso di perdita così elevato è molto preoccupante e arriva in barba agli sforzi condotti da diversi paesi e aziende al fine di ridurre la deforestazione”, ha spiegato Mikaela Weisse, direttrice di Global forest watch, il cui lavoro è stato condotto per conto del think tank americano World resources institute (Wri).

In termini di peggioramento anno su anno, invece, la nazione che presenta i dati più allarmanti è la Bolivia. Il paese latinoamericano ha infatti visto aumentare il tasso di deforestazione dell’80 per cento rispetto al 2018. Ciò in particolare a causa degli incendi, degli allevamenti e della coltura intensiva di soia. Al contrario, in Indonesia si è registrato un calo del 5 per cento (ma i numeri complessivi restano preoccupanti).
Occorreranno decenni, se non secoli, per rigenerare le foreste
Se si considera tuttavia la superficie totale di foreste distrutte, i dati, rispetto a quelle primarie, vanno triplicati. Raggiungendo i 119mila chilometri quadrati. L’attenzione è tuttavia concentrata proprio sulle foreste vergini, in quanto particolarmente preziose, non soltanto per la quantità di biodiversità che ospitano, ma anche per il contributo che garantiscono in termini di assorbimento della CO2 dispersa nel mondo a causa delle attività antropiche. Ad inquietare inoltre è il fatto che gli effetti della deforestazione peseranno a lungo sul Pianeta: “Occorreranno dei decenni, se non dei secoli, prima che tali aree possano tornare al loro stato di origine”, ha aggiunto Mikaela Weisse.
A causare la distruzione delle foreste sono stati in particolare gli incendi. Quelli che hanno devastato il Brasile hanno riempito le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, per via della loro vastità. Ma a quelle legate ai roghi, è probabile che nel 2020 possano aggiungersi altre minacce.
I rischi legati alla ripresa economica post-coronavirus
Il governo guidato dall’ultra-conservatore Jair Bolsonaro ha deciso infatti di rendere più facili le estrazioni minerarie, petrolifere e di gas in aree protette. Così come la conversione di zone boschive in aree adibite ad agricoltura intensiva. Ciò attraverso un progetto di legge approvato a febbraio e che probabilmente peserà fortemente sull’anno in corso.
Non a caso, l’8 maggio scorso l’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe), aveva indicato che nei primi quattro mesi del 2020 sono stati rasi al suolo 1.202 chilometri quadrati di foresta. Il 55 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Prendendo inoltre in considerazione unicamente l’area disboscata nel mese di aprile di quest’anno, pari a circa 405 chilometri quadrati, l’incremento rispetto allo stesso periodo del 2019 è stato del 64 per cento.

Come se non bastasse, poi, la pandemia di Covid-19 potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. “Dal mondo intero ci arriva l’eco di un aumento dello sfruttamento delle aree ricoperte da foreste – spiega Frances Seymour, del Wri -, anche per progetti minerari illegali”. Il rischio è che la necessità di riavviare le economie prevalga anche sulla salvaguardia dei territori. Il che conferma che il mondo è ad un bivio: o scegliere la strada della ripresa ad ogni costo o scegliere una svolta sostenibile. Mai come oggi il destino delle generazioni future è nelle nostre mani.
fonte: www.lifegate.it
#RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Il WWF: «Con i cambiamenti climatici, i virus diventano più pericolosi»
Esiste un legame strettissimo tra le malattie che stanno terrorizzando il Pianeta e le dimensioni epocali della perdita di natura». A dar l’allarme il WWF, che nei giorni scorsi ha pubblicato un report illustrato — «L’effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi» — in cui viene analizzata la stretta correlazione tra l’insorgenza di nuove pandemie e un eccesso di antropizzazione dell’Ambiente naturale. Chiaro il messaggio: virus e batteri, alla base delle più importanti pandemie dell’ultimo ventennio, erano al principio innocui, fino a quando la selvaggia distruzione degli ecosistemi ne ha aumentato la pericolosità e – complice la globalizzazione – la diffusione. Alla base di questa affermazione, spiega ancora il recentissimo report del World Wide Fund for Nature, ci son diversi fattori: l’urbanizzazione massiccia delle città, la deforestazione, l’estensione delle zone di caccia, il commercio di specie selvatiche e il cambiamento climatico. «Tout Se Tient, cioè ogni cosa è collegata a tutte le altre — interviene Grazia Francescato, ex presidente di WWF Italia e dei Verdi —, lo dice il primo comandamento dell’ecologia. Cambiamento climatico ed epidemie non conoscono confini».
«La distruzione degli ecosistemi è la vera minaccia, perché c’è un legame tra quello che facciamo alla natura e l’insorgere di pandemie». Ne aveva sottolineato i rischi anche una ricerca de La Sapienza nel febbraio 2019
Per questo, spiegano gli ambientalisti «sarebbe criminale non mettersi già oggi al lavoro per fermare il surriscaldamento globale: con un pianeta più caldo potrebbero presentarsi malattie anche peggiori del Coronavirus». A gettar luce sulle conseguenze delle attività umane nella formazione di epidemie/pandemia, ci aveva già pensato un recente studio dell’Università La Sapienza di Roma. La ricerca, condotta a febbraio 2019 col coordinamento del prof. Moreno di Marco, ha confermato ciò che già si sospettava: cioè, che il rischio di insorgenza di pandemie non deriva tanto dalla presenza di aree naturali o di animali selvatici, quanto dalle modalità in cui le attività antropiche influiscono su queste aree e su queste specie. Da qui, l’appello a un nuovo modello di crescita sostenibile, che tenga conto delle necessità del Pianeta. «Non si può dire con certezza, per ora, quale tipo di legame ci sia tra coronavirus e climate change — riprende Francescato —. Ma che ci sia una interconnessione tra cambiamento climatico e diffusione delle malattie infettive non è un mistero: da anni, numerosi rapporti di esperti internazionali lo denunciano».
La mancanza di coscienza ecologica costa cara: in Cina ha causato un deficit commerciale di 7 miliardi e un significativo crollo dell’export. A lungo termine, conterà sempre più investire nella tutela degli ecosistemi
In un’intervista alla rivista Vita, Francescato ha ricordato che «recentemente Giuseppe Miserotti, membro dell’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE), ha evidenziato come i picchi delle epidemie diventate più famose, come per esempio la SARS e l’influenza Aviaria nel 2003 e l’influenza Suina nel 2009, si siano verificati in corrispondenza di picchi di temperature di almeno 0,6 o 0,7 gradi oltre la media. Viste le temperature elevate degli ultimi periodi non c’è da stare sereni». E i picchi di temperature sono strettamente connessi con l’effetto serra alimentato dalle attività umane. Ad oggi il 75% dell’ambiente terrestre e circa il 66% di quello marino sono stati modificati in modo significativo dall’Uomo, ricorda la World Wildlife Foundation, mentre la popolazione umana è raddoppiata negli ultimi cinquant’anni. La mancanza di coscienza ecologica costa cara anche all’economia mondiale. Alla sola Repubblica Popolare Cinese, il Covid-19, che ha avuto come primo focolaio la città industriale di Wuhan (nell’Hubei), ha causato un deficit commerciale di 7 miliardi e un significativo crollo delle esportazioni. Investire nella tutela degli ecosistemi, quindi, si rivela un’azione fruttuosa a lungo termine.
Ilaria capua: «Covid-19 è figlio del traffico aereo ma non solo». La vita degli uomini nelle città con periferie sovraffollate e degradate crea habitat ideali per la diffusione dei virus
«Covid-19 è figlio del traffico aereo ma non solo: le megalopoli che invadono territori e devastano ecosistemi creando situazioni di grande disequilibrio nel rapporto uomo-animale», ha scritto la virologa Ilaria Capua sul Corriere della Sera. Le città occupano solo il 3% della superficie del pianeta, ma ospitano quasi il 60% della popolazione mondiale, che consuma il 75% delle risorse naturali. Molte di queste città, sovrappopolate, chiosa lo studio del WWF, versano in condizioni igieniche precarie. «Le periferie degradate e senza verde di tante metropoli tropicali si trasformano nell’habitat ideale per malattie pericolose». I mercati delle metropoli, specialmente in Africa e Asia, che incontrano un’alta domanda della popolazione, spacciano spesso tutta la fauna predata: animali selvatici vivi, scimmie e tigri, serpenti, pangolini, pipistrelli (da cui avrebbe avuto origine il successivo spill-over del SARS-CoV-2 all’Uomo) favorendo conosciute e sconosciute zoonosi. A condire il tutto, c’è il Climate Change perché, spiegano dal WWF, «tutti i virus e i batteri prediligono l’umidità delle nuove condizioni climatiche».
Perché la minaccia al Pianeta ci fa meno paura
Perché allora non aggredire il problema, in via cautelativa, con misure drastiche quanto quelle prese per fronteggiare l’emergenza da nuovo Coronavirus? «La differenza è nel tempo. Il fenomeno del climate change — con il surriscaldamento globale, lo scioglimento die ghiacci artici, l’espansione termica degli Oceani — ha tempi più lenti del Coronavirus che invece in breve ha raggiunto una fase acuta che tocca direttamente la salute delle persone. Il Coronavirus viene percepito come una emergenza immediata, non procrastinabile, nei cui confronti bisogna prendere delle misure urgenti». Per quanto riguarda il fenomeno dei cambiamenti che minacciano il Pianeta, invece, «la percezione è quella di avere ancora tempo per intervenire, anche se non è detto che il tempo a disposizione sia ancora molto», sostiene Anna Oliverio Ferraris, già ordinario di Psicologia all’Università La Sapienza di Roma e autrice del libro Psicologia della paura (Bollati Boringhieri). Insomma: è tutta questione di tempo. E chi lo ha, non lo aspetti.
fonte: www.corriere.it
«La distruzione degli ecosistemi è la vera minaccia, perché c’è un legame tra quello che facciamo alla natura e l’insorgere di pandemie». Ne aveva sottolineato i rischi anche una ricerca de La Sapienza nel febbraio 2019
Per questo, spiegano gli ambientalisti «sarebbe criminale non mettersi già oggi al lavoro per fermare il surriscaldamento globale: con un pianeta più caldo potrebbero presentarsi malattie anche peggiori del Coronavirus». A gettar luce sulle conseguenze delle attività umane nella formazione di epidemie/pandemia, ci aveva già pensato un recente studio dell’Università La Sapienza di Roma. La ricerca, condotta a febbraio 2019 col coordinamento del prof. Moreno di Marco, ha confermato ciò che già si sospettava: cioè, che il rischio di insorgenza di pandemie non deriva tanto dalla presenza di aree naturali o di animali selvatici, quanto dalle modalità in cui le attività antropiche influiscono su queste aree e su queste specie. Da qui, l’appello a un nuovo modello di crescita sostenibile, che tenga conto delle necessità del Pianeta. «Non si può dire con certezza, per ora, quale tipo di legame ci sia tra coronavirus e climate change — riprende Francescato —. Ma che ci sia una interconnessione tra cambiamento climatico e diffusione delle malattie infettive non è un mistero: da anni, numerosi rapporti di esperti internazionali lo denunciano».
La mancanza di coscienza ecologica costa cara: in Cina ha causato un deficit commerciale di 7 miliardi e un significativo crollo dell’export. A lungo termine, conterà sempre più investire nella tutela degli ecosistemi
In un’intervista alla rivista Vita, Francescato ha ricordato che «recentemente Giuseppe Miserotti, membro dell’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE), ha evidenziato come i picchi delle epidemie diventate più famose, come per esempio la SARS e l’influenza Aviaria nel 2003 e l’influenza Suina nel 2009, si siano verificati in corrispondenza di picchi di temperature di almeno 0,6 o 0,7 gradi oltre la media. Viste le temperature elevate degli ultimi periodi non c’è da stare sereni». E i picchi di temperature sono strettamente connessi con l’effetto serra alimentato dalle attività umane. Ad oggi il 75% dell’ambiente terrestre e circa il 66% di quello marino sono stati modificati in modo significativo dall’Uomo, ricorda la World Wildlife Foundation, mentre la popolazione umana è raddoppiata negli ultimi cinquant’anni. La mancanza di coscienza ecologica costa cara anche all’economia mondiale. Alla sola Repubblica Popolare Cinese, il Covid-19, che ha avuto come primo focolaio la città industriale di Wuhan (nell’Hubei), ha causato un deficit commerciale di 7 miliardi e un significativo crollo delle esportazioni. Investire nella tutela degli ecosistemi, quindi, si rivela un’azione fruttuosa a lungo termine.
Ilaria capua: «Covid-19 è figlio del traffico aereo ma non solo». La vita degli uomini nelle città con periferie sovraffollate e degradate crea habitat ideali per la diffusione dei virus
«Covid-19 è figlio del traffico aereo ma non solo: le megalopoli che invadono territori e devastano ecosistemi creando situazioni di grande disequilibrio nel rapporto uomo-animale», ha scritto la virologa Ilaria Capua sul Corriere della Sera. Le città occupano solo il 3% della superficie del pianeta, ma ospitano quasi il 60% della popolazione mondiale, che consuma il 75% delle risorse naturali. Molte di queste città, sovrappopolate, chiosa lo studio del WWF, versano in condizioni igieniche precarie. «Le periferie degradate e senza verde di tante metropoli tropicali si trasformano nell’habitat ideale per malattie pericolose». I mercati delle metropoli, specialmente in Africa e Asia, che incontrano un’alta domanda della popolazione, spacciano spesso tutta la fauna predata: animali selvatici vivi, scimmie e tigri, serpenti, pangolini, pipistrelli (da cui avrebbe avuto origine il successivo spill-over del SARS-CoV-2 all’Uomo) favorendo conosciute e sconosciute zoonosi. A condire il tutto, c’è il Climate Change perché, spiegano dal WWF, «tutti i virus e i batteri prediligono l’umidità delle nuove condizioni climatiche».
Perché la minaccia al Pianeta ci fa meno paura
Perché allora non aggredire il problema, in via cautelativa, con misure drastiche quanto quelle prese per fronteggiare l’emergenza da nuovo Coronavirus? «La differenza è nel tempo. Il fenomeno del climate change — con il surriscaldamento globale, lo scioglimento die ghiacci artici, l’espansione termica degli Oceani — ha tempi più lenti del Coronavirus che invece in breve ha raggiunto una fase acuta che tocca direttamente la salute delle persone. Il Coronavirus viene percepito come una emergenza immediata, non procrastinabile, nei cui confronti bisogna prendere delle misure urgenti». Per quanto riguarda il fenomeno dei cambiamenti che minacciano il Pianeta, invece, «la percezione è quella di avere ancora tempo per intervenire, anche se non è detto che il tempo a disposizione sia ancora molto», sostiene Anna Oliverio Ferraris, già ordinario di Psicologia all’Università La Sapienza di Roma e autrice del libro Psicologia della paura (Bollati Boringhieri). Insomma: è tutta questione di tempo. E chi lo ha, non lo aspetti.
fonte: www.corriere.it
Labels:
#Ambiente,
#Cambiamento,
#Clima,
#Covid19,
#Deforestazione,
#Epidemie,
#Isde,
#RiscaldamentoGlobale,
#Urbanizzazione,
#Virus,
#WWF
Il futuro dipende (anche) dalle api
Le api sono insetti fondamentali per la prosperità e la sopravvivenza dell’intero ecosistema terrestre e di quella dell’uomo, che però con la sua azione irresponsabile ne sta minando l’esistenza. Per combattere il fenomeno, stanno nascendo diverse iniziative per la tutela di questo prezioso insetto.
Nonostante già durante i primi anni di scuola tutti impariamo quanto sia importante il ruolo che le api svolgono per la nostra esistenza e per quella dell’intero ecosistema, esso è ancora da molti sottovalutato.
L’ape domestica, insieme ad altri insetti come le farfalle, è una delle principali responsabili dell’impollinazione delle piante: spostandosi ripetutamente da un fiore all’altro, ogni ape è responsabile della fecondazione di un’enorme quantità di piante sull’intera superficie terrestre. Se questo fenomeno in alcuni casi può avvenire anche attraverso piogge e venti, per il 70% delle specie vegetali terrestri è invece totalmente dipendente dall’intervento delle api.
Dovrebbe risultare quindi automatico capire quanto sia importante la sopravvivenza di questo piccolo animale per l’uomo: gran parte di ciò che viene coltivato in agricoltura per soddisfare il fabbisogno alimentare dell’umanità dipende dal volo delle api, senza di esse le conseguenze per l’uomo sarebbero catastrofiche.
Purtroppo qualcosa in questo senso si sta già verificando e l’inverno in corso è un esempio perfettamente calzante: le temperature eccezionalmente elevate hanno fatto sì che le api si risvegliassero con almeno un mese di anticipo rispetto al loro normale ciclo biologico. La loro sopravvivenza ora è messa a repentaglio dall’alta probabilità di un ritorno a temperature decisamente più fredde.
Coldiretti ha già annunciato che, secondo le elaborazioni su dati Isac-Cnr relativi al mese di dicembre e gennaio, fino ad ora in Italia la temperatura è stata superiore di 1,65 gradi rispetto alla media storica. Le gelate di un inverno tardivo sarebbero nefaste tanto per i fiori sbocciati in anticipo quanto per gli insetti e potrebbero mettere in difficoltà diverse produzioni. Ma questo non è di certo il primo caso: già durante lo scorso 2019 infatti gli apicoltori toscani hanno registrato una perdita di produzione di miele pari a circa l’80%.
Le principali cause di questo allarmante fenomeno sono da ricercare nel cambiamento climatico, nella deforestazione senza scrupoli e nell’utilizzo irresponsabile di pesticidi: azioni che, negli ultimi 15 anni, hanno causato ingenti perdite tra la popolazione delle api in percentuali che, in alcune aree del globo, arrivano addirittura al 90% degli esemplari.
I danni derivanti da una situazione di questo tipo non sono soltanto ambientali: anche l’economia locale ne risentirebbe pesantemente. A una perdita di produzione nazionale non può che corrispondere un aumento delle importazioni, con tutte le conseguenze che ne derivano, una su tutte le difficoltà a cui andrebbero incontro le aziende italiane.
Così come in buona parte l’uomo è responsabile di questi cambiamenti negativi, il suo intervento è anche fondamentale per cercare di porvi rimedio. Un esempio in questo senso arriva dalla capitale, dove l’Assemblea Comunale romana si è dichiarata all’unanimità favorevole alla realizzazione di un progetto di “apicoltura urbana”, un’iniziativa votata alla lotta contro la moria delle api che prevede la destinazione di diverse aree pubbliche all’apicoltura cittadina, attraverso la posa di arnie che dovranno favorire il ripopolamento degli insetti e agevolarne l’esistenza. La delibera prevede inoltre interventi di incremento del verde pubblico e una progressiva riduzione dell’uso di pesticidi.
fonte: https://www.nonsoloambiente.it
Deforestazione e fonti fossili. Gli investimenti insostenibili del colosso BlackRock
“Mentre l’Amazzonia brucia, BlackRock sta facendo profitti sulla distruzione ambientale e il caos climatico”. La denuncia di Friends of the Earth USA, Amazon Watch e Profundo, le tre realtà che nell’agosto 2019 hanno pubblicato il report che rivela come il più grande investitore istituzionale del mondo (6.500 miliardi di dollari gestiti) sia profondamente “coinvolto” in settori problematici


“Mentre l’Amazzonia brucia, BlackRock sta facendo profitti sulla distruzione ambientale e il caos climatico”. Non lascia scampo il giudizio di Friends of the Earth USA, Amazon Watch e Profundo, le tre realtà che nell’agosto 2019 hanno pubblicato il report che rivela come BlackRock, il più grande investitore istituzionale del mondo con 6.500 miliardi di dollari gestiti, sia profondamente “impegnato” in settori responsabili della distruzione delle foreste tropicali dell’Amazzonia e del resto del Pianeta.
Il rapporto “BlackRock’s Big Deforestation Problem” analizza le sue partecipazioni tra il 2014 e il 2018 in 167 società responsabili della deforestazione -attive nella produzione e nel commercio di soia, manzo, olio di palma, cellulosa e carta, gomma e legno-, quotate in Borsa. Il colosso statunitense è tra i primi tre azionisti in 25 di queste e tra i primi dieci azionisti in altre 50. Non solo: dal 2014 le partecipazioni di BlackRock in questi settori di investimento sono aumentate di oltre mezzo miliardo di dollari.
Tra il 2014 e il 2018, infatti, il fondo ha detenuto azioni in 82 delle società quotate selezionate, che sono scese a 61 nel 2018, ma con un aumento del valore complessivo degli investimenti. Da 1 miliardo di dollari in investimenti in società “a rischio di deforestazione” nel 2014, a 1,6 miliardi di dollari quattro anni dopo.
Il rapporto “BlackRock’s Big Deforestation Problem” analizza le sue partecipazioni tra il 2014 e il 2018 in 167 società responsabili della deforestazione -attive nella produzione e nel commercio di soia, manzo, olio di palma, cellulosa e carta, gomma e legno-, quotate in Borsa. Il colosso statunitense è tra i primi tre azionisti in 25 di queste e tra i primi dieci azionisti in altre 50. Non solo: dal 2014 le partecipazioni di BlackRock in questi settori di investimento sono aumentate di oltre mezzo miliardo di dollari.
Tra il 2014 e il 2018, infatti, il fondo ha detenuto azioni in 82 delle società quotate selezionate, che sono scese a 61 nel 2018, ma con un aumento del valore complessivo degli investimenti. Da 1 miliardo di dollari in investimenti in società “a rischio di deforestazione” nel 2014, a 1,6 miliardi di dollari quattro anni dopo.

Partecipazioni di BlackRock in aziende a “rischio deforestazione”. Analisi dell’andamento (2014-2018, dati in milioni di dollari USA) – Fonte: Thomson EIKON (2019, February), Shareholdings; Profundo’s calculations
I principali motori di questa tendenza sono gli aumenti degli investimenti nelle aziende produttrici di cellulosa e carta -passati da 103 milioni di dollari nel 2014 a 565 milioni nel 2018, con una crescita del 548%- e olio di palma, nonché in carne bovina, gomma e legno.
Tra i casi delle aziende approfondite nel report, nell’ambito della produzione di carta c’è Suzano, di cui BlackRock è il terzo maggiore azionista (27.256.786 di azioni nel 2018), per un valore di 267,5 milioni di dollari. “Dalla sua fusione con Fibria nel gennaio 2019, la brasiliana Suzano è la più grande azienda di carta e cellulosa del mondo, con mercati in 80 Paesi. Possiede anche la società biotecnologica Future Gene, che opera in Brasile, Israele, Stati Uniti e Cina”, si legge nel report. Suzano controlla 2,3 milioni di ettari, di cui 1,3 milioni di piantagioni, ed è stata accusata di “accaparramento delle terre, distruzione su larga scala delle foreste indigene e violenza psicologica e fisica” sui suoi abitanti.
A proposito dell’olio di palma, invece, sono citate le partecipazioni di BlackRock in Golden Agri-Resources (GAR), la seconda compagnia palma da olio del mondo: 162.580.102 azioni del valore di 33 milioni di dollari. La società controlla più di mille chilometri quadrati di terra in Indonesia. Sarebbero gravi “le continue accuse di deforestazione illegale, distruzione dell’habitat degli scimpanzé in pericolo e l’uso della violenza e della coercizione per appropriarsi con la forza delle terre della comunità”, si legge nel rapporto.
“Gli investimenti di BlackRock stanno causando direttamente gli incendi boschivi in Amazzonia e la deforestazione in tutto il mondo”, denuncia Jeff Conant di Friends of the Earth USA, tra i curatori del rapporto. “Investendo denaro in questo tipo di aziende, BlackRock sta distruggendo l’ambiente e calpestando i diritti delle popolazioni che abitano le foreste”.
A quella di Conant si aggiunge la voce di Moira Birss di Amazon Watch: “Gli incendi attualmente in corso in Amazzonia dimostrano chiaramente il rischio che l’espansione dell’agroalimentare rappresenta per la foresta pluviale amazzonica, le popolazioni indigene e il clima. Con l’incremento degli investimenti nelle stesse industrie complici di questa distruzione, BlackRock sta incoraggiando il presidente Jair Bolsonaro a radere al suolo l’Amazzonia a scopo di lucro”.


I principali motori di questa tendenza sono gli aumenti degli investimenti nelle aziende produttrici di cellulosa e carta -passati da 103 milioni di dollari nel 2014 a 565 milioni nel 2018, con una crescita del 548%- e olio di palma, nonché in carne bovina, gomma e legno.
Tra i casi delle aziende approfondite nel report, nell’ambito della produzione di carta c’è Suzano, di cui BlackRock è il terzo maggiore azionista (27.256.786 di azioni nel 2018), per un valore di 267,5 milioni di dollari. “Dalla sua fusione con Fibria nel gennaio 2019, la brasiliana Suzano è la più grande azienda di carta e cellulosa del mondo, con mercati in 80 Paesi. Possiede anche la società biotecnologica Future Gene, che opera in Brasile, Israele, Stati Uniti e Cina”, si legge nel report. Suzano controlla 2,3 milioni di ettari, di cui 1,3 milioni di piantagioni, ed è stata accusata di “accaparramento delle terre, distruzione su larga scala delle foreste indigene e violenza psicologica e fisica” sui suoi abitanti.
A proposito dell’olio di palma, invece, sono citate le partecipazioni di BlackRock in Golden Agri-Resources (GAR), la seconda compagnia palma da olio del mondo: 162.580.102 azioni del valore di 33 milioni di dollari. La società controlla più di mille chilometri quadrati di terra in Indonesia. Sarebbero gravi “le continue accuse di deforestazione illegale, distruzione dell’habitat degli scimpanzé in pericolo e l’uso della violenza e della coercizione per appropriarsi con la forza delle terre della comunità”, si legge nel rapporto.
“Gli investimenti di BlackRock stanno causando direttamente gli incendi boschivi in Amazzonia e la deforestazione in tutto il mondo”, denuncia Jeff Conant di Friends of the Earth USA, tra i curatori del rapporto. “Investendo denaro in questo tipo di aziende, BlackRock sta distruggendo l’ambiente e calpestando i diritti delle popolazioni che abitano le foreste”.
A quella di Conant si aggiunge la voce di Moira Birss di Amazon Watch: “Gli incendi attualmente in corso in Amazzonia dimostrano chiaramente il rischio che l’espansione dell’agroalimentare rappresenta per la foresta pluviale amazzonica, le popolazioni indigene e il clima. Con l’incremento degli investimenti nelle stesse industrie complici di questa distruzione, BlackRock sta incoraggiando il presidente Jair Bolsonaro a radere al suolo l’Amazzonia a scopo di lucro”.

Partecipazioni di BlackRock in aziende a “rischio deforestazione” per commodity. Analisi dell’andamento (2014-2018, dati in milioni di dollari USA)
C’è poi l’aspetto della partecipazione di BlackRock in carbone, petrolio e gas. A inizio agosto, l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis ha dimostrato che BlackRock ha perso 90 miliardi di dollari a causa dei suoi investimenti in combustibili fossili fatti nell’ultimo decennio.
“Nel contesto della crisi ecologica globale, BlackRock, la più grande società d’investimento al mondo, con patrimoni in gestione superiori alla terza economia mondiale, ha di fatto rinnegato il suo dovere fiduciario di affrontare questi rischi -sottolineano le realtà curatrici del report-. BlackRock ha riconosciuto pubblicamente per la prima volta la deforestazione come un rischio climatico nel 2016, ma non ha ancora articolato una politica specifica e legata a politiche per raggiungere la deforestazione zero nei suoi portafogli”.
Per invertire la rotta, il report suggerisce di “adottare politiche e pratiche per gestire i rischi di deforestazione e i diritti fondiari”; “avanzare richieste alle aziende in cui si investe” e garantire che tali richieste “siano soddisfatte per prevenire danni ambientali e sociali irreversibili”. Quindi, “rendere i fondi privi di deforestazione automatici sia per i prodotti attivi che per quelli gestiti passivamente e rimuovere le società ad alto rischio”; e “impegnarsi in modo proattivo e sostanziale con le parti interessate della società civile” per costruire nuove politiche. L’aumento degli investimenti nei settori responsabili della distruzione ambientale diffusa e delle violazioni dei diritti umani non hanno alcuna giustificazione. La risposta, ora, sta nei fatti a BlackRock.
fonte: https://altreconomia.it
C’è poi l’aspetto della partecipazione di BlackRock in carbone, petrolio e gas. A inizio agosto, l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis ha dimostrato che BlackRock ha perso 90 miliardi di dollari a causa dei suoi investimenti in combustibili fossili fatti nell’ultimo decennio.
“Nel contesto della crisi ecologica globale, BlackRock, la più grande società d’investimento al mondo, con patrimoni in gestione superiori alla terza economia mondiale, ha di fatto rinnegato il suo dovere fiduciario di affrontare questi rischi -sottolineano le realtà curatrici del report-. BlackRock ha riconosciuto pubblicamente per la prima volta la deforestazione come un rischio climatico nel 2016, ma non ha ancora articolato una politica specifica e legata a politiche per raggiungere la deforestazione zero nei suoi portafogli”.
Per invertire la rotta, il report suggerisce di “adottare politiche e pratiche per gestire i rischi di deforestazione e i diritti fondiari”; “avanzare richieste alle aziende in cui si investe” e garantire che tali richieste “siano soddisfatte per prevenire danni ambientali e sociali irreversibili”. Quindi, “rendere i fondi privi di deforestazione automatici sia per i prodotti attivi che per quelli gestiti passivamente e rimuovere le società ad alto rischio”; e “impegnarsi in modo proattivo e sostanziale con le parti interessate della società civile” per costruire nuove politiche. L’aumento degli investimenti nei settori responsabili della distruzione ambientale diffusa e delle violazioni dei diritti umani non hanno alcuna giustificazione. La risposta, ora, sta nei fatti a BlackRock.
fonte: https://altreconomia.it
Labels:
#Ambiente,
#BlackRock,
#CompagnieFossili,
#Deforestazione,
#DistruzioneAmbientale,
#FontiFossili,
#Investimenti,
#ReportAmbientali
Antropocene, l’epoca umana. Al cinema il docufilm che racconta come l’uomo ha trasformato la Terra
Il 19 settembre arriva al cinema il documentario Antropocene, l’epoca umana. Una visione provocatoria dell’impatto che l’attività umana ha avuto sul pianeta



Urbanizzazione, industrializzazione, sfruttamento intensivo delle risorse naturali, deforestazione, bracconaggio, inquinamento. Sono solo alcuni dei più devastanti processi messi in atto dall’uomo a discapito del suo stesso pianeta. Il documentario canadese Antropocene, l’epoca umana (in sala dal 19 settembre) li passa in rassegna nei suoi 87 minuti, fotografando lo stato attuale della Terra e mostrando alcune delle sue più profonde ferite. Inserito in un progetto multimediale più ampio, il film è stato diretto dalla coppia di cineasti Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier (moglie e marito) e dal noto fotografo Edward Burtynsky. Un team che, grazie alla lunga esperienza e all’impegno sui temi ambientali, ha saputo dare vita a un’opera dall’impatto visivo eccezionale.
Per quattro anni i registi hanno viaggiato per il mondo, attraversando sei continenti e 20 Paesi, per immortalare la maestosità ferita di una natura drasticamente deturpata dall’azione umana. Immagini di una nuova epoca geologica: quella che gli studiosi chiamano Antropocene, l’epoca umana (dal greco ánthrōpos “uomo”).
Antropocene, l’impronta umana cambia la geologia
Secondo geologi e scienziati del gruppo di lavoro Anthropocene oggi ci troviamo a vivere in una nuova fase della linea geologica del tempo, chiamata, appunto, Antropocene.
Collocata dopo l’Olocene (iniziato 11.700 anni fa) l’epoca umana sarebbe iniziata a partire dalla metà del XX secolo, quando l’umanità ha iniziato a mettere in atto processi che hanno provocato cambiamenti duraturi e talvolta irreversibili. La tesi degli studiosi, dunque, è che l’uomo, ospite su un pianeta di oltre 4,5 miliardi di anni, abbia portato (in diecimila anni di civiltà moderna) l’ecosistema oltre i suoi limiti naturali, trasformandosi da partecipante alla vita sulla Terra ad agente “in grado di influenzare l’ambiente e i suoi processi più di tutte le altre forze naturali combinate”. Nel film Antropocene, l’epoca umana cerca di restituire visivamente gli effetti di questo impatto.
La trama e i luoghi del documentario
Per realizzare il loro progetto e dimostrare questa tesi, i tre registi hanno viaggiato quattro anni intorno al mondo, immortalando immagini che parlano da sole. Scenari surreali capaci di scuotere le coscienze, come nelle intenzioni dei filmaker, consapevoli che “Il mondo sta cambiando a una velocità tale che è fondamentale comunicarlo nel modo più potente possibile al maggior numero di persone possibile”.

Le miniere di fosfato in Florida. Le quantità di fosfato (azoto e potassio) nel terreno sono raddoppiate nell’ultimo secolo. Usati come fertilizzanti essi hanno causato il più grande cambiamento nel ciclo nutrizionale dell’ecosistema in 2,5 miliardi di anni. © Burtynsky
Dall’Africa alla Siberia, bracconaggio ed estrazione
In questo excursus, Antropocene ci porta nella riserva di Ol Pejeta, in Kenia, dove si tenta di preservare l’esistenza di rinoceronti ed elefanti, messa in serio pericolo dal bracconaggio. Qui assistiamo allo straziante rituale della cremazione di migliaia di zanne di elefante, sottratte ai sanguinosi bottini della criminalità. Un funereo falò che diventa il simbolo del documentario stesso, raccontando tutta la miseria e il paradosso dell’avidità umana. Un’avidità che stermina e distrugge e a cui solo l’uomo stesso può rimediare, invertendo la rotta delle proprie azioni. Dall’Africa ci spostiamo a Norilsk in Siberia, uno dei luoghi più inquinati al mondo e noto come città del nichel, in cui tutto ruota attorno all’industria dell’estrazione mineraria.
Dalle cave di marmo di Carrara alle miniere di lignite in Germania
Da lì si va in Europa, in luoghi dove l’intervento umano ha ormai irrimediabilmente mutato l’aspetto della superficie terrestre, come le cave di marmo di Carrara, dove oggi le macchine riescono a strappare alla montagna in un giorno quello che una volta ne richiedeva manualmente almeno quindici. Ma è in Germania che diventiamo spettatori di uno dei momenti più sconvolgenti del film, quando nel paesino di Immerath una graziosa chiesa risalente alla fine del XIX secolo viene completamente abbattuta dalle ruspe, per fare spazio alla miniera di lignite, che ormai dilaga in tutta la cittadina. Qui i macchinari più grandi al mondo lavorano incessantemente, trasformando profondamente la superficie terrestre.

La barriera corallina è la casa di oltre il 25 per cento di tutte le specie marine. L’acidificazione degli oceani e il riscaldamento globale potrebbe distruggerla entro la fine del XXI secolo. © Burtynsky
Dalle barriere frangiflutti cinesi ai giacimenti di litio in Cile
Il film prosegue trasportandoci lungo le barriere frangiflutti in cemento, edificate sul sessanta per cento delle coste cinesi, per arginare l’innalzamento dei mari, dovuto ai cambiamenti climatici, per poi condurci nelle profondità psichedeliche delle miniere di potassio nei monti Urali in Russia. Qui la città industriale di Berezniki era balzata agli onori delle cronache qualche anno fa per le enormi doline che, aprendosi nel terreno, hanno iniziato a inghiottire interi edifici.
Una delle visioni più surreali è quella delle immense vasche di evaporazione del litio nel deserto di Atacama, in Cile. Qui sorge il più grande giacimento di questo leggerissimo metallo, divenuto fondamentale per le moderne batterie di cellulari e strumenti tecnologici. Gli obiettivi dei registi ci conducono anche nelle profondità oceaniche della grande barriera corallina australiana, sempre più minacciata dall’acidificazione dei mari.
A chiudere il cerchio del devastante impatto dell’uomo sulla Terra il film ci accompagna a Dandora, in Kenya, tra le montagne di rifiuti di una delle più grande discariche del mondo, dove ogni giorno centinaia di disperati si guadagnano da vivere immersi nella spazzatura.

Per realizzare il film i registi hanno viaggiato quattro anni per il mondo, attraversando sei continenti e 20 Paesi © Anthropocene Film Inc.
Anthropocene, un progetto multimediale
Il film Antropocene, l’epoca umana ha debuttato al Toronto Film Festival 2018 ed è stato definito dall’Hollywood Reporter come “un viaggio visivo senza precedenti” e fa parte di un progetto multidisciplinare artistico e scientifico più ampio. Ne fa parte anche la mostra Anthropocene, attualmente allestita al Mast di Bologna e visitabile fino al 5 gennaio 2020. Il documentario rappresenta il terzo e ultimo capitolo di una trilogia, iniziata nel 2006 con Manufactures Landscapes, e proseguita nel 2013 con Watermark, dedicata dai registi proprio ad analizzare la fase più critica dell’attuale processo geologico e dell’impronta umana sulla Terra. In versione originale il film è narrato dal premio Oscar Alicia Vikander, mentre nella versione italiana è stata Alba Rohrwacher, profondamente colpita dal film, a voler prestare la propria voce.
Antropocene è stato selezionato da importanti kermesse cinematografiche, come il Sundance e il festival di Berlino, mentre in Italia a Cinemambiente ha recentemente vinto il premio del pubblico.
Il 12 settembre si terrà un’anteprima del film a Milano (ore 19,40 presso CityLife Anteo in occasione del Milano Green Forum), mentre il 18 settembre è in programma un’anteprima a Torino, presso il Cinema Massimo.
Il 19 settembre Antropocene, l’epoca umana arriverà nelle sale italiane
fonte: www.lifegate.it
Iscriviti a:
Post (Atom)