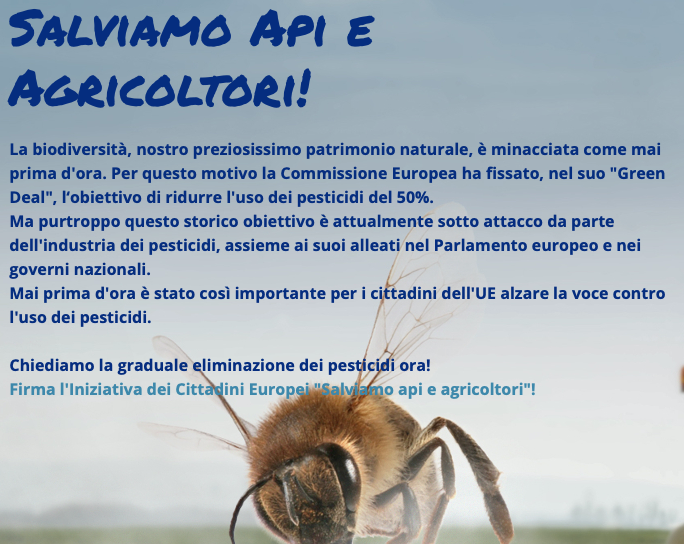In uno studio appena pubblicato su Communications biology, una rivista del gruppo Nature, un team di ricercatori coordinato da Simone Tosi dell’Università di Torino, ha svolto un...
Api: anche i pesticidi di nuova generazione risultano dannosi. Lo rivela una ricerca dell’Università di Torino
In uno studio appena pubblicato su Communications biology, una rivista del gruppo Nature, un team di ricercatori coordinato da Simone Tosi dell’Università di Torino, ha svolto un...
ICE SALVIAMO API E AGRICOLTORI: TOUR IN 8 CITTA' CON LA BENEDIZIONE DI PAPA FRANCESCO
COMUNICATO STAMPA
UN TOUR IN 8 TAPPE PER SALVARE API E AGRICOLTORI
Parte oggi il tour dell’alleanza dell’Iniziativa dei Cittadini Europei per salvare api e agricoltori che terminerà il giorno 8 settembre con la benedizione di Papa Francesco
“Salviamo Api e Agricoltori” è il titolo di un'ambiziosa Iniziativa dei ...
Cibo, ecco quanto dipendiamo dalle api

Un mondo senza api sarebbe sicuramente un pianeta privo di miele. Ma anche senza cioccolato. Il motivo? Il cacao è una delle colture – insieme al kiwi, meloni, cocomeri, zucche e noci del Brasile – che dipendono per il 90% dagli impollinatori, api in testa.
Le api, messe in pericolo dall’uso dei pesticidi (purtroppo non solo dai famigerati neonicotinoidi), svolgono insieme ad altri insetti – vespe e farfalle – un ruolo fondamentale nella ...
Cosa fare per proteggere le api e gli impollinatori dagli insetticidi
Se davvero si vogliono proteggere le api e gli altri impollinatori dalla catastrofica situazione in cui si trovano, è necessario rifondare la legislazione in materia di insetticidi e pesticidi, cambiandone radicalmente l’impostazione. A sostenerlo, dalle pagine di Nature, è Adrian Fisher, esperto in materia dell’Università dell’Arizona, che esprime un’opinione assai netta, e condivisa con 14 colleghi. Il primo dato di fatto è il fallimento delle normative attuali, con il clamoroso esempio dei neonicotinoidi, che Fisher definisce sistemico, in quanto del tutto incapace di proteggere gli impollinatori. Se si vuole cambiare, bisogna partire da un concetto fondamentale: che questi ultimi siano protagonisti ineludibili della sicurezza alimentare.
Chiare le linee guida suggerite da Fisher. Innanzitutto, prima di ottenere un via libera, un produttore deve dimostrare che il suo fitofarmaco non è tossico per gli impollinatori, e mettere a punto un protocollo per la verifica della tossicità a dosi subletali che includa lo studio del comportamento in situazioni ecologicamente realistiche. Bisogna poi rendere obbligatoria un’attività di analisi regolare sulle colonie di impollinatori, e prevedere test di tossicità da accumulo e da combinazione tra i diversi pesticidi e residui presenti nell’ambiente. Infine, è indispensabile affidare a enti pubblici terzi il controllo dei possibili effetti sul lungo termine, affinché emergano prima possibile eventuali tossicità impreviste.
Intanto, in attesa che i regolamenti e le norme seguano la direzione indicata da Fisher, uno studio dei ricercatori della Cornell University di Ithaca, New York, pubblicato su Nature Food, autorizza a sperare che almeno gli apicoltori possano disporre presto di un vero e proprio antidoto contro gli insetticidi. Secondo studi recenti, il 98% della cera e del polline degli Stati Uniti contiene sei tra i principali insetticidi usati nel mondo, alcuni dei quali noti per indebolire notevolmente il sistema immunitario delle api, rendendole così molto più suscettibili a infestazioni quali quella da Varroa.
Per questo i ricercatori newyorkesi, che hanno creato anche una start up (Beeimmunity) per commercializzare le soluzioni messe a punto, hanno cercato il modo di neutralizzare le sostanze tossiche che le api inevitabilmente assorbono con una sorta di finto polline ripieno di un enzima che, una volta entrato in circolo, le degrada. La sostanza, una fosfodiesterasi studiata contro i pesticidi organofosfati, viene somministrata in liquido zuccherino o insieme al polline (dal quale è indistinguibile). Così arriva all’apparato digerente, e il “guscio” protettivo delle particelle permette di oltrepassare intatta gli acidi dello stomaco delle api. Nell’intestino poi vengono scisse, liberando l’enzima che può agire, depurare l’organismo dell’insetto e neutralizzare il pesticida.
Dopo i primi test in vitro molto positivi, gli autori sono passati a quelli sulle api in laboratorio, confrontando la sopravvivenza di api esposte all’organofosfato malathion nutrite o meno con l’antidoto. Mentre il 100% delle prime ha resistito anche alle dosi più alte, le seconde sono morte tutte entro pochi giorni.
In seguito è stata ideata anche un’altra versione dell’antidoto, questa volta sfruttando l’azione stessa dei pesticidi e in particolare dei neonicotinoidi, diretti specificamente contro alcune proteine degli insetti. Le palline di finto polline, in quel caso, sono stare realizzate proprio con quelle proteine, in modo da avere una sorta di spugna sferica che attiri tutto l’insetticida al suo interno, e che sia poi espulsa con le feci. I primi risultati, anche in questo caso, sono più che incoraggianti.
Ora tutti i test si sono spostati in 240 alveari del New Jersey, per sperimentare le diverse soluzioni non solo in un ambiente naturale, ma nella complessa realtà delle colonie. Se tutto andrà per il meglio, entro pochi mesi potrebbe essere messo in vendita uno di questi antidoti che, secondo le previsioni, dovrebbero essere anche molto economici (l’enzima è già prodotto industrialmente e ha numerosi altri impieghi) e facilissimi da gestire.
fonte: www.ilfattoalimentare.it
=> Seguici su Blogger
=> Seguici su Facebook
L’omicidio è reato, ma non il biocidio : lo stato dell’arte nell’era della transizione ecologica.
In questi giorni mi scrivono per comunicarmi indignazione e rabbia per un uso vigliacco di prodotti agricoli che causano la morte degli esseri viventi.
“Cosa sta facendo!” un’amica carissima dalla provincia di Bari mi racconta l’ennesimo teatro innaturale. Un vicino sta vaporizzando del veleno su un ciglio del suo campo, ciglio che confina con il suo.“Sto disseccando, ma non si preoccupi: lo faccio qui mica nel suo terreno.”
“Ma è un pesticida!”
“No, è un disseccante” ribatte costui. Se la cortesia precede l’arguzia, la mia amica si auto-colloca nella riserva dei panda.
Quell’enclave di cittadini consapevoli che non accettano un futuro già segnato e non possono più capire l’ottusa routine dell’agricoltura moderna.
Veniamo al punto. Pochi giorni fa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha definitivamente vietato l’uso dei neonicotinoidi.
Si tratta di un momento storico, considerando che la battaglia legale è durata 8 anni.
Per capire questa posizione definitiva dobbiamo risalire ad un altra sentenza, del 30 novembre 2020, in cui la Corte dei conti europea obbliga l’EFSA ad esprimere pareri chiari in merito all’uso dei pesticidi e all’applicazione del principio di precauzione ma sopratutto obbliga la Commissione Europea a rispettare il parere dell’EFSA ed approvare l’uso dei formulati in agricoltura solo se se sicuri. Dalla storia recente degli ultimi 5 anni, più del 50% dei formulati sono stati approvati con procedure di emergenza.
Come apicoltore ricordo bene la storia delle decisioni dei governi italiani in questi ultimi 10 anni in merito all’uso di pesticidi tra cui erbicidi, disseccanti, fungicidi, acaricidi, talpicidi, battericidi, nematocidi, insetticidi, molluschicidi ed altre categorie.
L’italia è uno dei paesi europei che usa maggiormente i pesticidi, secondo ISPRA erbicidi insetticidi e fungicidi sono disciolti nel 67% dei campioni delle acque superficiali e nel 33% di quelle sotterranee. L’Europa è anche forte nell’Export di pesticidi nei paesi extra UE che producono poi i cibi che ritornano in Italia.
Questo movimento, che nutre e costituisce l’ossatura del mercato libero globale, è fatto di pesticidi.
Pesticidi che si muovono tra nazioni, veleni che scorrono nelle arterie delle nostre regioni e finiscono nel mare.
I danni si possono sintetizzare in 3 tipi. Danni irreversibili al suolo e al mare. Significa dover dipendere da altra chimica, inseguendo per sempre soluzioni inefficaci per ‘correggere’ la terra, essendo incapace di nutrire. Danni alla salute degli esseri viventi. Significa far cadere la sanità pubblica, a causa di malattie gravi anche letali, il cui nesso pesticida-malattia sta emergendo sotto traccia grazie alla ricerca scientifica. Danni al comparto agricolo e all’export italiano. Significa infine ridisegnare la geografia agricola, nella prospettiva peggiore in cui perdere l’identità della produzione italiana.
Sostenere di voler rispettare le regole di buon vicinato pensando che il disseccante agisca solo nel proprio fondo, è quasi ironico.
Analizzando le api nell’astigiano, grazie all’ultimo servizio pubblicato su LAPIS (aprile/maggio 2021) scopriamo un apicoltore professionista si è dedicato a sue spese ad effettuare le analisi del miele che produceva. In questi anni ha rilevato presenze di Flonicamid in concentrazione di 129 ppb in ambiente frutticolo (il quale esplica una tossicità acuta già a 53,3 milionesimi di grammo per ape). Poi la Cipermetrina a una concentrazione pari a 1153 ppb in ambiente vinicolo (che esplica una tossicità acuta già a 0,4592 milioni di grammo per ape). Come fungicida ha rilevato Folpet e Phtalimide che hanno superato insieme i 34’000 ppm (tali formulati esplicano una tossicità acuta già a 10 microgrammi per ape).
Ma venendo al glifosato dalle analisi effettuate ha riscontrato una concentrazione pari a 792 ppb. L’apicoltore ha affermato di aver trovato tracce di glifosato anche nel miele di alveari a più di 900 metri s.l.m.
Tutto questo deve farci riflettere, al netto delle centinaia di campagne sull’ambiente, sul fatto che il veleno che viene applicato nelle nostre campagne non resta mai confinato nel perimetro della propria parcella ma corre e lo fa velocemente.
Vietare imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam, una categoria di veleni certamente la più abusata e pericolosa, è una parziale vittoria.
Considerando che ci sono voluti molti anni per una sentenza come questa, a fronte di sospensioni (e quasi mai divieti) dei rispettivi stati membri Italia compresa, ci troviamo davanti ad una sfida ancora più grande.
E’ una sfida culturale, rivolta a noi tutti. Non possiamo aspettare altri dieci o vent’anni per veder vietare altre 3 molecole, rispetto alle centinaia di formulati che vengono immessi nel mercato, di cui bastano pochi microgrammi per creare danni incalcolabili.
Se non vogliamo perdere la nostra campagna e il primato della nostra identità, e se vogliamo stare in salute non possiamo sperare in ulteriori divieti.
Dobbiamo cambiare a monte il problema. E cioè cambiare il modo di fare agricoltura.
C’è una moltitudine di persone in Europa che ci crede, e dobbiamo prendere questa sentenza come un segnale forte, incontrovertibile di una possibilità di farcela. Contro i poteri forti e le lobbies della produzione agricola intensiva e contro le politiche che garantiscono ai contadini solo debiti e fatiche, il 2021 segna un punto a favore della terra e della sovranità alimentare.
La sfida è culturale perchè istituzioni, scuole, famiglie devono riaffermare le competenze e lo spirito di coltivare la terra senza scorciatoie perchè -lo ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea- le scorciatoie uccidono.
*Guido Cortese . Apicoltore
fonte: vociperlaterra.it
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Alessandra Prampolini, Wwf Italia. Per salvare la Terra dobbiamo fermare lo sfruttamento nascosto

Quest’anno il tema della Giornata mondiale della Terra è il ripristino degli ecosistemi. Ne abbiamo parlato con Alessandra Prampolini che, dallo scorso gennaio, è direttrice generale del Wwf Italia, prima donna a ricoprire questa carica nell’associazione. Dal consumo di cibo non più sostenibile all’agricoltura, dall’allevamento fino alla deforestazione, Alessandra Prampolini invita ad analizzare la crisi climatica e quella della biodiversità come fenomeni interconnessi, rispetto ai quali vanno messe in campo azioni integrate e trasversali. In quest’ottica, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che l’Italia si appresta a presentare a Bruxelles costituisce uno snodo fondamentale, perché le modalità con le quali decideremo di declinarlo tracceranno il solco lungo il quale ci muoveremo nei prossimi anni.
In occasione della Giornata mondiale della Terra il Wwf ha lanciato la campagna Food4Future. Qual è il messaggio principale che volete veicolare?
Dobbiamo modificare i sistemi agroalimentari sia dal punto di vista della produzione che da quello del consumo. Per come sono oggi, hanno impatti eccessivi sul pianeta e non sono efficienti: né per quanto riguarda la distribuzione – pensiamo al tema dei rifiuti e a quello della fame nel mondo –né per quanto concerne la salute, perché la gran parte del cibo che produciamo non è salutare. I sistemi agroalimentari vanno rivisti alla luce delle necessità umane e dei limiti del pianeta.
Quali sono gli impatti negativi sull’ecosistema di un consumo di cibo poco sostenibile?
Clima e biodiversità sono crisi planetarie che rappresentano due facce della stessa medaglia: l’80 per cento della perdita di biodiversità è causata dall’agricoltura e dall’allevamento, che sono responsabili anche del 24 per cento delle emissioni nocive. C’è poi il grande tema del consumo del suolo: abbiamo già consumato i tre quarti delle terre emerse e la prima causa della deforestazione sono proprio le nuove coltivazioni e l’allevamento, che già occupano il 40 per cento delle terre emerse. Un altro punto importante è quello dei cicli biogeochimici: consumiamo fertilizzanti minerali in numero dieci volte maggiore rispetto a 50 anni fa, e ciò si traduce in inquinamento, degrado del suolo e peggiore qualità delle acque. In proposito, l’uso scorretto della risorsa idrica ha portato a un consumo triplicato in 50 anni dell’acqua destinata all’agricoltura, senza dimenticare che l’80 per cento dei laghi italiani versa in uno stato ecologico non buono.
Abbiamo già consumato i tre quarti delle terre emerse e la prima causa della deforestazione sono proprio le nuove coltivazioni e l’allevamento, che già occupano il 40 per cento delle terre emerse.
Il tema della Giornata della Terra 2021 è il ripristino degli ecosistemi. In proposito, un vostro recente report ha quantificato gli impatti sulla deforestazione legati al commercio internazionale. Cosa emerge in particolare da questo lavoro?
Emerge l’enorme impatto della deforestazione importata, nascosta nelle nostre abitudini di consumo e in quello che mangiamo. Un tempo le foreste si utilizzavano principalmente per realizzare utensili in legno o per il riscaldamento domestico, mentre ora la produzione di soia, olio di palma e carne bovina è la principale responsabile della deforestazione. Il Wwf sta lavorando con l’Unione europea a una proposta legislativa per ridurre l’impronta dei consumi, ponendo limiti all’importazione di prodotti che abbiano origine forestale o che siano legati alla deforestazione. Quella nascosta pesa ormai per l’80 per cento rispetto alla deforestazione in tutto il mondo; l’Europa è seconda solo alla Cina in termini di deforestazione importata, e l’Italia figura al secondo posto in Europa.

Sempre in riferimento anche al cibo che arriva sulle nostre tavole, stiamo perdendo il prezioso esercito degli insetti impollinatori. Qual è il quadro e quali sono le conseguenze?
Si tratta di una delle crisi più drammatiche a livello globale, di un fenomeno che procede a velocità spaventosa e che spesso in passato è stato ignorato. Il numero dei volatori in Europa si è ridotto del 70 per cento negli ultimi 30 anni, e oggi a livello globale il 40 per cento degli insetti più comuni come api selvatiche, farfalle e coleotteri rischiano l’estinzione. Ben l’80 per cento delle 1.400 piante da cui si produce cibo nel mondo richiede l’impollinazione: il venir meno di questo servizio ecosistemico fa crollare le possibilità di portare in tavola alimenti che garantiscono la nostra salute e il nostro sostentamento. La riduzione di cibi legati a una dieta sana come frutta, verdura, noci e semi, aumenta i rischi di diabete e di malattie cardiovascolari; anche perché al contempo si assiste alla crescita di colture alimentari povere di nutrienti come riso, soia, mais e patate.
Tra le principali cause dell’estinzione degli impollinatori ci sono anche i cambiamenti climatici. A livello globale si sta facendo abbastanza per contrastarne gli effetti?
Ancora no, purtroppo. Come Unione europea ci siamo posti l’obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e target progressivi intermedi con orizzonte al 2030. A fronte dell’Accordo di Parigi, manca però l’implementazione di un piano di azione vincolante per i diversi Paesi: gli obiettivi devono essere legati alla riduzione delle emissioni e a un aumento delle energie rinnovabili, e al contempo serve una chiara scansione temporale per il loro raggiungimento. Lo scorso anno non ha aiutato lo slittamento della Cop26 a causa dell’emergenza pandemica, perché avrebbe rappresentato un importante momento di confronto a cinque anni dagli accordi di Parigi.
Il Wwf ha rimarcato le “enormi prospettive di collaborazione” che esistono tra uomo e natura nel contrasto ai cambiamenti climatici.
Un aumento delle temperature causa una perdita di biodiversità, ma è bene rimarcare che è vero anche il contrario: ci sono tante specie animali che sono preziose alleate nel contrasto al cambiamento climatico. Faccio qualche esempio. Elefanti, gibboni e macachi svolgono un ruolo essenziale per diffondere i semi di molte specie arboree, e in questo modo contribuiscono all’espansione della biodiversità in habitat anche molto diversi fra di loro. In vita, le balene accumulano carbonio nei tessuti e quando muoiono lo depositano sui fondali marini: ogni balena adulta cattura in media 33 tonnellate di CO2. Anche le formiche, con il loro instancabile lavoro, generano una serie di reazioni chimiche che facilitano assorbimento della CO2 da parte del suolo: i suoli abitati da formiche hanno una capacità di assorbimento 300 volte superiore rispetto agli altri.
Il Next Generation Eu può rappresentare una svolta per la transizione ecologica dell’Europa?
Il Next Generation Eu è lo strumento del secolo e le modalità con le quali decideremo di utilizzarlo daranno l’impronta dei prossimi anni. Rappresenta insomma un’occasione unica e come Wwf stiamo chiedendo che l’approccio sia quello della transizione ecologica, a patto che lo sia realmente. Il primo principio è che il valore della natura deve essere, con un approccio trasversale, incorporato in tutti i processi decisionali.
Alessandra Prampolini, il 30 aprile l’Italia dovrà presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza all’Ue, su cosa si dovrebbe puntare con maggiore decisione?
Almeno il 37 per cento delle risorse deve essere destinato in azioni in difesa del clima e a tutela della biodiversità. In secondo luogo, l’azione di rilancio del nostro Paese deve prevedere un rinnovamento della strategia industriale, il cui fine ultimo deve essere la completa decarbonizzazione: ciò potrà avvenire solo con target di riduzione delle emissioni molto chiari e con investimenti massicci sulle energie rinnovabili. Va infine riqualificata la natura: in Italia abbiamo uno dei patrimoni più importanti in Europa, ma anni di consumo incauto di suolo hanno fatto sì che siano sopravvissute piccole isole di biodiversità, non collegate fra di loro, che oltretutto si stanno riducendo. Servono quindi azioni per la tutela, il ripristino e la riconnessione delle tante aree che il nostro Paese ospita: ciò a vantaggio non solo del turismo, ma anche di attività come l’agricoltura e la pesca.
fonte: www.lifegate.it
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Stop pesticidi, lettera aperta di “Salviamo le api” ai decisori italiani. Firmiamo l’appello europeo
L’agricoltura europea sta raggiungendo un vicolo cieco. Le politiche agricole che erano orientate unilateralmente verso l’aumento dei raccolti incrementando l’uso di prodotti chimici tossici hanno portato l’ecosistema sull’orlo del collasso. Le conseguenze per la natura sono disastrose: api, farfalle e altri insetti stanno scomparendo dai nostri paesaggi e uccelli precedentemente diffusi hanno smesso di cantare nei nostri campi. I nostri torrenti e fiumi vengono inquinati e siamo esposti a un cocktail quotidiano di pesticidi sintetici attraverso il nostro cibo. L’eliminazione graduale dei pesticidi sintetici è quindi il prerequisito fondamentale e la leva più forte per la transizione dall’attuale modello agricolo ad alta intensità di input a un modello di miglioramento della biodiversità basato su cicli naturali.
Le associazioni italiane aderenti all’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “Salviamo Api e Agricoltori” hanno inviato una lettera ai decisori politici per ricordare gli impegni dell’Italia per la riduzione dell’uso dei pesticidi. La Commissione Europea ha fissato col Green Deal l‘obiettivo di ridurre l’uso dei pesticidi del 50% entro il 2030. Ma questo obiettivo è sotto attacco da parte dell’industria, di lobby e corporazioni. Nella lettera – ricorda Help Consumatori – le associazioni sostengono che «la biodiversità, in particolare quella delle api e di altri impollinatori negli ecosistemi agricoli, è in drastico calo sia in Italia che in Europa e nel mondo. E sottolineano che una delle cause di questo declino è proprio l’uso dei pesticidi chimici in agricoltura.
Nel testo, la coalizione composta da decine di associazioni, chiede dunque ai decisori politici «di assumere posizioni ed iniziative coraggiose e lungimiranti per rafforzare gli obiettivi delle due Strategie UE “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030”.Bisogna adottare piani e programmi nazionali coerenti, recuperando i gravi ritardi nell’aggiornamento del Pan pesticidi, nella redazione del Piano strategico nazionale della PAC post 2023 e nell’approvazione della Legge nazionale per l’agricoltura biologica. Tutti strumenti indispensabili per proteggere gli impollinatori, l’agricoltura, l’ambiente e la salute dei cittadini».
Il coordinamento italiano di “Salviamo le api ” ricorda, nella lettera inviata ai ministri e ai decisori competenti in materia di regolamentazione dell’uso dei pesticidi, che «il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è scaduto nel febbraio 2018 e il nuovo testo presentato per la consultazione pubblica nel 2019 è stato superato dagli obiettivi delle Strategie UE “Farm to Fork” e “Biodiversità” che indicano il traguardo della riduzione del 50% dell’uso dei pesticidi in Europa entro il 2030».

La petizione “Salviamo le api e gli agricoltori” – continua Help Consumatori – si può firmare fino a giugno. Se l’ICE avrà successo raccogliendo 1 milione di firme, la Commissione Europea sarà legalmente tenuta ad esaminare le richieste avanzate e proporre atti legali vincolanti per gli Stati membri per l’implementazione degli obiettivi delle Strategie UE “Farm to Fork” e “Biodiversità”. Oltre 533 mila cittadini europei (di cui 20 mila italiani) hanno sottoscritto l’ICE “Salviamo Api e Agricoltori”, sostenuta da oltre 250 organizzazioni in tutta Europa, e la raccolta di firme continuerà fino al prossimo mese di giugno. L’eliminazione graduale dei pesticidi sintetici è quindi il prerequisito fondamentale e la leva più forte per la transizione dall’attuale modello agricolo ad alta intensità di input a un modello di miglioramento della biodiversità basato su cicli naturali
La raccolta delle firme è importante per sollecitare gli Stati membri dell’Unione Europea ad elaborare Piani d’Azione Nazionali con obiettivi concreti per ridurre significativamente l’uso di pesticidi nei prossimi anni e trasformare l’obiettivo del 50% di riduzione dell’uso di pesticidi fissato dalle strategia “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030” in una norma vincolante per i Governi nazionali. Per firmare clicca qui.
fonte: www.ilfattoalimentare.it
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Così il glifosato “disorienta” le api
Uno studio condotto da ricercatori cinesi ha trovato prove che i prodotti erbicidi commerciali a base di glifosato, come il RoundUp della Bayer-Monsanto, sono dannosi per le api mellifere anche alle concentrazioni raccomandate o inferiori alla stessa. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Report del network di Nature e mostrano come l’azione del glifosato sugli insetti più operosi ne riduca proprio le capacità operative.
I ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze agricole di Pechino e del Chinese Bureau of Landscape and Forestry, hanno affermato di aver riscontrato una serie di effetti negativi sulle api mellifere esponendole al Roundup. In particolar modo la memoria delle api era “significativamente compromessa dopo l’esposizione a Roundup”, suggerendo che l’esposizione cronica delle api mellifere al famigerato erbicida “può avere un impatto negativo sulla ricerca e la raccolta di materia prima e sul coordinamento delle attività di foraggiamento” per la produzione del miele. Dall’esposizione al glifosato sarebbe compromesso anche la capacità di “arrampicata” delle api, cioè la capacità di risalita degli impollinatori.
I ricercatori hanno concluso stabilendo che c’è bisogno di un “sistema di allarme rapido in caso di irrorazione di erbicidi” perchè troppo “frequenti sono gli episodi di avvelenamento delle api da miele”.
fonte: https://ilsalvagente.it
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Salvare le api, un progetto europeo nato a Venezia. 3,2 milioni di euro per prati, siepi e bordure fiorite
Gli insetti impollinatori sono fondamentali per la produzione della maggioranza delle specie vegetali e quindi per l’agricoltura, ma oggi sono a rischio di estinzione. Un problema legato al degrado ambientale e alla scomparsa degli habitat naturali di questi insetti, che secondo la piattaforma intergovernativa su biodiversità e servizi ecosistemici (Ipbes) riguarda oltre il 40% delle specie, principalmente api e altri imenotteri (vespe o api selvatiche) o farfalle. Per il momento si cerca di rimediare con progetti internazionali come LIFE Biodiversità PollinAction, della durata di cinque anni coordinato dall’Università di Venezia.
“Esistono varie categorie di insetti impollinatori”, spiega Emilio Guerrieri, dirigente di ricerca presso l’istituto per la Protezione sostenibile delle piante del Cnr, “tra le più importanti gli imenotteri, quali api, vespe e simili, i ditteri quali mosche e simili e i lepidotteri ossia le farfalle diurne”. Sono però gli imenotteri a essere i principali impollinatori – approssimativamente in una percentuale intorno al 50%, seguiti rispettivamente dagli altri due gruppi al 30 e al 20% – e quindi quelli più a rischio. “La criticità è legata a diversi fattori – spiega Guerrieri – l’uso di insetticidi ad ampio spettro di azione, il cambiamento climatico che influisce sulla quiescenza, il riposo nei mesi freddi, che possiamo paragonare al letargo e la perdita di biodiversità vegetale, cui si aggiungono altri elementi di stress come i parassiti delle api”.
Eventi che mettono in crisi un meccanismo naturale di straordinaria efficienza, che offre alle piante importanti vantaggi genetici: “Gli insetti bottinano i fiori per il nettare di cui si nutrono, e in questo modo si sporcano di polline che trasportano da pianta a pianta”, spiega Guerrieri. Tra poco questo potrebbe non essere più possibile, come mostrano dati preoccupanti sulla moria di insetti, soprattutto api, con la conseguente riduzione della produzione di miele, ma soprattutto con gravi conseguenze per le coltivazioni. “In Cina ho visto frutteti in cui i fiori di pero erano impollinati a mano da braccianti agricoli, uno per uno”, ricorda Guerrieri. “Uno scenario apocalittico che non è così lontano da noi, anche se ora anche lì si sta cercando di portare l’agricoltura verso una maggiore sostenibilità”.
Ed è in questa direzione che si muove LIFE “Biodiversità” PollinAction, coordinato dalla botanica Gabriella Buffa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e avviato dal mese scorso con un budget di 3,2 milioni di euro e dieci partner tra l’Italia e la Spagna. Un programma di azioni finalizzate a invertire questa tendenza, recuperando gli habitat naturali di questi insetti; “Prima di tutto i prati da sfalcio, a vegetazione spontanea e quindi ricchi di biodiversità, che una volta erano un elemento essenziale del sistema agicolo da cui si ricavava il fieno per il bestiame, ma che oggi stanno scomparendo a causa dell’urbanizzazione e di un’intensificazione dell’agricoltura”, osserva Buffa. Questi prati garantiscono fioriture prolungate, dove gli insetti possono trovare nutrimento durante tutta la stagione; i coltivi hanno invece cicli più brevi, con fioriture sincrone, come ad esempio i frutteti, o hanno diversi sistemi di impollinazione come i cereali, privando api e altri insetti della possibilità di nutrirsi.
Con quali conseguenze? “Uno degli obiettivi del progetto è di quantificare la situazione”, spiega la botanica. In Europa e in altri paesi ci sono molti dati sulla perdita di insetti, mentre della situazione italiana sappiamo poco, e anche il report europeo del 2017 sulle iniziative dei diversi stati europei a tutela degli impollinatori non menziona neppure l’Italia. Anche se ci sono forti segnali di allarme, come la notevole riduzione della produzione di miele, che nel 2019 si è praticamente dimezzata.
L’obiettivo del progetto europeo è quello di realizzare infrastrutture “verdi” che favoriscono la presenza di specie vegetali adatte agli insetti. “Lavoreremo con modalità diverse”, spiega Buffa, “in Spagna puntiamo a recuperare terreni abbandonati, mentre in Italia i nostri interventi sono concentrati in aree della Pianura Padana orientale, fortemente antropizzate e dove è diffusa l’agricoltura meccanizzata“. Nel progetto sono coinvolti sei comuni, due apicoltori in Spagna, sei aree ad agricoltura estensiva in Friuli-Venezia Giulia e il Passante di Mestre oltre ad alcune aziende agricole appartenenti al circuito di EcorNaturasì, produttore e distributore di alimenti biologici e biodinamici. “Cerchiamo di dimostrare che si può fare economia utilizzando il territorio in modo sostenibile”, spiega Buffa, “in Italia stiamo creando una filiera per valorizzare la produzione di latte e formaggio da animali alimentati col fieno ricavato dallo sfalcio dei prati, per valorizzare la competitività delle aziende agricole che mettono a disposizione il terreno per il progetto”.
In altre aree, come le scarpate del passante di Mestre, è prevista invece la realizzazione di prati, siepi e bordure fiorite: “Interventi di questo tipo sono molto diffusi in altri paesi, come la Gran Bretagna”, spiega Buffa, “e oltre a rendere più gradevole il paesaggio offrono agli insetti piccole aree attraverso le quali spostarsi“. Il progetto prevede la conversione di 200mila metri quadrati di seminativi in prati fioriti, oltre al miglioramento di 2,6 milioni di m2 di praterie esistenti, e alla realizzazione di 3,5 chilometri di siepi e di corridoi ecologici su trenta chilometri di strade.
fonte: www.ilfattoalimentare.it
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Api a rischio e con loro anche la produzione alimentare. La petizione di Greenpeace
Greenpeace ha lanciato una campagna per chiedere al Governo italiano e alla Commissione Europea di prendere efficaci e rapidi provvedimenti per tutelare la salute delle api. Il ruolo di questi insetti è fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi ma anche per la produzione alimentare e quindi per l’economia. L’84% delle specie coltivate nell’Unione Europea dipendono dall’impollinazione degli insetti, come ad esempio mele, fragole, pomodori e mandorle.
Dagli anni ’90 si è notato un preoccupante declino delle api, che purtroppo non si è ancora arrestato. I fattori indicati dagli esperti sono molteplici, e agiscono singolarmente o in combinazione fra loro. Fra i più importanti l’uso di pesticidi, la perdita di habitat naturali, malattie e parassiti e i cambiamenti climatici.

Tra i pericoli diretti ci sono alcuni pesticidi chimici, in particolare i neonicotinoidi. L’Unione Europea nel 2018 ha messo al bando tre insetticidi di questa categoria, l’imidacloprid e il clothianidin della Bayer e il tiamethoxam della Syngenta. Ma è ancora consentito l’uso di altri neonicotinoidi come acetamiprid e altre sostanze quali sulfoxaflor, flupyradifurone, cipermetrina, deltametrina e clorpirifos.
L’eliminazione di queste sostanze sarebbe il primo e più efficace passo da adottare per difendere gli impollinatori.
La richiesta di Greenpeace alle istituzioni si articola in tre punti chiave:
– bandire l’uso di tutti i pesticidi dannosi per le api e gli altri insetti impollinatori
– applicare rigidi standard per la valutazione dei rischi da pesticidi
– aumentare i finanziamenti per la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di pratiche agricole ecologiche
Per sostenere la campagna si può firmare la petizione qui.
fonte: www.ilfattoalimentare.it
RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Neonicotinoidi: tossici per le api e dannosi anche per le larve. Uno studio sulla pericolosità di questi pesticidi

Per filmare ogni passaggio, i ricercatori hanno messo a punto quattro alveari con una parete trasparente su cui hanno appoggiato una telecamera specifica, che lavora con la luce infrarossa e quindi non disturba, e hanno studiato il comportamento delle nutrici alimentate con acqua zuccherata con o senza due tra i neonicotinoidi più usati, il Thiacloprid e il Clothianidin.

Gli autori non sanno dire quali di questi effetti sia predominate o se siano tutti quanti, insieme, a dare come esito finale un minor numero di api, ma di sicuro queste sostanze agiscono direttamente sulle nuove generazioni, decimandole.
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Le api sentinelle dell’ambiente
#RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Con il lockdown stiamo salvando le api: i fiori selvatici spuntano nelle città di tutto il mondo
Negli ultimi anni, spiega Trevor Dines, botanico di Plantlife, “la cattiva gestione si è combinata con l’inquinamento, creando una ‘tempesta perfetta’. I consigli comunali hanno adottato politiche eccessivamente impazienti che abbattono i fiori prima che possano piantare i semi”. Ma sono state proprio le falciature, a causa della crisi dovuta a Covid-19, ad essere tra i primi servizi ridotti se non addirittura sospesi. E gli ecosistemi vegetali urbani hanno già iniziato a riprendersi.
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Il futuro dipende (anche) dalle api
Coldiretti ha già annunciato che, secondo le elaborazioni su dati Isac-Cnr relativi al mese di dicembre e gennaio, fino ad ora in Italia la temperatura è stata superiore di 1,65 gradi rispetto alla media storica. Le gelate di un inverno tardivo sarebbero nefaste tanto per i fiori sbocciati in anticipo quanto per gli insetti e potrebbero mettere in difficoltà diverse produzioni. Ma questo non è di certo il primo caso: già durante lo scorso 2019 infatti gli apicoltori toscani hanno registrato una perdita di produzione di miele pari a circa l’80%.