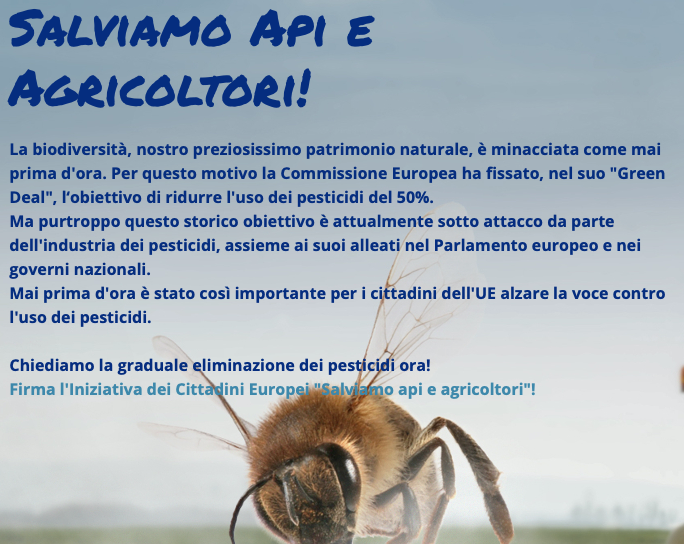Ri-Abitare - città e territorio - Gubbio, sabato 13 aprile ore 17
Api: anche i pesticidi di nuova generazione risultano dannosi. Lo rivela una ricerca dell’Università di Torino
In uno studio appena pubblicato su Communications biology, una rivista del gruppo Nature, un team di ricercatori coordinato da Simone Tosi dell’Università di Torino, ha svolto un...
ICE SALVIAMO API E AGRICOLTORI: TOUR IN 8 CITTA' CON LA BENEDIZIONE DI PAPA FRANCESCO
COMUNICATO STAMPA
UN TOUR IN 8 TAPPE PER SALVARE API E AGRICOLTORI
Parte oggi il tour dell’alleanza dell’Iniziativa dei Cittadini Europei per salvare api e agricoltori che terminerà il giorno 8 settembre con la benedizione di Papa Francesco
“Salviamo Api e Agricoltori” è il titolo di un'ambiziosa Iniziativa dei ...
Cosa fare per proteggere le api e gli impollinatori dagli insetticidi
Se davvero si vogliono proteggere le api e gli altri impollinatori dalla catastrofica situazione in cui si trovano, è necessario rifondare la legislazione in materia di insetticidi e pesticidi, cambiandone radicalmente l’impostazione. A sostenerlo, dalle pagine di Nature, è Adrian Fisher, esperto in materia dell’Università dell’Arizona, che esprime un’opinione assai netta, e condivisa con 14 colleghi. Il primo dato di fatto è il fallimento delle normative attuali, con il clamoroso esempio dei neonicotinoidi, che Fisher definisce sistemico, in quanto del tutto incapace di proteggere gli impollinatori. Se si vuole cambiare, bisogna partire da un concetto fondamentale: che questi ultimi siano protagonisti ineludibili della sicurezza alimentare.
Chiare le linee guida suggerite da Fisher. Innanzitutto, prima di ottenere un via libera, un produttore deve dimostrare che il suo fitofarmaco non è tossico per gli impollinatori, e mettere a punto un protocollo per la verifica della tossicità a dosi subletali che includa lo studio del comportamento in situazioni ecologicamente realistiche. Bisogna poi rendere obbligatoria un’attività di analisi regolare sulle colonie di impollinatori, e prevedere test di tossicità da accumulo e da combinazione tra i diversi pesticidi e residui presenti nell’ambiente. Infine, è indispensabile affidare a enti pubblici terzi il controllo dei possibili effetti sul lungo termine, affinché emergano prima possibile eventuali tossicità impreviste.
Intanto, in attesa che i regolamenti e le norme seguano la direzione indicata da Fisher, uno studio dei ricercatori della Cornell University di Ithaca, New York, pubblicato su Nature Food, autorizza a sperare che almeno gli apicoltori possano disporre presto di un vero e proprio antidoto contro gli insetticidi. Secondo studi recenti, il 98% della cera e del polline degli Stati Uniti contiene sei tra i principali insetticidi usati nel mondo, alcuni dei quali noti per indebolire notevolmente il sistema immunitario delle api, rendendole così molto più suscettibili a infestazioni quali quella da Varroa.
Per questo i ricercatori newyorkesi, che hanno creato anche una start up (Beeimmunity) per commercializzare le soluzioni messe a punto, hanno cercato il modo di neutralizzare le sostanze tossiche che le api inevitabilmente assorbono con una sorta di finto polline ripieno di un enzima che, una volta entrato in circolo, le degrada. La sostanza, una fosfodiesterasi studiata contro i pesticidi organofosfati, viene somministrata in liquido zuccherino o insieme al polline (dal quale è indistinguibile). Così arriva all’apparato digerente, e il “guscio” protettivo delle particelle permette di oltrepassare intatta gli acidi dello stomaco delle api. Nell’intestino poi vengono scisse, liberando l’enzima che può agire, depurare l’organismo dell’insetto e neutralizzare il pesticida.
Dopo i primi test in vitro molto positivi, gli autori sono passati a quelli sulle api in laboratorio, confrontando la sopravvivenza di api esposte all’organofosfato malathion nutrite o meno con l’antidoto. Mentre il 100% delle prime ha resistito anche alle dosi più alte, le seconde sono morte tutte entro pochi giorni.
In seguito è stata ideata anche un’altra versione dell’antidoto, questa volta sfruttando l’azione stessa dei pesticidi e in particolare dei neonicotinoidi, diretti specificamente contro alcune proteine degli insetti. Le palline di finto polline, in quel caso, sono stare realizzate proprio con quelle proteine, in modo da avere una sorta di spugna sferica che attiri tutto l’insetticida al suo interno, e che sia poi espulsa con le feci. I primi risultati, anche in questo caso, sono più che incoraggianti.
Ora tutti i test si sono spostati in 240 alveari del New Jersey, per sperimentare le diverse soluzioni non solo in un ambiente naturale, ma nella complessa realtà delle colonie. Se tutto andrà per il meglio, entro pochi mesi potrebbe essere messo in vendita uno di questi antidoti che, secondo le previsioni, dovrebbero essere anche molto economici (l’enzima è già prodotto industrialmente e ha numerosi altri impieghi) e facilissimi da gestire.
fonte: www.ilfattoalimentare.it
=> Seguici su Blogger
=> Seguici su Facebook
L’omicidio è reato, ma non il biocidio : lo stato dell’arte nell’era della transizione ecologica.
In questi giorni mi scrivono per comunicarmi indignazione e rabbia per un uso vigliacco di prodotti agricoli che causano la morte degli esseri viventi.
“Cosa sta facendo!” un’amica carissima dalla provincia di Bari mi racconta l’ennesimo teatro innaturale. Un vicino sta vaporizzando del veleno su un ciglio del suo campo, ciglio che confina con il suo.“Sto disseccando, ma non si preoccupi: lo faccio qui mica nel suo terreno.”
“Ma è un pesticida!”
“No, è un disseccante” ribatte costui. Se la cortesia precede l’arguzia, la mia amica si auto-colloca nella riserva dei panda.
Quell’enclave di cittadini consapevoli che non accettano un futuro già segnato e non possono più capire l’ottusa routine dell’agricoltura moderna.
Veniamo al punto. Pochi giorni fa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha definitivamente vietato l’uso dei neonicotinoidi.
Si tratta di un momento storico, considerando che la battaglia legale è durata 8 anni.
Per capire questa posizione definitiva dobbiamo risalire ad un altra sentenza, del 30 novembre 2020, in cui la Corte dei conti europea obbliga l’EFSA ad esprimere pareri chiari in merito all’uso dei pesticidi e all’applicazione del principio di precauzione ma sopratutto obbliga la Commissione Europea a rispettare il parere dell’EFSA ed approvare l’uso dei formulati in agricoltura solo se se sicuri. Dalla storia recente degli ultimi 5 anni, più del 50% dei formulati sono stati approvati con procedure di emergenza.
Come apicoltore ricordo bene la storia delle decisioni dei governi italiani in questi ultimi 10 anni in merito all’uso di pesticidi tra cui erbicidi, disseccanti, fungicidi, acaricidi, talpicidi, battericidi, nematocidi, insetticidi, molluschicidi ed altre categorie.
L’italia è uno dei paesi europei che usa maggiormente i pesticidi, secondo ISPRA erbicidi insetticidi e fungicidi sono disciolti nel 67% dei campioni delle acque superficiali e nel 33% di quelle sotterranee. L’Europa è anche forte nell’Export di pesticidi nei paesi extra UE che producono poi i cibi che ritornano in Italia.
Questo movimento, che nutre e costituisce l’ossatura del mercato libero globale, è fatto di pesticidi.
Pesticidi che si muovono tra nazioni, veleni che scorrono nelle arterie delle nostre regioni e finiscono nel mare.
I danni si possono sintetizzare in 3 tipi. Danni irreversibili al suolo e al mare. Significa dover dipendere da altra chimica, inseguendo per sempre soluzioni inefficaci per ‘correggere’ la terra, essendo incapace di nutrire. Danni alla salute degli esseri viventi. Significa far cadere la sanità pubblica, a causa di malattie gravi anche letali, il cui nesso pesticida-malattia sta emergendo sotto traccia grazie alla ricerca scientifica. Danni al comparto agricolo e all’export italiano. Significa infine ridisegnare la geografia agricola, nella prospettiva peggiore in cui perdere l’identità della produzione italiana.
Sostenere di voler rispettare le regole di buon vicinato pensando che il disseccante agisca solo nel proprio fondo, è quasi ironico.
Analizzando le api nell’astigiano, grazie all’ultimo servizio pubblicato su LAPIS (aprile/maggio 2021) scopriamo un apicoltore professionista si è dedicato a sue spese ad effettuare le analisi del miele che produceva. In questi anni ha rilevato presenze di Flonicamid in concentrazione di 129 ppb in ambiente frutticolo (il quale esplica una tossicità acuta già a 53,3 milionesimi di grammo per ape). Poi la Cipermetrina a una concentrazione pari a 1153 ppb in ambiente vinicolo (che esplica una tossicità acuta già a 0,4592 milioni di grammo per ape). Come fungicida ha rilevato Folpet e Phtalimide che hanno superato insieme i 34’000 ppm (tali formulati esplicano una tossicità acuta già a 10 microgrammi per ape).
Ma venendo al glifosato dalle analisi effettuate ha riscontrato una concentrazione pari a 792 ppb. L’apicoltore ha affermato di aver trovato tracce di glifosato anche nel miele di alveari a più di 900 metri s.l.m.
Tutto questo deve farci riflettere, al netto delle centinaia di campagne sull’ambiente, sul fatto che il veleno che viene applicato nelle nostre campagne non resta mai confinato nel perimetro della propria parcella ma corre e lo fa velocemente.
Vietare imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam, una categoria di veleni certamente la più abusata e pericolosa, è una parziale vittoria.
Considerando che ci sono voluti molti anni per una sentenza come questa, a fronte di sospensioni (e quasi mai divieti) dei rispettivi stati membri Italia compresa, ci troviamo davanti ad una sfida ancora più grande.
E’ una sfida culturale, rivolta a noi tutti. Non possiamo aspettare altri dieci o vent’anni per veder vietare altre 3 molecole, rispetto alle centinaia di formulati che vengono immessi nel mercato, di cui bastano pochi microgrammi per creare danni incalcolabili.
Se non vogliamo perdere la nostra campagna e il primato della nostra identità, e se vogliamo stare in salute non possiamo sperare in ulteriori divieti.
Dobbiamo cambiare a monte il problema. E cioè cambiare il modo di fare agricoltura.
C’è una moltitudine di persone in Europa che ci crede, e dobbiamo prendere questa sentenza come un segnale forte, incontrovertibile di una possibilità di farcela. Contro i poteri forti e le lobbies della produzione agricola intensiva e contro le politiche che garantiscono ai contadini solo debiti e fatiche, il 2021 segna un punto a favore della terra e della sovranità alimentare.
La sfida è culturale perchè istituzioni, scuole, famiglie devono riaffermare le competenze e lo spirito di coltivare la terra senza scorciatoie perchè -lo ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea- le scorciatoie uccidono.
*Guido Cortese . Apicoltore
fonte: vociperlaterra.it
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Stop pesticidi, lettera aperta di “Salviamo le api” ai decisori italiani. Firmiamo l’appello europeo
L’agricoltura europea sta raggiungendo un vicolo cieco. Le politiche agricole che erano orientate unilateralmente verso l’aumento dei raccolti incrementando l’uso di prodotti chimici tossici hanno portato l’ecosistema sull’orlo del collasso. Le conseguenze per la natura sono disastrose: api, farfalle e altri insetti stanno scomparendo dai nostri paesaggi e uccelli precedentemente diffusi hanno smesso di cantare nei nostri campi. I nostri torrenti e fiumi vengono inquinati e siamo esposti a un cocktail quotidiano di pesticidi sintetici attraverso il nostro cibo. L’eliminazione graduale dei pesticidi sintetici è quindi il prerequisito fondamentale e la leva più forte per la transizione dall’attuale modello agricolo ad alta intensità di input a un modello di miglioramento della biodiversità basato su cicli naturali.
Le associazioni italiane aderenti all’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “Salviamo Api e Agricoltori” hanno inviato una lettera ai decisori politici per ricordare gli impegni dell’Italia per la riduzione dell’uso dei pesticidi. La Commissione Europea ha fissato col Green Deal l‘obiettivo di ridurre l’uso dei pesticidi del 50% entro il 2030. Ma questo obiettivo è sotto attacco da parte dell’industria, di lobby e corporazioni. Nella lettera – ricorda Help Consumatori – le associazioni sostengono che «la biodiversità, in particolare quella delle api e di altri impollinatori negli ecosistemi agricoli, è in drastico calo sia in Italia che in Europa e nel mondo. E sottolineano che una delle cause di questo declino è proprio l’uso dei pesticidi chimici in agricoltura.
Nel testo, la coalizione composta da decine di associazioni, chiede dunque ai decisori politici «di assumere posizioni ed iniziative coraggiose e lungimiranti per rafforzare gli obiettivi delle due Strategie UE “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030”.Bisogna adottare piani e programmi nazionali coerenti, recuperando i gravi ritardi nell’aggiornamento del Pan pesticidi, nella redazione del Piano strategico nazionale della PAC post 2023 e nell’approvazione della Legge nazionale per l’agricoltura biologica. Tutti strumenti indispensabili per proteggere gli impollinatori, l’agricoltura, l’ambiente e la salute dei cittadini».
Il coordinamento italiano di “Salviamo le api ” ricorda, nella lettera inviata ai ministri e ai decisori competenti in materia di regolamentazione dell’uso dei pesticidi, che «il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è scaduto nel febbraio 2018 e il nuovo testo presentato per la consultazione pubblica nel 2019 è stato superato dagli obiettivi delle Strategie UE “Farm to Fork” e “Biodiversità” che indicano il traguardo della riduzione del 50% dell’uso dei pesticidi in Europa entro il 2030».

La petizione “Salviamo le api e gli agricoltori” – continua Help Consumatori – si può firmare fino a giugno. Se l’ICE avrà successo raccogliendo 1 milione di firme, la Commissione Europea sarà legalmente tenuta ad esaminare le richieste avanzate e proporre atti legali vincolanti per gli Stati membri per l’implementazione degli obiettivi delle Strategie UE “Farm to Fork” e “Biodiversità”. Oltre 533 mila cittadini europei (di cui 20 mila italiani) hanno sottoscritto l’ICE “Salviamo Api e Agricoltori”, sostenuta da oltre 250 organizzazioni in tutta Europa, e la raccolta di firme continuerà fino al prossimo mese di giugno. L’eliminazione graduale dei pesticidi sintetici è quindi il prerequisito fondamentale e la leva più forte per la transizione dall’attuale modello agricolo ad alta intensità di input a un modello di miglioramento della biodiversità basato su cicli naturali
La raccolta delle firme è importante per sollecitare gli Stati membri dell’Unione Europea ad elaborare Piani d’Azione Nazionali con obiettivi concreti per ridurre significativamente l’uso di pesticidi nei prossimi anni e trasformare l’obiettivo del 50% di riduzione dell’uso di pesticidi fissato dalle strategia “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030” in una norma vincolante per i Governi nazionali. Per firmare clicca qui.
fonte: www.ilfattoalimentare.it
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Salvare le api, un progetto europeo nato a Venezia. 3,2 milioni di euro per prati, siepi e bordure fiorite
Gli insetti impollinatori sono fondamentali per la produzione della maggioranza delle specie vegetali e quindi per l’agricoltura, ma oggi sono a rischio di estinzione. Un problema legato al degrado ambientale e alla scomparsa degli habitat naturali di questi insetti, che secondo la piattaforma intergovernativa su biodiversità e servizi ecosistemici (Ipbes) riguarda oltre il 40% delle specie, principalmente api e altri imenotteri (vespe o api selvatiche) o farfalle. Per il momento si cerca di rimediare con progetti internazionali come LIFE Biodiversità PollinAction, della durata di cinque anni coordinato dall’Università di Venezia.
“Esistono varie categorie di insetti impollinatori”, spiega Emilio Guerrieri, dirigente di ricerca presso l’istituto per la Protezione sostenibile delle piante del Cnr, “tra le più importanti gli imenotteri, quali api, vespe e simili, i ditteri quali mosche e simili e i lepidotteri ossia le farfalle diurne”. Sono però gli imenotteri a essere i principali impollinatori – approssimativamente in una percentuale intorno al 50%, seguiti rispettivamente dagli altri due gruppi al 30 e al 20% – e quindi quelli più a rischio. “La criticità è legata a diversi fattori – spiega Guerrieri – l’uso di insetticidi ad ampio spettro di azione, il cambiamento climatico che influisce sulla quiescenza, il riposo nei mesi freddi, che possiamo paragonare al letargo e la perdita di biodiversità vegetale, cui si aggiungono altri elementi di stress come i parassiti delle api”.
Eventi che mettono in crisi un meccanismo naturale di straordinaria efficienza, che offre alle piante importanti vantaggi genetici: “Gli insetti bottinano i fiori per il nettare di cui si nutrono, e in questo modo si sporcano di polline che trasportano da pianta a pianta”, spiega Guerrieri. Tra poco questo potrebbe non essere più possibile, come mostrano dati preoccupanti sulla moria di insetti, soprattutto api, con la conseguente riduzione della produzione di miele, ma soprattutto con gravi conseguenze per le coltivazioni. “In Cina ho visto frutteti in cui i fiori di pero erano impollinati a mano da braccianti agricoli, uno per uno”, ricorda Guerrieri. “Uno scenario apocalittico che non è così lontano da noi, anche se ora anche lì si sta cercando di portare l’agricoltura verso una maggiore sostenibilità”.
Ed è in questa direzione che si muove LIFE “Biodiversità” PollinAction, coordinato dalla botanica Gabriella Buffa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e avviato dal mese scorso con un budget di 3,2 milioni di euro e dieci partner tra l’Italia e la Spagna. Un programma di azioni finalizzate a invertire questa tendenza, recuperando gli habitat naturali di questi insetti; “Prima di tutto i prati da sfalcio, a vegetazione spontanea e quindi ricchi di biodiversità, che una volta erano un elemento essenziale del sistema agicolo da cui si ricavava il fieno per il bestiame, ma che oggi stanno scomparendo a causa dell’urbanizzazione e di un’intensificazione dell’agricoltura”, osserva Buffa. Questi prati garantiscono fioriture prolungate, dove gli insetti possono trovare nutrimento durante tutta la stagione; i coltivi hanno invece cicli più brevi, con fioriture sincrone, come ad esempio i frutteti, o hanno diversi sistemi di impollinazione come i cereali, privando api e altri insetti della possibilità di nutrirsi.
Con quali conseguenze? “Uno degli obiettivi del progetto è di quantificare la situazione”, spiega la botanica. In Europa e in altri paesi ci sono molti dati sulla perdita di insetti, mentre della situazione italiana sappiamo poco, e anche il report europeo del 2017 sulle iniziative dei diversi stati europei a tutela degli impollinatori non menziona neppure l’Italia. Anche se ci sono forti segnali di allarme, come la notevole riduzione della produzione di miele, che nel 2019 si è praticamente dimezzata.
L’obiettivo del progetto europeo è quello di realizzare infrastrutture “verdi” che favoriscono la presenza di specie vegetali adatte agli insetti. “Lavoreremo con modalità diverse”, spiega Buffa, “in Spagna puntiamo a recuperare terreni abbandonati, mentre in Italia i nostri interventi sono concentrati in aree della Pianura Padana orientale, fortemente antropizzate e dove è diffusa l’agricoltura meccanizzata“. Nel progetto sono coinvolti sei comuni, due apicoltori in Spagna, sei aree ad agricoltura estensiva in Friuli-Venezia Giulia e il Passante di Mestre oltre ad alcune aziende agricole appartenenti al circuito di EcorNaturasì, produttore e distributore di alimenti biologici e biodinamici. “Cerchiamo di dimostrare che si può fare economia utilizzando il territorio in modo sostenibile”, spiega Buffa, “in Italia stiamo creando una filiera per valorizzare la produzione di latte e formaggio da animali alimentati col fieno ricavato dallo sfalcio dei prati, per valorizzare la competitività delle aziende agricole che mettono a disposizione il terreno per il progetto”.
In altre aree, come le scarpate del passante di Mestre, è prevista invece la realizzazione di prati, siepi e bordure fiorite: “Interventi di questo tipo sono molto diffusi in altri paesi, come la Gran Bretagna”, spiega Buffa, “e oltre a rendere più gradevole il paesaggio offrono agli insetti piccole aree attraverso le quali spostarsi“. Il progetto prevede la conversione di 200mila metri quadrati di seminativi in prati fioriti, oltre al miglioramento di 2,6 milioni di m2 di praterie esistenti, e alla realizzazione di 3,5 chilometri di siepi e di corridoi ecologici su trenta chilometri di strade.
fonte: www.ilfattoalimentare.it
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
A Torino una vecchia fabbrica si trasforma in orto urbano per le api

Nel bel mezzo del quartiere di Mirafiori sud, circondata da palazzi ed edifici industriali sorgerà una nuova casa che, a differenza di quelle del circondario, avrà delle ospiti d’eccezione: le api. Ci troviamo in via Onorato Vigliani e proprio qua si trova un vecchio complesso abbandonato, precedentemente adibito alla meccanizzazione agricola e ora in fase di riconversione, che ci dimostra come anche le zone più industriali possono diventare un luogo dove la natura riconquista i suoi spazi.
Tutto questo grazie al contributo di Elena Carmagnani ed Emanuela Saporito, fondatrici di Orti Alti, associazione che, come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo, stanno diffondendo a Torino la cultura del verde, attraverso la realizzazione di orti urbani sui tetti di edifici e palazzi.
Qui sta nascendo Orto Wow, con uno speciale giardino in cassoni per piante impollinatrici, un tetto verde coltivato a prato naturale e un grande apiario, per diffondere l’apicoltura nelle nostre città. Il pezzo forte del progetto è il “pollinator garden”, un giardino formato da 16 cassoni in legno disposti a creare percorsi e zone di sosta. Come ci spiegano Elena ed Emanuela, «In questi cassoni è in corso la semina e la piantumazione di piante mellifere, ovvero piante che, insieme al tetto verde, costituiranno il “pascolo” delle api e di altri insetti impollinatori».
Le piante mellifere coltivate, definite in collaborazione con il dipartimento di agronomia dell’Università di Torino, prevedono la semina di molteplici varietà di piante molto apprezzate dalle api come salvia, calendula, tarassaco, borraggine, papavero, senape selvatica, giglio, fiordaliso e iperico, oltre che il trapianto di timo, erba cipollina e menta. «Al suo interno si sperimenta l’utilizzo del “new soil”, un nuovo suolo rigenerato e creato per inserire terreno fertile nei parchi urbani che sono nati dall’abbandono di aree industriali, spesso di scarsa qualità e inadatto a qualsiasi uso».

La realizzazione di Orto Wow rientra nell’ambito di ProGiReg, un progetto europeo finalizzato a sperimentare soluzioni “nature based” per la rigenerazione urbana e sociale delle città. Questi primi interventi infatti vanno nella direzione di avviare la riqualificazione di un complesso abbandonato che può essere rigenerato a partire da una sua nuova vocazione green.
L’apiario è poi parte integrante del progetto e sarà curato dall’associazione Parco del Nobile che da molti anni si occupa di apicultura urbana. L’integrazione dell’allevamento di api per la produzione di miele urbano con la realizzazione di orti e giardini melliferi è fortemente perseguita da OrtiAlti in molte sue realizzazioni. Come ci viene spiegato da Elena ed Emanuela, «Le piante mellifere si combinano perfettamente con le piante orticole e nel caso dell’Orto Wow l’inserimento delle attività di apicultura rientra anche in un programma di Science Education che riguarda tutto il progetto. Inoltre, la presenza del mercato dei produttori di Coldiretti che qui si svolge, può essere messa in relazione con la produzione del miele WOW per innescare micro-economie di quartiere».

La fabbrica dismessa diventerà in questo modo un vero e proprio corridoio ecologico per favorire nuove connessioni e contribuire a riequilibrare gli ecosistemi naturali. Come ci viene spiegato, «Un corridoio ecologico è un’area verde studiata per preservare specie di animali e di piante, permettendo il passaggio graduale di animali e semi da un habitat all’altro. La possibilità di realizzare queste infrastrutture verdi all’interno delle città è fondamentale poichè permette di ripristinare la biodiversità biologica, cioè la variabilità di tutti gli organismi viventi e degli ecosistemi di cui fanno parte».
E saranno proprio gli abitanti del quartiere a prendersi cura e a mantenere il pollinator garden, occupandosi dei cassoni e dell’area dedicata all’orto, utilizzando lo spazio verde per lo svolgimento di attività ludiche. Il tutto grazie alla Fondazione Mirafiori che a pochi passi gestisce la Casa nel Parco, casa del quartiere di Mirafiori sud.

«Purtroppo la situazione Covid ha impedito di partire con il calendario di attività programmate da questo giugno e le iniziative sono state rinviate alla prossima primavera. Intanto però è iniziato un lavoro per la proposta di un patto di collaborazione per la cura dell’area che mette insieme la Fondazione Mirafiori, l’associazione Parco del nobile (che si occupa delle api), Coldiretti e un gruppo informale di cittadini appassionati di api e biodiversità che si chiama Comunità degli Impollinatori Metropolitani».
L’obiettivo è di arrivare nei prossimi mesi alla firma di un patto con la Città per la gestione del giardino in cassoni, avendo a disposizione anche dei locali dell’edificio dove svolgere attività formative intorno ai temi della biodiversità e dell’apicultura urbana.
fonte: https://www.italiachecambia.org
#RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Il futuro dipende (anche) dalle api
Coldiretti ha già annunciato che, secondo le elaborazioni su dati Isac-Cnr relativi al mese di dicembre e gennaio, fino ad ora in Italia la temperatura è stata superiore di 1,65 gradi rispetto alla media storica. Le gelate di un inverno tardivo sarebbero nefaste tanto per i fiori sbocciati in anticipo quanto per gli insetti e potrebbero mettere in difficoltà diverse produzioni. Ma questo non è di certo il primo caso: già durante lo scorso 2019 infatti gli apicoltori toscani hanno registrato una perdita di produzione di miele pari a circa l’80%.
Dall’alveare alla vigna: l’agricoltura resiliente affronta il clima che cambia

Abbiamo perso 10milioni di alveari in soli 5 anni e la colpa è nostra
Dati che fanno rabbrividire: negli ultimi cinque anni, nel mondo sono scomparsi 10 milioni di alveari. Quasi 2milioni l’anno e 200mila solo in Italia. Le api sono gli esseri viventi più importanti della Terra, eppure sono a pieno titolo tra le specie a rischio estinzione.
“Se non si interviene subito e in maniera integrata, presto le varietà di miele, così come ortaggi e frutta, saranno sempre più scarsi, o non disponibili, in primis nei mercati contadini dove gli agricoltori portano ogni giorno tipicità e biodiversità – ha spiegato il presidente nazionale de ‘La Spesa in Campagna’, Matteo Antonelli-. Bisognerà comprare a prezzi più alti per avere prodotti di qualità e stare sempre più attenti alla provenienza”.
Isde: Coalizione di 90 associazione in 17 paesi europei lanciano raccolta firme ICE (Iniziativa Cittadini Europei) per vietare pesticidi, trasformare agricoltura e salvare natura
- Ridurre gradualmente ed eliminare i pesticidi di sintesi: eliminare gradualmente l’80% delle sostanze chimiche di sintesi nell’agricoltura europea entro il 2030, a cominciare dai più pericolosi, affinché l’agricoltura diventi libera al 100% dai pesticidi entro il 2035.
- Ridare spazio alla Natura e fermare la perdita di biodiversità: ripristinare gli ecosistemi naturali nelle zone agricole affinché l’agricoltura diventi un fattore di recupero e non la principale causa della perdita di biodiversità in Europa.
- Sostenere gli agricoltori nella transizione ecologica del settore primario: riformare la Politica Agricola Comune dando priorità all’agricoltura su piccola scala, diversificata e sostenibile, promuovendo un rapido aumento delle pratiche agroecologiche e biologiche, la formazione e la ricerca scientifica indipendente per una agricoltura senza pesticidi e OGM.
Patrizia Gentilini, Responsabile Agricoltura di ISDE Italia ha dichiarato: “Il prezzo che stiamo pagando per questa agricoltura di morte basata sulla chimica di sintesi è folle. Questi veleni distruggono non solo la fertilità dei suoli e la biodiversità, ma anche la nostra salute e soprattutto quella dei bambini e delle bambine. Questi veleni, presenti nel nostro corpo, sono causa di patologie cronico degenerative, quali cancro, obesità, diabete, infertilità, malattie cardiologiche, della tiroide e del sistema nervoso. E questi rischi si documentano anche per esposizione residenziale nei bambini in cui aumentano deficit cognitivi, autismo, malformazioni e tumori. Il modello agricolo industriale è fallito, non possiamo più perdere tempo e dobbiamo imboccare la strada dell’agroecologia, l’unica strada che può ridare vita e salute al Pianeta e alle Persone”.Helmut Burtscher, esperto di pesticidi e prodotti chimici di Global 2000/Friends of the Earth Austria ha dichiarato: “Solo un’agricoltura sostenibile e priva di pesticidi può garantire l’approvvigionamento alimentare delle generazioni presenti e future e fornire risposte alle crescenti sfide poste dal cambiamento climatico. Inoltre, contribuisce alla conservazione della biodiversità e riduce le emissioni di gas serra. Una politica agricola europea responsabile deve quindi promuovere l’ulteriore sviluppo di metodi agroecologici e sostenere gli agricoltori nella loro transizione verso una produzione senza pesticidi“.Veronika Feicht dell’Istituto per l’ambiente di Monaco di Baviera ha dichiarato: “Stiamo portando la lotta contro i pesticidi sintetici a livello europeo, dando ai cittadini di tutta Europa che chiedono un nuovo sistema agricolo la possibilità di esprimersi con una sola voce. I cittadini reclamano un sistema che non danneggi la biodiversità e gli ecosistemi, che non metta a dura prova la salute dei consumatori, ma che invece garantisca il sostentamento per api e agricoltori ed sia più sano per le persone. Con la nostra iniziativa ci impegniamo a fare di questo tipo di agricoltura una realtà in tutta Europa“.François Veillerette, direttore di Générations Futures, ha dichiarato: “Invitiamo i cittadini europei a sostenere massivamente questa iniziativa per una graduale rapida eliminazione di tutti i pesticidi sintetici nell’UE. Speriamo che milioni di persone si uniscano presto alle nostre richieste di vietare i pesticidi, trasformare l’agricoltura, sostenere gli agricoltori nella transizione e salvare la biodiversità“.