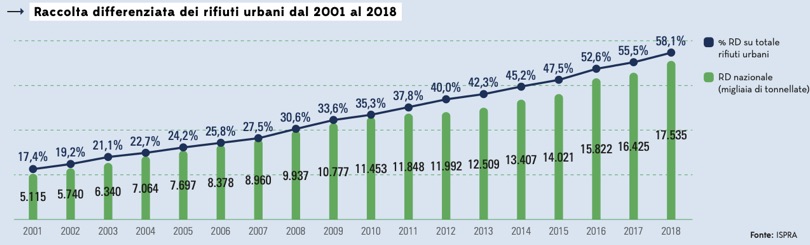In tutta l'Unione europea (UE), l'aumento dell'elettricità da fonti rinnovabili come il solare fotovoltaico (FV), l'eolico e le biomasse, entro il 2018, ha ridotto significativamente le emissioni di gas serra.
La valutazione si basa su due report tecnici in cui EEA presenta un'analisi dettagliata del ciclo di vita dei cambiamenti globali negli impatti ambientali complessivi associati alle tendenze del mix energetico dell'UE tra il 2005 e il 2018, in particolare il passaggio a quote crescenti di elettricità prodotta da fonti rinnovabili.
Per la maggior parte delle categorie di impatto esaminate, il passaggio dai combustibili fossili alle fonti di elettricità rinnovabile negli Stati membri dell'UE ha portato a chiari miglioramenti nel 2018 rispetto al 2005. Ciò è dovuto al fatto che l'intensità dell'impatto della generazione di elettricità da combustibili fossili è significativamente maggiore di quella della energia rinnovabile. Pertanto, i potenziali di impatto del ciclo di vita sono stati inferiori per l'eutrofizzazione, la formazione di particolato e l'acidificazione nel 2018 rispetto al 2005, mentre i potenziali di impatto legati all'ecotossicità e all'occupazione del suolo sono leggermente aumentati.
Il briefing mostra anche che il monitoraggio e le azioni mirate possono aiutare a minimizzare alcuni effetti negativi di questa transizione, in particolare quelli riguardanti l'ecotossicità dell'acqua dolce e l'occupazione del suolo.
Le azioni dovrebbero concentrarsi sulla riduzione degli impatti legati all'approvvigionamento di materiali e ai processi di produzione attraverso varie catene di approvvigionamento (ad esempio per moduli solari fotovoltaici e combustibili da biomassa), insieme a miglioramenti nell'efficienza energetica e delle risorse.
Poiché i progetti di elettricità rinnovabile sono destinati a crescere, la valutazione di altri potenziali impatti, come quelli che interessano gli habitat e gli ecosistemi, sarà essenziale per contenere gli impatti futuri.
Gli ultimi dati disponibili mostrano che la quota di energia rinnovabile a livello dell'UE nel 2019 era inferiore di meno di mezzo punto percentuale rispetto all'obiettivo vincolante del 20% per il 2020.
Con il 34% di tutta la produzione di elettricità, l'elettricità rinnovabile è quasi raddoppiata dal 2005 e il carbone non fornisce più la maggior parte dell'elettricità dell'UE. Tuttavia, i combustibili fossili producono complessivamente più elettricità (38% di tutta la produzione nel 2019) rispetto alle fonti rinnovabili.
Con gli impianti basati sulla combustione che dominano il mix energetico, il settore elettrico dell'UE è responsabile di quasi un quarto di tutte le emissioni di gas serra dell'UE.
La piena attuazione dei piani nazionali per il clima e l'energia per il 2030 consentirebbe all'UE di superare i suoi attuali obiettivi per il clima e le energie rinnovabili per il 2030.
Tuttavia, tali progressi sono ancora insufficienti per raggiungere un obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 o per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'energia rinnovabile dovrebbe crescere fino a oltre l'80% entro il 2050 per rispettare questi impegni.
Questo briefing si basa sui rapporti
A life cycle perspective on the benefits of renewable electricity generation
Renewable energy in Europe 2020 — recent growth and knock-on effects
Sono inoltre disponibili informazioni sulle politiche e misure nazionali in materia di energia rinnovabile in Europa e sui progressi verso il raggiungimento degli obiettivi energetici.
I dati sulle emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici sono disponibili in visualizzatori di dati dedicati sul sito EEA.
fonte: www.arpat.toscana.it
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria