
In Umbria c’è un ‘Repair café’ e cerca casa, ecco di cosa si tratta

Aperte iscrizioni agli Stati Generali della Green Economy 2021, in presenza a Rimini 26 e 27 ottobre
Ecosistemi in Costituzione

Se la proposta dovesse passare in aula al Senato, sarebbe la prima volta che il Parlamento propone di modificare la prima parte – quella dei principi – della Carta del ‘48. Segno evidente di una maturata sensibilità in tema ambientale che ha raggiunto i vertici delle istituzioni. L’iter, comunque, sarà lungo (doppia lettura in Camera e Senato, eventuale referendum confermativo) e alcune forze politiche (tra cui la Lega) hanno già il mal di pancia.
É ben vero che l’inserimento della tutela della salute potrebbe apparire pleonastico (l’Articolo 32 esiste già) e che gli orientamenti della Corte costituzione includono già la tutela dell’ambiente naturale all’interno del più ampio significato di “paesaggio”. Ma non sempre è facile per i movimenti ecologisti raggiungere in giudizio la Suprema corte e non sempre si sono ottenuti pronunciamenti favorevoli. Il nuovo articolato, quindi, rafforza il principio della tutela degli ecosistemi naturali riconoscendone esplicitamente il loro valore fondamentale per il bene comune del paese. E ciò non può che fare piacere, poiché incoraggia a promuovere una legislazione ambientale più avanzata in un paese massacrato da una industrializzazione e da una urbanizzazione scellerata. Così come fa molto piacere il riconoscimento degli animali non umani e quello delle generazioni future. Non sono quindi solo gli aventi diritto al voto i “sovrani” al potere, ma anche tutti gli esseri viventi, presenti e futuri, con cui va condiviso il mondo.
C’è da rallegrarsi anche del non accoglimento da parte della maggioranza della Commissione affari costituzionali del Senato della proposta, più volte caldeggiata dal neoministro Enrico Giovannini e dalla sua associazione ASviS, di introdurre in Costituzione l’ambiguo sintagma dello “sviluppo sostenibile”, che avrebbe concesso una dignità persino costituzionale alle discutibili pratiche della green economy. Un grazie, doveroso, alla senatrice Loredana De Petris che da qualche decennio ha insistito per adeguare la Carta del ’48 alle nuove evidenze e responsabilità ecologiche.
Ci si potrebbe invece rammaricare del mancato esplicito riconoscimento legale dei Rights of Nature. “Il movimento per i diritti della natura sta crescendo – scrive il Right-of-Rivers-Report, redatto da diversi istituti di ricerca: Cyrus R. Vance Center for International Justice, Earth Law Centere International Rivers – È guidato da popoli indigeni, società civile, esperti legali, e giovani, che chiedono una riforma sistemica del nostro modo di rapportarci con la natura”. La Natura viene intesa come soggetto dotato di “personalità giuridica” (esattamente come lo è un ente economico o una società di persone) portatore di diritti ad esistere, evolvere e prosperare. Diritti che possono essere difesi in tribunale tramite organismi di tutela (amministratori, piuttosto che proprietari) composti da gruppi di persone o da enti che hanno questo obbligo legale. Il salto logico e filosofico, etico e politico è evidente. Si tratta di passare dal diritto degli umani ad avere un ambiente salubre, al diritto della natura, in quanto tale, a rigenerarsi. Un passaggio di approccio dall’antropocentrismo all’ecocentrismo.
Esistono ormai esperienze di “costituzionalizzazione” dei diritti di particolari ecosistemi (bacini fluviali, laghi, foreste, montagne…) in molte parti del mondo. Non solo in Sua America (con Ecuador e Bolivia apripista), ma in vari paesi dell’Oceania, in Asia (India, Bangladesh e Filippine), Nord e Centro America (Stati Uniti Stati Uniti, Costa Rica e Messico) e Africa (Uganda). Certo, la giurisprudenza dei diritti della natura è ancora agli inizi, ma è sicuro che solo se i nostri “stati di diritto” sapranno compiere questo salto culturale epocale inclusivo degli animali non umani e del vivente in generale (come lo è stato con l’abolizione della schiavitù o con i diritti politici delle donne) sarà possibile preservare i cicli vitali del pianeta dalla “macro criminalità di sistema”, per usare le parole di Luigi Ferrajoli, e pensare a una vera Costituzione della Terra (www.costituenteterra.it).
fonte: comune-info.net
=> Seguici su Blogger
=> Seguici su Facebook
Nuova vita per la plastica in mare che diventa montatura di occhiali
L'innovazione di Sea2See, brand di occhiali da vista e da sole che fa della circolarità la sua bandiera
Dal mare agli occhi. Non è il titolo di una poesia romantica, quanto piuttosto il principio fondante di Sea2See, brand che produce montature per occhiali, da vista e da sole, interamente con plastica recuperata dal mare: un progetto di business sostenibile in un’ottica del tutto circolare dei consumi, con riguardo all’ambiente.
L’impatto ambientale del settore ottico
François van den Abeele, fondatore di Sea2see, ricorda che l’industria della moda è la più inquinante al mondo, subito dopo quella petrolifera. Nel settore ottico - parte integrante del mondo fashion - l'attenzione alla sostenibilità è quasi inesistente: i rifiuti prodotti dalle montature in acetato degli occhiali vecchi hanno un altissimo impatto, soprattutto in virtù del fatto che ogni paio di occhiali è prodotto con materie prime (plastiche) nuove. A ciò si aggiunga che circa il 50% della popolazione porta occhiali da vista. L’idea alla base di Sea2See è unica nel tuo genere e punta a invertire questo trend, conciliando business e tutela ambientale e impattando positivamente anche su un'altra dimensione lavorativa, quella dei pescatori che hanno la possibilità di arrotondare lo stipendio raccogliendo rifiuti dal mare.
Dal rifiuto alla nuova vita
Il team di Sea2see si occupa infatti di recuperare rifiuti dal mare in un’ottica circolare, trasformando così in risorsa ciò che è stato trattato come uno scarto: l’azienda si occupa di tutto, dalla raccolta alla produzione, che avviene in Italia. François spiega che i materiali vengono raccolti nei porti di Spagna e Francia grazie a centinaia di pescatori attivi sulle coste di Ghana e Senegal. I pescatori, oltre a svolgere il proprio lavoro, ricevono uno stipendio extra per il recupero di materiali plastici che vengono devoluti all’azienda. Ogni mese Sea2See raccoglie circa 15 mila kg di rifiuti plastici dai mari.
Il punto di forza del brand è la capacità di recupero del materiale dai rifiuti marini, anziché l'acquisto di materie prime ex novo. La plastica, infatti, in virtù della propria resistenza, è un materiale che non si biodegrada mai: affinché un materiale si biodegradi è infatti necessario che esista un batterio in grado di trasformarlo in un altro materiale, ma per la plastica non c'è nulla di simile. La plastica si limita a degradarsi, nei decenni, nelle cosiddette microplastiche, pericolose sia per gli ecosistemi marini sia per l'alimentazione umana. La superficie di queste microplastiche, infatti, è particolarmente idonea a intrappolare tossine che vengono rilasciate all’interno del corpo dei pesci che le ingeriscono e di cui noi ci nutriamo.
Ed è qui che entra in gioco Sea2See. Togliendo materiale plastico dal mare e dandogli nuova vita e nuovo utilizzo, favorisce non solo la circolarità e la sostenibilità in un ambito che ne era privo, ma anche la salubrità di mari, acque e animali. Un modo etico, innovativo e visionario di fare business pensando anche al domani, un valido esempio di conciliare profitto e salvaguardia ambientale. Spingere il consumatore ad agire in maniera responsabile è uno strumento importante di sensibilizzazione, in questo caso per la tutela dei mari da cui dipende la vita sulla terra, ma è anche un’opportunità che sempre più aziende dovrebbero imparare a cogliere.
fonte: www.infosostenibile.it
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Idrogeno: la nuvola di vapore acqueo
Come qualunque altro gas, l’idrogeno consente una forma di stoccaggio e trasporto/trasferiento dell’energia molto efficiente rispetto a combustibili solidi o liquidi e l’interesse dei paesi europei verso la produzione ed i possibili utilizzi del “green hydrogen” sta crescendo ogni anno. Il settore marittimo dei trasporti ad esempio ha delle alte aspettative verso questo vettore energetico. Per la stessa ragione le hanno i settori industriali più energivori che necessitano di alte temperature per eseguire i loro processi produttivi, afferma l’Ing. Dina Lanzi di Snam responsabile dell’Unità di Affari “Idrogeno Tecnico” intervenuta al seminario “Idrogeno per la transizione energetica” patrocinato dalla Autorità del Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale.
Quello che sta avvenendo in Europa ma anche in Italia è che sempre maggior interesse viene rivolto a supporto dell’idrogeno come principale vettore energetico, se ne parla infatti nel Next Generation EU nei progetti PCI (Projects of Common Interest). Di recente è stata creata una catena di valore “value chain” anche per l’idrogeno così come per la microelettronica, per le batterie del settore automotive, che mira a facilitare l’ingresso dell’idrogeno come vettore energetico nel mix energetico. Nel corso del 2020 sono state presentate le strategie industriali per l’uso dell’Idrogeno ed anche in Italia a fine novembre 2020 sono state presentate le linee guida. Per tali motivi i trasportatori europei stanno lavorando insieme per costruire e mettere a disposizione la rete gas a favore di un’economia ad idrogeno.
A tale proposito l’Ing Lenzi ricorda che il materiale con cui è realizzata l’infrastruttura di trasporto per il gas è compatibile per la maggior parte dei casi anche con l’idrogeno. Si procederà a realizzare interventi specifici di adeguamento alle centrali di compressione, particolare attenzione sarà posta sulle modifiche alle attrezzature di misura. Attualmente la maggior parte dei gasdotti che si è sviluppata nel corso degli anni, per la maggior parte dei casi, è già compatibile per il convogliamento dell’idrogeno. Inoltre l’attuale rete gas è in grado di trasportare una miscelazione di gas detto “blending” composta da idrogeno e gas naturale dando la possibilità a questo nuovo vettore di essere applicato in maniera massiva su diverse applicazioni e quindi trainare una logistica ed una catena di fornitura “supply chain” particolarmente favorevole e capace nel tempo di conseguire un considerevole abbassamento dei costi di produzione e rendendo in questo modo l’idrogeno più competitivo rispetto ai prezzi dei combustibili tradizionali.
L’integrazione dei trasportatori europei TSO (Transmission System Operator) diventerebbe una spina dorsale “Back-bone” ad idrogeno puro di 6000 km estensibile poi a 23.000 km al 2040. Punto di origine di questa dorsale europea dovrebbe essere il porto olandese di Rotterdam a dimostrazione del fatto che i porti sono un punto fondamentale per lo sviluppo dell’idrogeno e questo rivela anche come le infrastrutture possano operare da elemento volano e da facilitatore per avviare e consolidare le fasi della transizione. Circa il 75% della dorsale europea deriverebbe già da quella esistente mentre solo un 25% sarebbe di nuova realizzazione.
Per il primo si tratta di lavorare per rendere disponibili tutti gli asset della rete gas per l’idrogeno e quindi le condutture “pipelines”, ma anche centrali di compressione che vuol dire studi e collaborazioni con Baker-Hughes, con Ansaldo, con Solar e con altri soggetti per avere dei turbocompressori compatibili con l’idrogeno.
Il secondo pilastro della strategia è contribuire alla nascita di un sistema/schema regolatorio per predisporre le condizioni necessarie a rendere possibile la diffusione dell’idrogeno.
Il terzo pilastro si fonda sulle leve da attivare come soggetto facilitatore in modo che tutta la catena del valore riesca ad integrarsi e ad avere un approccio di sistema che permetta la diffusione del vettore nella maniera più veloce possibile.
Quanto sopra perché SNAM è una struttura votata al trasporto e che deve allo stesso tempo cercare di mettere in contatto la produzione con l’utilizzo. L’idrogeno servirà per l’industria delle raffinerie, per gli impianti di produzione di ammoniaca, per le celle a combustibile “fuell cells” che possono essere alimentate sia a gas naturale che in blending, ma è possibile anche a idrogeno puro. Gli impianti fuell cells possono essere utilizzati come co-generatori perché in grado di produrre gas e calore anche ad esempio in ambito portuale e per il settore dei trasporti. Quest’ultimo è uno dei settori dove SNAM sta investendo maggiormente. In particolare tutte le partnership che SNAM ha fatto con ALSTOM (Alsace-Thomson) e Ferrovie dello Stato mirano appunto ad entrare in questo settore per avviare all’elettrificazione delle tratte ferroviarie Diesel che in Italia sono ancora circa il 30/40%.
In Italia e più precisamente nel Lazio il più grande Centro di ricerca dell’Enea, nei pressi del lago di Bracciano, si occupa anche di Idrogeno. “Da diversi decenni l’utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico e non solo come materia prima dell’industria di processo, è considerato come un possibile elemento chiave per la decarbonizzazione dei sistemi energetici”, scrivono i ricercatori del Dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili. L’ente è impegnato nello sviluppo di processi e tecnologie relative all’intera catena del valore dell’idrogeno, è capofila in umerosi progetti europei e ricopre ruoli di rappresentanza in diverse iniziative e tavoli tematici nazionali ed internazionali.
L’attenzione verso l’idrogeno come vettore energetico è dovuta ad alcune sue interessanti caratteristiche: è leggero, più facilmente immagazzinabile a lungo termine rispetto all’energia elettrica, reattivo, ad alto contenuto di energia per unità di massa e può essere facilmente prodotto su scala industriale. La combustione, poi, non è associata alla produzione di anidride carbonica (CO2) e non comporta quindi emissioni climalternati dirette, ma produce solo una nuvola di vapore acqueo.
fonte: www.arpat.toscana.it
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Il pericoloso ottimismo di certi economisti mainstream sul cambiamento climatico
In un recente articolo scientifico, tradotto in italiano da Rethinking Economics Italia (disponibile cliccando qui), Keen ha realizzato una rigorosa analisi critica della ricerca economica sui cambiamenti climatici sviluppata dagli economisti della scuola neoclassica, corrente di pensiero preponderante nella scienza economica.
L’economista australiano riporta nella sua analisi decenni di pubblicazioni scientifiche dei principali economisti climatici, tra i quali il premio Nobel per l’Economia 2018, William Nordhaus, evidenziandone lacune e gravi errori logici e metodologici. La superficialità nello studio delle conseguenze economiche dei cambiamenti climatici ha portato questi studiosi a una sostanziale sottovalutazione del fenomeno, e a sostenere che gli effetti negativi sull’economia causati dati cambiamenti climatici sarebbero quasi del tutto bilanciati da altrettanti effetti positivi.
Il fatto che alcuni Paesi possano risentire del cambiamento climatico più di altri è facilmente intuibile. Ma appare poco credibile che alcuni Paesi possano addirittura trarre un beneficio economico da un riscaldamento globale di 3 o 4 gradi Celsius, che secondo la maggioranza dei biologi e degli scienziati climatici rappresenta al contrario un serio pericolo per la sopravvivenza della vita sulla Terra.

Nonostante ciò, la visione di questi economisti ha predominato per anni tra coloro che avrebbero dovuto contrastare il cambiamento globale. Perfino l’IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico), l’organismo dell’Onu per il controllo e lo studio dei cambiamenti climatici, nel suo report del 2014 dava credito a molte delle ipotesi alla base della ricerca di economisti neoclassici come Nordhaus. Ipotesi, secondo Keen, totalmente sbagliate.
La maggior parte della ricerca economica sui cambiamenti climatici si basa su tre approcci. Il primo consiste nell’utilizzare le stime degli effetti dei cambiamenti climatici su diversi settori (come agricoltura o silvicultura) e calcolarne l’effetto cumulativo sull’economia. Con il secondo, invece, si ricava la relazione attuale tra Pil e temperatura, e si utilizzano tali dati per fare previsioni per il futuro. L’ultimo consiste invece nel raccogliere le opinioni di esperti con dei sondaggi.
Con due sole eccezioni, le stime degli economisti prevedono un impatto negativo molto ridotto, a volte addirittura positivo, dei cambiamenti climatici sull’economia (grafico dal report IPCC 2014, riportato nel paper)
Cosa fa Keen? Applica una logica rigorosa a ciascun tipo di approccio, evidenziandone i problemi e le contraddizioni e spiegandone le ripercussioni sulla stabilità economica globale.
Nel primo tipo di studi (stime degli effetti del clima sui vari settori), gli economisti neoclassici escludono completamente dall’analisi parti importanti dell’economia quali la finanza, i servizi e l’industria estrattiva. Settori che negli Stati Uniti rappresentano l’87% del Pil. Gli economisti mainstream giustificano questa scelta dicendo che le attività produttive in questi ambiti si svolgono al chiuso, e quindi al riparo dai cambiamenti climatici. Il problema principale di questa assunzione, secondo Keen, è che pone sullo stesso piano clima e tempo atmosferico: seguendo questa logica solo le attività svolte all’aperto come l’agricoltura o la pesca saranno dunque colpite dal cambiamento climatico. Ma l’innalzamento delle temperature globali può avere effetti imprevedibili su tutti i settori economici, colpendo ad esempio la produttività, salute dei lavoratori e l’abitabilità di intere regioni.

Gli studi che cercano invece di estendere al futuro la relazione tra Pil e temperatura non considerano i possibili eventi catastrofici che possono modificare il clima terrestre irrimediabilmente.
La terza metodologia di ricerca, infine, si basa sulla raccolta delle opinioni sul cambiamento climatico di esperti in diverse discipline. I destinatari di questi sondaggi però, secondo Keen, sono spesso economisti appartenenti ad una cerchia ristretta, che condividono opinioni simili, rendendo così questi questionari poco affidabili.
L’effetto finale di questi errori grossolani è una sistematica sottostima degli effetti che i cambiamenti climatici potranno avere sul pianeta. Le previsioni ottimistiche di questi economisti sono diffuse tra capi di Stato e all’interno di organizzazioni internazionali, e il rischio è di sottovalutare pericolosamente gli effetti dei cambiamenti climatici, non reagendo in modo e in tempo utile per prevenirne le conseguenze più catastrofiche. C’è allora da augurarsi che siano presto disponibili studi economici metodologicamente rigorosi per guidare le decisioni politiche sui cambiamenti climatici. Sono in gioco il futuro della nostra economia e quello dell’ambiente.
fonte: www.ilfattoquotidiano.it
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Dal riciclo benefici per un miliardo di euro
Più in dettaglio, il valore economico della materia recuperata grazie al riciclo è stimata in 402 milioni di euro, quello dell’energia prodotta da recupero energetico si attesta intorno a 27 milioni di euro, mentre l’indotto economico generato dalla filiera è pari a 592 milioni di euro.
Grazie al riciclo, inoltre, sono state risparmiate - sempre nel 2019 - 4 milioni e 469mila tonnellate di materia prima vergine ed evitate immissioni in atmosfera per oltre 4 milioni e 300mila tonnellate di CO2 equivalente.
Per quanto concerne l'utilizzo di risorse - sottolinea Conai - grazie al riciclo si sono risparmiate 433mila tonnellate di plastica - pari a 9 miliardi di flaconi in PET per detersivi da un litro -, 270mila tonnellate di acciaio, oltre 19mila tonnellate di alluminio, un milione e 80mila tonnellate di carta, 907mila tonnellate di legno e un milione e 760mila tonnellate di vetro.
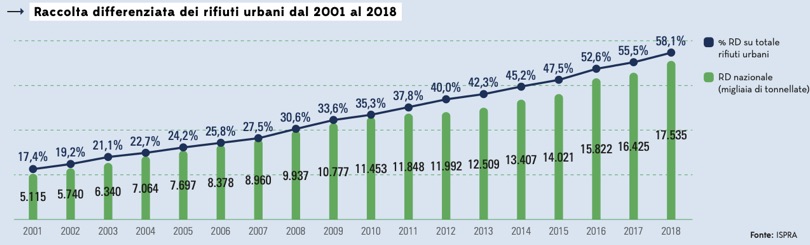
"Sono numeri che fanno riflettere - commenta Luca Ruini, Presidente di Conai -. Come ricordo spesso, l’Italia in Europa è seconda solo alla Germania per riciclo pro-capite dei rifiuti di imballaggio. Abbiamo praticamente già raggiunto gli obiettivi europei di riciclo richiesti entro il 2025, e il nostro sistema Paese continua a fare scuola in Europa. Anche perché ha uno dei sistemi di responsabilità estesa del produttore meno costosi e più efficienti". "Dobbiamo continuare a lavorare per incentivare l’eco-design e per sviluppare e potenziare le tecnologie per il riciclo, auspicando al più presto incentivi fiscali per chi usa materia prima seconda: la sua domanda sta purtroppo calando, e non possiamo permetterci di lasciare inutilizzati gli enormi quantitativi di materiale che il Paese ricicla - aggiunge il Presidente di Conai -. Ci auguriamo per questo si arrivi presto anche a una concreta attuazione del Green Public Procurement e alla chiusura di nuovi provvedimenti sull’End of Waste".
Per informazioni: Green Economy Report Conai
fonte: www.polimerica.it
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
“L’economia circolare ha bisogno di una visione utopica”. Colloquio con Cillian Lohan (Cese)

Cillian Lohan è il nuovo vice-presidente responsabile per la comunicazione del Comitato economico e sociale europeo (Cese). Nato e cresciuto in Irlanda, Lohan ha una lunga esperienza nell’economia verde, fronte società civile. Oltre al nuovo ruolo presso il Cese, è infatti anche amministratore delegato della Green Economy Foundation. Il Cese è una delle istituzioni consultive dell’Unione europea. Il Comitato prepara opinioni e pareri all’attenzione – e su richiesta – della Commissione, del Parlamento e del Consiglio europeo, esponendo gli interessi e le prospettive delle tre categorie socioeconomiche che rappresenta: sindacati, organizzazioni datoriali e terzo settore. Una delle iniziative più recenti e importanti portate avanti dal CESE in collaborazione con la Commissione europea, e inerenti l’economia circolare, è stata la costituzione, nel 2017, della Piattaforma europea degli attori dell’economia circolare, la Circular Economy Stakeholder Platform. Cillian Lohan è stato uno dei promotori della piattaforma, che ha come obiettivo accelerare la transizione verso un’economia circolare attraverso lo scambio di idee e buone pratiche tra imprese, ong, istituti di ricerca e istituzioni.
Da sapere
Il nuovo Piano d’azione della Commissione europea è stato presentato l’11 marzo del 2020 e si iscrive nel più ampio progetto del Green Deal per l’Europa (scheda informativa da scaricare). Il nuovo Piano d’azione prevede l’approvazione, a livello europeo, di 35 misure entro il 2023 (vedi Annex). Il nuovo Piano d’azione rappresenta la continuazione del primo Piano d’azione, approvato nel 2015 e composto da 54 misure legislative.
Il Rapporto OECD sull’economia circolare nelle città e regioni è stato pubblicato il 28 ottobre 2020. L’analisi si basa sui dati raccolti in 51 città e regioni che hanno contribuito al Sondaggio dell’OECD sull’economia circolare nelle città e regioni, da un lato, e sui risultati dei Dialoghi sulle politiche pubbliche sull’economia circolare che si sono svolti a Groningen (Paesi Bassi), Umeå (Svezia), Valladolid e Granada (Spagna), Glasgow (Scozia, Regno Unito) e Irlanda. Lo studio propone un compendio di buone pratiche, ostacoli e opportunità inerenti l’economia circolare, analizzati attraverso la lente analitica delle “tre P”: cittadini (people), politiche pubbliche (policy) e luoghi (places). Il rapporto propone anche una checklist e raccomandazioni utili all’implementazione di misure di governance in città e regioni che non hanno fatto parte del progetto ma che desiderano operare una transizione verso l’economia circolare (scheda informativa).
Mister Lohan, come possiamo assicurare che l’economia circolare sia posta con efficacia al centro del programma Next Generation EU, il pacchetto per la ripresa dal Covid-19?
Se si guarda alla scomposizione degli strumenti di finanziamento del Next Generation EU, si può notare come l’economia circolare giochi già un ruolo centrale. Per esempio, c’è il fondo per la giusta transizione – un volano per la transizione verso un’economia a basso consumo di carbone attraverso la produzione di energia rinnovabile – e il fondo per lo sviluppo rurale, il quale è legato alla circolarità dell’economia biologica.
Quindi tutto bene?
No. In gergo di Bruxelles, la grande sfida per l’economia circolare rimane quella di abbattere le barriere (“break the silos”, tda.) tra i diversi meccanismi di finanziamento pubblici e uffici della Commissione.
Ci sono segnali positivi? Ci stiamo muovendo in questa direzione?
La Commissione europea ha cominciato a far comunicare le differenti DG, il che è un passo importante. E anche i membri della Circular Economy Stakeholder Platform stanno cercando di abbattere queste barriere burocratiche in qualche modo.
Quindi il cambiamento è in atto?
Beh, credo che sia un cambiamento lento e graduale a livello burocratico. Ma ci sono molti ufficiali dentro la Commissione europea che stanno lavorando in maniera dinamica. Cercano di tagliare le linee di separazione, perché capiscono che tutto questo è fondamentale per l’idea di circolarità.
Basta l’azione della Commissione europea per trasformare l’Europa in un’economia circolare, secondo lei?
Dobbiamo essere chiari su questo punto. L’economia circolare implica un modo completamente diverso di organizzare i nostri sistemi economici e di produzione. Si tratta di un cambiamento imponente. Le istituzioni devono comprendere che ci sarà sempre più bisogno della collaborazione di attori meno tradizionali.
È innegabile che, in un certo senso, l’Europa abbia spinto sull’acceleratore: entro il 2023, ci sono 35 misure legislative da approvare nel quadro della Piano d’azione europeo per l’economia circolare. C’è qualche priorità che manca all’appello? E, soprattutto, tutto ciò è realistico?
Credo che sia realistico perché il precedente Piano di azione era pieno di target. Il 95% di quel monte-obiettivi è stato raggiunto. Più in generale, gli obiettivi europei vengono stabiliti per essere soddisfatti. Ma ciò non vuol dire che non ci sia stato qualche fallimento in passato.
Ovvero?
Il precedente Piano aveva un deficit di contenuti. In particolare, per quanto riguarda l’eco-design, un capitolo che è stato aggiunto nella nuova formulazione. Il design dei prodotti che produciamo – se sono in grado o meno di essere riparati e, quindi, utilizzati, per una seconda vita – è una parte fondamentale dell’economia circolare.
Tutto sommato, mi sembra di capire che siamo sulla buona strada. O no?
Sì, attenzione però. Possiamo barrare quante caselle desideriamo. Ma gli attori della Circular Economy Stakeholder Platform – aziende piccole e grandi, oltre alle ong – affermano che, nella vita di tutti i giorni, pochi sanno cosa voglia dire economia circolare.
Se guardiamo all’Unione europea nel suo complesso – Commissione, Parlamento, Consiglio, Comitato economico e sociale, ecc. – è innegabile che viene prodotta una grande quantità di legislazione. E credo che il Piano d’azione europeo per l’economia circolare abbia portato la riflessione a livello continentale.
Ho come la sensazione che stia arrivando un grande “ma” …
Se poi guardiamo al livello nazionale, regionale e locale, ci sono lacune. In particolare, c’è un problema al livello del consumatore: capire cosa voglia dire economia circolare. Abbiamo fatto alcune ricerche con il Comitato e analizzato i piani d’azione in giro per l’Europa.
E cosa avete scoperto?
Ogni qualvolta esista un piano di azione nazionale, anche a livello regionale e locale le azioni pubbliche sono più precise ed efficaci. Lo stesso si può dire per il fattore leadership.
Parlando di leadership a livello nazionale, combinato con quello europeo, siamo nel pieno della presidenza tedesca del Consiglio europeo. In realtà, quella tedesca è la prima presidenza di tre – Germania, Slovenia e Portogallo – che dovrebbero lavorare a un programma coerente nel corso di 18 mesi.
Ripongo molte speranze nei semestri dei due paesi più piccoli, Portogallo e Slovenia. L’ex-Commissario europeo all’ambiente, lo sloveno Janez Potocnik, è molto attivo in patria. Prima del 2015, era stato un motore dello sviluppo del primo Piano d’azione per l’economia circolare in Europa. Ecco, credo che si debbano puntare i fari sulla presidenza slovena.
E se dovesse fare un bilancio del semestre tedesco?
Non sono sorpreso che il semestre sia stato incentrato sulla gestione della crisi del Covid-19. Ma se si scava sotto la superficie, ci sono state diverse azioni sul fronte clima e sostenibilità. La Germania ha messo il focus sulla mobilità nel contesto del Green Deal. E quando parliamo di mobilità, parliamo di utilizzo di energia. In media, è un settore che utilizza il 20 per cento dell’energia che produciamo.
Invece, a livello internazionale, nel confronto con altre parti del mondo, com’è messa l’Europa secondo lei?
L’anno scorso sono stato a New York per un evento dell’Onu. Ho incontrato il governatore dello Stato e il sindaco. Mi hanno detto che utilizzano la Circular Economy Stakeholder Platform come punto di riferimento per disegnare le azioni a New York. Lo stesso mi è stato detto in Colombia. Quello che stiamo facendo in Europa rappresenta un termine di paragone altrove nel mondo. Inoltre, questi partner sono anche coscienti del fatto che tutto ciò avrà, in futuro, un impatto sulle condizioni annesse ai trattati commerciali globali.
Lei ha menzionato che l’economia circolare implica collaborazione. Allo stesso tempo, manca la leadership. Eppure, in tutto questo c’è un grande paradosso: il concetto di economia circolare appare come calato dall’alto, dal mondo delle élite. Non crede?
È un paradosso che esiste. Possiamo sviluppare tutti i concetti del mondo. Ma se vogliamo raggiungere il risultato finale, c’è bisogno di un cambiamento culturale, a livello di comportamento delle singole persone e delle aziende medio-piccole, nel modo in cui interagiamo con prodotti e servizi quotidianamente.
Come si risolve il paradosso?
Quando ero ragazzo, in Irlanda, negli anni ‘80, in macchina le cinture di sicurezza non si utilizzavano per i passeggeri posteriori. Mi ricordo che i miei genitori mi invitavano a sedermi al centro per avere una visuale migliore. Oggi verrebbe considerata una cosa da pazzi.
Fuor di metafora?
Il cambiamento di percezione deriva dalle legislazioni che sono state messe in campo per cambiare i comportamenti. Ma è stato fatto attraverso una modalità che non ha spostato il costo e peso sul consumatore finale.
Tutto questo mi fa pensare a un altro Paese europeo e ai gilet gialli …
Oggigiorno, il pericolo più grande è legato alla promozione dell’economia circolare come una scelta di vita della classe media. Una scelta costosa. La sfida è cambiare la legislazione e le regole – un’azione dall’altro verso il basso – per ottenere un cambiamento nei comportamenti di tutti.
Il cambiamento dal basso arriva soltanto se modifichiamo il consumo in quanto tale. Se i consumatori diventano utilizzatori di beni e servizi. E se il valore dei materiali che utilizziamo nella produzione viene preservato. In un certo senso, si tratta di tornare a uno stile di vita più antico in cui c’era meno scarto.
Mi concederà che il “si stava meglio quando si stava peggio” non è proprio un messaggio accattivante …
Effettivamente, il livello di scarto di un tempo era legato a condizioni di povertà e scarsità. È diverso applicare tutto questo in un mondo fatto di abbondanza, ricchezza e prosperità. E credo che questo ci porti anche a parlare di un altro paradosso, quello della contraddizione apparente, nella mente delle persone, tra “risparmio” e “ricchezza”. Non sono concetti che vanno a braccetto di solito.
La circolarità sembra piena di vicoli ciechi …
Dobbiamo affrontare un tabù onnipresente: tutti hanno la sensazione che i prodotti che comprano siano stati disegnati per rompersi, prima o poi. Io penso che lo svisceramento di questo tabù sia connesso in qualche modo al pensiero, altrettanto condiviso, del: “Voglio comprare cose che durino nel tempo. Oggetti che, qualora danneggiati, possano essere aggiustati”.
In effetti, in maniera implicita, oggi diamo ancora un grande valore alla parola “nuovo”.
In effetti, invece di utilizzare parole e locuzioni come “riparato”, oppure “come nuovo”, dovremmo spostarci verso un linguaggio che implichi “meglio di nuovo” (“better than new”, nda).
Per terminare questa intervista, vorrei, per così dire, chiudere il cerchio. Le 35 misure previste dal Piano d’azione europeo per l’economia circolare si focalizzano su una marea di prodotti e filiere: batterie, veicoli, imballaggio, costruzione, alimentazione. Sappiamo già che tutto è connesso. Ma non c’è un settore che dovrebbe avere la precedenza?
La risposta breve è “no”. Tutto deve essere modificato in maniera coordinata. Altrimenti il concetto di circolarità non ha senso. Se prende come esempio il settore tessile, cambiare le regole di produzione ha un impatto sull’imballaggio e, di conseguenza, sul trasporto delle merci, per non parlare dell’energia necessaria alla produzione. Come vede, nel momento stesso in cui ci focalizziamo su un dettaglio, parliamo del tutto.
E la risposta più lunga? Voglio dire, “cambiare tutto” spesso equivale a dire “non cambiare nulla”. O meglio, in termini più costruttivi, cambiare ogni cosa stimola “paura”.
Sono d’accordo che il cambiamento crei paura. Ma poi mi dico che esistono alcuni cambiamenti che vengono accolti con serenità. E quindi mi chiedo se non sia semplicemente l’incertezza a produrre paura, o resistenza.
Mi scusi, ma non vedo la differenza.
Se lei mi dicesse: “C’è una grande sfida all’orizzonte, un nuovo lavoro da svolgere. Cambierai attività, ma in realtà sai già fare quello di cui ci sarà bisogno. E sarai pagato di più”. Beh, ecco: non credo sarebbe problematico.
Come si può cambiare l’interpretazione del rischio da parte delle persone comuni?
Continuiamo a criticare i sistemi di produzione attuali. Ma non abbiamo ancora identificato la destinazione finale. Diciamo che ci siamo fermati al distopico, mentre ci sarebbe bisogno di una visione del futuro utopica e positiva.
fonte: economiacircolare.com
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Il 27 Novembre di Reborn Ideas sarà nuovamente Green Friday
Per il secondo anno consecutivo, Reborn Ideas porterà avanti il Green Friday, la risposta sostenibile al Black Friday e donerà il 20% dei profitti a The Ocean Cleanup
Cos’è il Green Friday
Per contrastare il consumismo eccessivo e gli sprechi legati alla ricorrenza del Black Friday, nel 2017 nasce in Francia il Green Friday per merito dell’associazione di imprese Envie.
L’obiettivo dell’iniziativa è educare a un consumo più responsabile ricordando alle persone che ogni acquisto ha un impatto e che esistono alternative alle logiche commerciali tradizionali.
Il Green Friday non prevede sconti che incentivano all’acquisto eccessivo, ma fin dall’inizio dell’iniziativa ogni azienda che prende parte a questo progetto dona una parte del proprio ricavato a enti che lavorano nel nome della sostenibilità e a favore dell’ambiente.
REBORN IDEAS
Quest’anno, per il secondo anno consecutivo, Reborn Ideas aderisce all’iniziativa e donerà il 20% del ricavato di ogni vendita realizzata dal 27 ottobre al 27 novembre, giorno del vero Black Friday, a The Ocean Cleanup, una fondazione impegnata nello sviluppo di tecnologie in grado di rimuovere la plastica dagli oceani.

Reborn Ideas è la prima social commerce community di prodotti realizzati secondo i principi dell’upcycling, recycling e del riciclo creativo.
Una piattaforma che vuole essere punto di incontro tra i produttori e i consumatori consapevoli, con un’offerta di prodotti che varia dall’abbigliamento all’arredamento, passando per gli accessori.
Tutti i prodotti a cui viene data visibilità su www.rebornideas.com si caratterizzano per la grande originalità e unicità e soprattutto sono prodotti che rappresentano una storia.
«Con il nostro Green Friday – spiega Maurizio Mazzanti, co-founder di Reborn Ideas – vogliamo trasmettere ai consumatori un ulteriore stimolo a creare community: donare il 20% del ricavato delle vendite significa condividere obiettivi insieme, contribuendo al tempo stesso a una causa importante come la riduzione dell’inquinamento delle acque. Lo scorso anno abbiamo aderito all’iniziativa e quest’anno abbiamo deciso di allungarne il periodo per poter dare un contributo di visibilità ed economico ancora più importante».
fonte: www.economia-circolare.info
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Puntare alla circolarità per spendere bene i soldi del Recovery Fund

Senza innovazione e senza rinnovamento non si esce dalla crisi economica ed ecologica in cui ci troviamo. E senza una regia forte dello Stato, magari immaginando un’agenzia nazionale ad hoc, l’Italia non coglierà l’opportunità offerta dal pacchetto Next Generation Eu. Se ne è discusso ieri durante l’incontro “Le misure per l’economia circolare nel Recovery Plan nazionale”, organizzato dal Circular Economy Network nell’ambito degli Stati Generali della Green Economy. Un folto gruppo di ospiti, che ha messo insieme pubblico e privato con la mediazione e la collaborazione del terzo settore, partendo da quello che può diventare una enorme occasione di svolta per il Paese o il più grande spreco degli ultimi anni: l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund, 209 miliardi di euro – tra prestiti e sussidi – che l’Europa ha messo in campo per sostenere la ripresa dell’Italia nell’era post Covid-19.
I settori su cui spingere
In apertura, il coordinatore del Circular Economy Network Fabrizio Vigni ha ricordato che “bisogna partire dal potenziamento del Piano di transizione 4.0, più noto come Industria 4.0, ricordandoci che l’Italia vanta il secondo comparto manifatturiero d’Europa. Nella nostra idea – ha aggiunto igni – col Recovery Fund si potrebbe stabilizzare il credito d’imposta per le imprese per 5 anni e raddoppiare gli incentivi e gli strumenti agevolati, in settori come l’ecodesign, la simbiosi industriale e la riparabilità. Bisognerebbe poi raddoppiare, entro il 2030, i materiali derivanti da riciclo di materia e anche qui si potrebbe pensare all’utilizzo del Recovery Fund incentivando in questo caso le attività di ricerca e potenziando lo sviluppo tecnologico delle imprese. Inoltre, si dovrebbero sostenere le aziende che operano nella sharing economy e quelle che operano nel prodotto come servizio”.
Gli strumenti normativi e il nodo impianti
Quella del Recovery Fund è una “partita decisiva”, per usare ancora le parole di Vigni, e il punto di partenza è che il 37% delle risorse deve essere destinato alla transizione verde, in conformità ai principi enunciati nel cosiddetto Green Deal. L’economia circolare diventa in questo senso una priorità e una via percorribile grazie al quadro normativo europeo: il Piano europeo sull’economia circolare del 2015, le direttive del 2018 sui rifiuti e i decreti di recepimento, la direttiva sulle plastiche monouso e il nuovo Piano europeo sull’economia circolare del 2020. Tra i punti principali di quest’ultimo provvedimento vale la pena ricordare l’obiettivo del dimezzamento della quantità di rifiuti urbani residui (non riciclati) entro il 2030, anche in questo caso con il possibile supporto del Recovery Fund alle zone più in difficoltà.
“Uno dei nodi fondamentali è quello dell’impiantistica: senza impianti tutta la filiera non può avere la sua struttura sostanziale – ha concordato Laura D’Aprile, direttrice generale per l’economia circolare al ministero dell’Ambiente -. Stiamo lavorando ad esempio al programma nazionale dei rifiuti, per questo motivo abbiamo già convocato le regioni e Ispra per un primo avvio, e a breve ci sarà il confronto con le imprese del settore. Vogliamo individuare i flussi e le esigenze impiantistiche per garantire uno sviluppo omogeneo in tutto il Paese, soprattutto per quanto riguarda l’organico e per adeguare gli impianti alle Bat (Best Available Technologies, le migliori tecniche disponibili, ndr). Il nostro ministero farà dunque da supporto normativo alle Regioni e contemporaneamente da sostegno economico, in proprio e coi nuovi fondi dell’Europa”.
Obiettivo semplicità
Da più parti si è sollevata l’esigenza di una strategia nazionale, perché il tema dell’economia circolare non è solo una questione ambientale ma anche, come suggerisce lo stesso termine, di sviluppo economico. In questo quadro diventa cruciale il ruolo del Mise – che vanta anch’esso una direzione destinata all’economia circolare – e del ministero dell’Agricoltura, ancora in ritardo sul tema. “Serve uno sforzo sistemico e coerente – ha ammonito Elio Catania, neoconsigliere per la industriale al Mise – perché l’economia circolare è un cambio strutturale che interessa tutti i settori del mondo produttivo, dall’approvvigionamento delle risorse al consumo fino alla produzione di rifiuti e alla reimmissione delle materie prime e seconde. La platea interessata è di almeno 300mila imprese, e forse sono numeri limitativi. Già l’anno scorso, di concerto col ministero dell’Ambiente, abbiamo voluto stimolare la transizione energetica: nel 2019 il 20% delle risorse disponibili è stato legato all’innovazione e all’economia circolare. L’interesse è forte: faccio notare che solo quest’anno sono stati presentati nuovi progetti, legati alla ricerca e allo sviluppo, per 110 milioni di euro. Puntiamo poi alla riconversione degli impianti produttivi e al rafforzamento delle competenze, con l’obiettivo di avere 7mila dottorati all’anno in questo ambito. Se è vero, come ci dice l’Ocse, che si possono ottenere risparmi di produzione di miliardi di euro serve che l’economia circolare diventi una priorità. Perciò abbiamo bisogno di semplicità e di quella che io chiamo una costante ossessione dell’attuazione, affinché si possa fare la differenza”.
“La politica torni a decidere”
Come ha ricordato Gianni Girotto, presidente della Commissione Attività produttive al Senato, ci sono settori che più di altri potrebbero immediatamente avvantaggiarsi di una accorta direzione del Recovery Plan che l’Italia dovrà presentare all’Unione Europea. Senza limitarsi a “svuotare i cassetti dei ministeri”, per parafrasare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma elaborando strategie concrete, integrate e lungimiranti. “Penso ad esempio ai rifiuti da demolizione – ha dichiarato Girotto -. Più in generale molte altre filiere dovranno creare dei consorzi, in particolare quella del tessile, che è la seconda filiera più inquinante al mondo dopo quella fossile. Allo stesso tempo ci sono casi positivi, ad esempio sulla batteria al litio c’è un’azienda italiana che sta progettando e costruendo uno stabilimento per creare l’intera filiera di questo materiale fondamentale, compreso il riciclaggio. A me poi sta a cuore il settore dei Raee, che al momento ci vede indietro visto che ne ricicliamo solo il 30%: ciò è un danno economico perché le materie prime che contengono sono importanti ed è un danno ambientale perché questi rifiuti vengono contrabbandati all’estero o comunque spediti dove i processi di riciclaggio non sono curati come avviene in Europa”. Così se non sorprende più che a parlare di ambiente sia un parlamentare dell’ex commissione Industria, allo stesso modo succede che Alessia Rotta, presidente della commissione Ambiente a Montecitorio, incentri il suo intervento sulle opportunità produttive dell’economia circolare. “Non si tratta più di una sfida ma di una necessità – ha osservato Rotta – visto che importiamo più della metà delle materie prime, e allora serve che impariamo a recuperarle dalle materie prime seconde. Le imprese poi non devono essere lasciate sole. Quel che è certo è che col Recovery Fund la politica deve tornare a decidere, e quella dell’economia circolare è la migliore strada possibile”.
fonte: economiacircolare.com
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Barriqule: le barrique si trasformano in occhiali

Tra le vigne di Barolo e Barbaresco nasce Barriqule che dal mondo vinicolo non prende solo ispirazione per il design, ma anche per il nome: le barriques, infatti, sono le piccole botti francesi per affinare i vini e in Langa, patria di vini pregiati riconosciuti come patrimonio mondiale dell’Unesco, barricule significa proprio occhiale.
La produzione e i materiali utilizzati sono 100% Made in Italy.
Il risultato è un prodotto di alta qualità dove l’artigianalità è presente in ogni dettaglio – a volte forse imperfetto per la naturale conformazione del legno stesso – ma che conferisce quel senso di unicità e appartenenza al territorio a ciascun modello.

Barriqule è il brand che racconta un territorio e l’ economia circolare attraverso l’occhiale di design che nasce dal vino e diventa l’accessorio irrinunciabile, sia per lui che per lei, per ogni momento della giornata.
Gli occhiali Barricule con aste in legno di rovere le trovi su Greeneria di SoSa, la selezione dei prodotti di qualità ed eccellenze ambientali delle nostre aziende, degli artigiani e dei produttori di qualsiasi settore merceologico della Green Economy, che non c’era direttamente a casa tua. QUI
fonte: https://www.economia-circolare.info/
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Rifiuti: al Sud una riscossa dimezzata

Sul fronte rifiuti la riscossa del Meridione è possibile. E la risposta dei cittadini arriva ogni volta che si creano le premesse giuste. L’ultimo caso è la raccolta di carta e cartone nelle aree in ritardo sugli obiettivi della differenziata. In queste zone il Comieco, il consorzio per la raccolta degli imballaggi in carta, ha impostato una campagna mirata che ha prodotto risultati. Nel 2019 la raccolta è cresciuta del 3% e nel Sud l'incremento ha toccato l'8,5%. Non solo ogni abitante ha messo da parte oltre un chilo di carta e cartone in più rispetto al 2018 superando per volumi raccolti il Centro Italia. Ma la percentuale di impurità (la chiave per definire qualità ed economicità del servizio) è scesa sotto la soglia del 3%.
Insomma lo schema un po’ di maniera che vede, in questo settore, un’Italia a tre velocità guidata dal Nord si sta cominciando a incrinare. Già nel 2015 Sardegna, Campania e Abruzzo hanno battuto, per la raccolta differenziata, Toscana, Liguria e Valle d’Aosta. Segno di una mappa che si va facendo sempre più articolata: nelle aree meridionali in cui le amministrazioni danno messaggi chiari e continuativi, la collaborazione dei cittadini si attiva.
I cittadini però possono risolvere solo metà del problema: fornire la materia che da rifiuto può rinascere trasformandosi in oggetti. Ma la bacchetta magica per realizzare la metamorfosi solo in forza della virtù ambientale non è stata ancora inventata. Per ora dobbiamo restare ai principi che governano le trasformazioni fisiche e chimiche e ai sistemi industriali che regolano il processo. Per dare gambe all’economia green ci vogliono impianti green. Senza impianti avanzati non resta che affidarsi ai vecchi sistemi, che tra l’altro hanno lasciato ampi margini di manovra alla criminalità organizzata.
“Il potenziale di miglioramento della gestione dei rifiuti nel Sud Italia si scontra con la carenza di impianti”, spiega Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys, la società di ricerca che organizza il WAS Annual Report, l’analisi degli investimenti effettuati dalle utility ambientali in questo campo. “Se i dati di raccolta differenziata mostrano un miglioramento negli ultimi anni, il trattamento e la valorizzazione dei materiali per il riciclo al Sud non decolla perché non ci sono gli impianti. Risultato? Grandi viaggi di questi materiali, con relativi costi e impatti ambientali, verso il Centro Nord”.
Secondo i dati del WAS Annual Report, a fronte di un rapporto nazionale tra investimenti e valore della produzione pari al 3,8% e uno tra investimenti e popolazione pari a 7,14 euro per abitante servito, nel Sud e nelle Isole i valori sono molto più bassi, 2,8% per gli investimenti e 3,64 euro per abitante servito. Mentre nel Nord e nel Centro Italia oltre il 60% (e fino al 74%) degli investimenti delle aziende è indirizzato agli impianti, nel Meridione e nelle Isole si scende a meno di un terzo del totale. La gran parte dei fondi serve a finanziare attrezzature e automezzi per la raccolta. Con il piccolo problema che, una volta fatta la raccolta, non si sa dove inviare i materiali.
fonte: www.lastampa.it
RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Crocco, il packaging rinasce dal riciclo

Il nuovo packaging dell’azienda veneta Crocco Spa si posiziona in piena economia circolare: generato per il 60 % da materia derivante da riciclo, il nuovo imballaggio in plastica prodotto dall’azienda ha superato le richieste dell’UE, che entro il 2030 ha fissato come obiettivo il riciclo del 55 % degli imballaggi in plastica.
Lo speciale packaging ha ottenuto la certificazione di conformità per l’utilizzo del marchio Plastica Seconda Vita per film termoretraibili neutri e stampati, quelli che sono utilizzati per l’imballaggio delle bottiglie, e che possono quindi contenere fino al 60 % di plastica riciclata proveniente da post consumo oppure dal 30% fino al 60 % di plastica riciclata Mix Eco, una miscela di scarto industriale e post consumo.
Al progetto hanno lavorato R&D Team e una “nuova figura sostenibile” la Corporate Sustainability Expert, un ingegnere chimico di 28 anni donna: una professionalità chiave nello sviluppo in ottica green delle imprese e dei prodotti.
“Questa nuova soluzione” spiega Renato Zelcher, AD di Crocco “presenta diversi impatti positivi. Il primo è verso l’ambiente, perché il riciclo significa che si utilizza un materiale, o almeno una sua buona parte, più volte anziché una e questo comporta anche un’automatica riduzione della CO2 immessa nell’atmosfera”. “Il secondo” continua Zelcher “è che per chi utilizza il nostro packaging perché può comunicare al proprio cliente finale l’abbassamento del proprio impatto”.
Il packaging da Plastica Seconda Vita sarà in grado di garantire all’acquirente, sia essa impresa, PA o consumatore finale, il rispetto del regolamento dell’Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo e l’utilizzo di materiale riciclato con relativa rintracciabilità. Il tutto certificato da un ente terzo, SGS Italia, che prevede, come da regolamento, una sorveglianza continua della correttezza del processo.
“Questa ulteriore garanzia per il consumatore” spiega Zelcher “si inserisce nel più ampio progetto di Crocco per la sostenibilità del packaging plastico denominato Greenside, per cui grazie ad un processo di Eco design collaborativo, riusciamo a fornire un packaging limitando al massimo l’impatto ambientale, addirittura arrivando ad avere un impatto zero dal punto di vista delle emissioni di CO2.”
Proprio durante l’emergenza Covid-19, il packaging in plastica è stato riscoperto come materiale essenziale per garantire la salubrità degli alimenti, e per il consumatore è ormai facile riconoscere quale plastica si stia comprando e quale sia il suo l’impatto sull’ambiente.
Crocco durante il lockdown ha visto la parte commerciale lavorare in smart working, come prescritto dai DPCM, mentre la produzione, essendo l’azienda inserita nelle filiere agroalimentare e farmaceutica, ha proseguito con le misure di sicurezza il lavoro per soddisfare l’aumento di ordini. Tra marzo e aprile si è registrato un picco nel settore della GDO e ovviamente anche il farmaceutico ha avuto un aumento significativo.
La sfida del futuro sarà come garantire prodotti plastici rigenerati post consumo a prezzi competitivi sul mercato. “Il primo passo è migliorare la raccolta perché è l’operazione a monte di tutto il processo “afferma l’AD di Crocco Zelcher, che conclude “con un sistema efficiente di raccolta e selezione, prima, e di riciclo poi, si arriverebbe ad avere del materiale riciclato di qualità a prezzi concorrenziali, creando delle economie di scala enormi che ripagherebbero dell'investimento sia da un punto di vista economico ma anche e soprattutto ambientale”.
fonte: www.lastampa.it
RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria
Il Fondo monetario internazionale chiede la fine dei sussidi ai combustibili fossili (VIDEO)
Durante un meeting virtuale del World Economic Forum (Wef), l’amministratore delegato del Fondo monetario internazionale (FMI), Kristalina Georgieva, ha annunciato la svolta: «Ora è il momento di porre fine ai sussidi per i combustibili fossili e creare un’economia più verde e più equa per il futuro».
La Georgieva lo ha dichiarato in occasione del lancio del “Great Reset”, l’iniziativa globale del Wef per costruire un mondo migliore dopo la pandemia di Covid-19, mettendo così tutto il peso dell’FMI sull’accelerazione del passaggio dai combustibili fossili alla green economy.
La Georgieva ha sottolineato che «ora dobbiamo fare un passo avanti, usare tutta la forza che abbiamo, che nel caso del FMI ammonta a 1 trilione di dollari per garantire che la storia parli di una grande ripresa e non di un grande rovesciamento. Questo significa mettere in atto i giusti investimenti e incentivi e rompere con quelli insostenibili. Sono particolarmente desiderosa di sfruttare i bassi prezzi del petrolio per eliminare i sussidi dannosi».
Il documento “Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country-Level Estimates” pubblicato dall’FMI nel 2019 ha stimato sussidi annuali globali per combustibili fossili in 5,2 trilioni di dollari nel 2017, ovvero il 6,5% dell’economia globale, illustrando l’entità della sfida. Secondo il sesto dossier “Stop sussidi alle fonti fossili – Stato dei sussidi e dei finanziamenti diretti e indiretti, al settore Oil&Gas” presentato a fine marzo 2019 da Legambiente, sono invece «circa 18,8 i miliardi di euro che sono arrivati in un anno in Italia al settore delle fonti fossili, tra sussidi diretti e indiretti al consumo o alla produzione di idrocarburi».
Ma i leader che hanno partecipato al meeting Wef hanno convenuto che «questo momento di crisi è anche un momento di opportunità per tracciare un percorso diverso». La Georgieva ha tracciato un parallelo con il modo in cui la Seconda Guerra Mondiale ha portato alla fondazione del Servizio sanitario nazionale nel Regno Unito: «Il miglior memoriale che possiamo costruire per coloro che hanno perso la vita nella pandemia è un mondo più verde, più intelligente e più giusto».
Persino l’amministratore delegato di Bp, Bernard Looney, ha affermato di appoggiato la fine dei sussidi per i combustibili fossili e di «sostenere le politiche di investimento ecologico che le istituzioni, compresa l’Ue, stanno iniziando a mettere in atto. Il portafoglio di energia alternativa di BP comprende energia eolica, solare e biocarburanti. Sappiamo tutti che esiste un bilancio del carbonio. E’ limitato, si sta esaurendo».
Looney ha raccontato di aver parlato con un operaio di una raffineria che lo ha ringraziato per aver avviato la transizione verso le energie rinnovabili, sulla base del fatto che: «Data la scelta, la sceglierei ogni volta per i miei nipoti».
Al Wef sottolineano che «a meno che le cose non cambino, le prospettive per questa generazione sono desolanti. Senza azione, entro la fine del secolo è previsto un riscaldamento catastrofico di oltre 4 gradi, con le attuali politiche che ci mettono in rotta verso i circa 3 gradi di riscaldamento, abbastanza per far finire sott’acqua le principali città, portare a estinzioni di massa e rendere inabitabili ampie parti del mondo».
Usa e Cina sono i maggiori inquinatori del mondo e in Cina, dopo la pausa del blocco per il Covid-19 che ha portato a un calo delle emissioni di CO2 e dello smog, l’inquinamento atmosferico è già tornato ai livelli precedenti. Per questo anche Ma Jun, presidente del China Green Finance Committee, ha sostenuto una grande revisione dell’attuale modello produttivo: «Deve essere più ecologico di qualsiasi altra ripresa precedente» e ha sollecitato che la ripresa post-Covid-19 comprenda «Relazioni e normative più rigorose per le aziende, incentivi al consumo come incentivi per beni ad alta efficienza energetica, sviluppo di infrastrutture verdi e utilizzo di green bond per incanalare gli investimenti».
fonte: http://www.greenreport.it
#RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria







