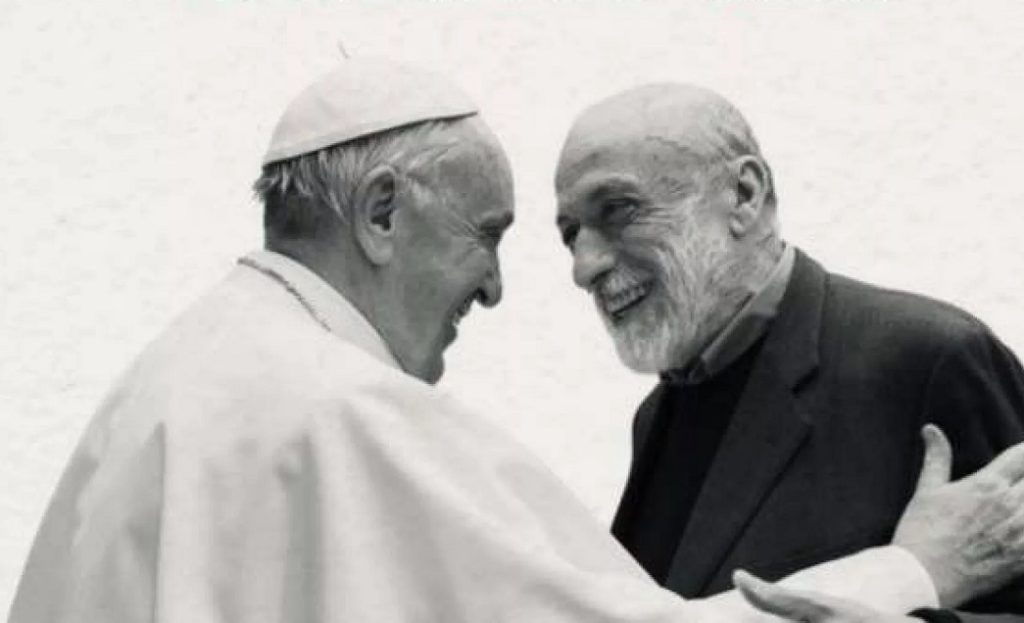Quest’anno la seconda edizione del
Festival sulla Qualità della Vita,
ospiterà un importante dibattito pubblico tra le principali
associazioni nazionali impegnate nella salvaguardia e tutela ambientale
del nostro territorio, in tre settori fondamentali: il trattamento dei
rifiuti, con
Massimo Piras, Presidente del Movimento Legge Rifiuti Zero per l’economia circolare,
Cinzia Scaffidi, vicepresidente
Slow Food Italia e Direttrice del centro studi dell’associazione, e
Luca Fioretti, del direttivo nazionale dell’Associazione Comuni Virtuosi
.
Sarà proprio
l’economia circolare,
quest’anno tema principale del festival insieme all’alimentazione,
ad animare il confronto. Questo approccio è considerato da molti chiave
per il rilancio dell’economia europea, a seguito dell’approvazione del
Pacchetto sull’economia circolare da parte della Commissione Juncker nel dicembre del 2015.
In breve,
l’economia circolare è il contrario dell’
economia lineare,
che tratta la materia prima trasformata ed utilizzata dal consumatore,
fino alla fine del suo “ciclo di vita” come rifiuto e quindi
concettualmente come qualcosa di non più utilizzabile.
Si tratta di prendere la linea retta – economia lineare – sottesa all’attuale sistema economico, che
preleva, trasforma, vende e butta, indifferente alle conseguenze –
cambiamenti climatici, difficoltà di approvvigionamento delle materie
prime, inquinamento e distruzione della biodiversità – e piegarla fino a
trasformarla in un cerchio.
In questo modo, i prodotti vengono progettati per durare ed essere
smontati facilmente, i rifiuti vengono valorizzati e trasformati in
risorse con cui prolungare all’infinito il ciclo di vita dei beni.
Nel nuovo paradigma, più vicino al buonsenso e rispettoso della natura,
rientrano ambiti cognitivi molto diversi come la bioeconomia, la sharing
economy, il remanufacturing, la biomimesi o i sistemi di gestione
avanzata dei rifiuti.
Ad aprire l’incontro
Massimo Piras, Presidente del
movimento legge “Rifiuti Zero” che illustrerà non solo le linee guida
del pacchetto europeo di recente approvazione, ma soprattutto come
possiamo concretamente metterle in pratica nella vita di tutti i giorni.
Inoltre verrà presentata una proposta di delibera che tutti i comuni
possono adottare per raggiungere l’obiettivo ambizioso, ma possibile
della riduzione complessiva dei rifiuti conferiti.
Interverrà all’incontro anche
Massimo Ranieri, Presidente della società
Ecologica Lanciano, per mostrare i risultati di una gestione corretta e, soprattutto,
partecipata, del trattamento dei rifiuti.
A Lanciano infatti in un anno la raccolta differenziata ha raggiunto quote apprezzabili,
sfiorando l’80%
considerata la base del 28% ereditata da una gestione privata. Tutto
ciò a dimostrazione che l’alternativa alla discarica e all’incenerimento
dei rifiuti è la differenziata spinta.
Obiettivo primario sarà fornire uno stimolo alle amministrazioni
comunali abruzzesi – invitate all’incontro – per rimettere al centro
dell’agenda politica la questione rifiuti, con l’intervento dell’ex
Sindaco di Monsano
Luca Fioretti che racconterà al
pubblico l’esperienza dell’associazione Comuni Virtuosi, rete di Enti
locali, che opera a favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei
propri Territori, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezze e
stili di vita all’insegna della sostenibilità, di buone pratiche
attraverso l’attuazione di progetti concreti ed economicamente
vantaggiosi, sulla gestione del territorio, sull’efficienza e il
risparmio energetico, nuovi stili di vita all’insegna della
partecipazione attiva dei cittadini.
Fondamentale corollario di
Cinzia Scaffidi
sull’educazione alimentare, l’alimentazione come “atto politico” che
influenza non solo la nostra salute, ma oggi anche il consumo di suolo,
con le coltivazioni intensive che distruggono la biodiversità. Prevista
inoltre per domenica 9 ottobre alle 17.00 la presentazione del suo
ultimo libro “
Mangia come parli”.
L’incontro si terrà nella giornata centrale del festival,
all’AURUM sabato 8 ottobre alle ore 18.00,
in sala d’Annunzio, moderato da Massimo Melizzi, Presidente di
Pescara Punto Zero, associazione organizzatrice del festival e referente del
movimento legge rifiuti Zero in Abruzzo.
fonte: http://comunivirtuosi.org/