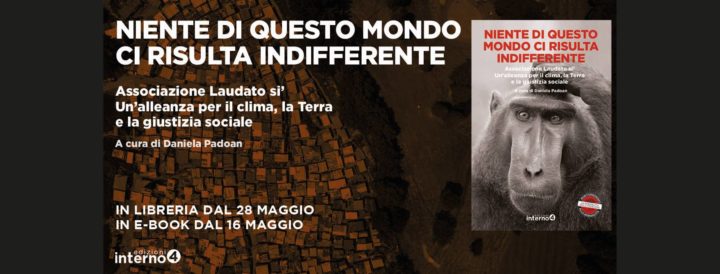Due noti economisti, Lorenz T. Keyber e Manfred Lenzer, specializzati nella elaborazione di modelli, hanno di recente pubblicato su Nature Communications (12, articolo numero 2676, 2021) un saggio molto ampio e impegnativo, intitolato “Gli scenari di decrescita relativi a 1,5 gradi suggeriscono la necessità di seguire nuovi percorsi di mitigazione” (1.5 °C degrowth scenarios suggest the need for new mitigation pathways). Il loro testo fa riferimento ad un notissimo rapporto dell’IPCC, il Comitato Intergovernativo per il Cambiamento Climatico, intitolato “Riscaldamento globale di 1,5 gradi centigradi” e messo in circolazione circa due anni fa, quindi prima dei ritardi negli incontri del Comitato dovuti alla pandemia ancora in corso. Quel documento aveva un compito ben preciso, cioè difendere in modo scientifico e ben documentato la necessità assoluta di non superare il grado e mezzo di aumento della temperatura del pianeta nei prossimi anni. Questo limite per molto tempo era stato indicato in 2 gradi durante diverse Conferenze delle Parti, cioè gli incontri assembleari dell’IPCC, a causa dell’opposizione di molti dei paesi maggiori inquinatori che pretendevano di avere margini più ampi prima di essere costretti a ridurre le produzioni più dannose.
A seguito di quel conflitto interno, l’ultimo documento emesso dal Comitato indicava ancora il limite dei 2 gradi, ma aggiungeva “e se possibile degli 1,5 gradi” e subito dopo usciva il rapporto sopra indicato, a difesa del limite inferiore, considerato evidentemente dagli scienziati vitale per gli equilibri del pianeta. Una sintesi ampia e molto dettagliata di questo rapporto si trova in italiano nel sito dell’IPCC per l’Italia, nella forma di “Sommario per i Decisori Politici”.
I due economisti già nelle prime righe del saggio formulano una accusa molto precisa: “Gli scenari dell’IPCC si basano su delle combinazioni di emissioni negative e oggetto di controversie e su dei cambiamenti tecnologici senza precedenti, mentre si presume una continua crescita del prodotto interno lordo”. I due economisti hanno infatti scoperto che gli autori del rapporto si sono dimenticati di prendere in considerazione lo scenario della decrescita, poiché il prodotto dell’economia non può che diminuire a causa degli interventi sulle attività produttive volti a mitigare i loro effetti negativi sul clima. Come si può ben comprendere, si tratta di un’accusa non trascurabile, in quanto riduce di molto l’attendibilità scientifica delle migliaia di scienziati che lavorano per l’IPCC.
Dopo questa premessa, i due autori avviano una analisi molto approfondita di tutti i 222 modelli utilizzati dai redattori del rapporto, ed evidenziano il fatto che in nessuno di essi si è tenuto conto di queste riduzioni che incidono molto sulle attività economiche e sulla vita sociale di tutti i paesi coinvolti. Inoltre, non contenti, elaborano una serie di modelli, basati su una gamma di ipotesi alternative, che evidenziano ogni volto una varietà di effetti sulle società e sulle strutture produttive. Questi loro modelli sembrano essere molto semplificati (ad esempio sono elaborati in riferimento alla sola energia da carburanti), mentre invece moltiplicano le combinazioni di fattori presi in considerazione.
L’autore del presente articolo non entra minimamente nel merito del prezioso saggio, oltre che per totale incapacità scientifica, non avendo alcuna competenza in materia di modelli, anche perché è interessato solo ad un ‘aspetto molto particolare, cioè all’uso della parola “degrowth”, traducibile con “decrescita” dall’italiano all’inglese, ma che forse non rappresenta un effettivo riferimento ai tanti significati contenuti nel pensiero della decrescita nel nostro paese.
Durante questo loro lavoro, molto faticoso, indubbiamente complesso, ma anche molto accurato e scientificamente corretto, i due economisti si sono anche convinti che sarebbe molto utile tenere conto delle riduzioni dei livelli di produzione e di reddito determinate dalle misure di mitigazione e di adeguamento, perché aprirebbero la strada a ulteriori interventi di questo tipo, ad esempio a politiche come la intensificazione delle forme alternative di energia (quelle di per se non dannose per l’ambiente) e comunque a scelte industriali veramente attente ad evitare danni all’ambiente, sia riducendo l’uso di certe materie prime, sia evitando inquinamenti derivanti da processi produttivi, sia influendo positivamente su scelte dei consumatori realmente alternative.
Nella discussione finale sui risultati ottenuti dai molteplici modelli da loro elaborati, i due economisti si preoccupano molto di mostrare i limiti dell’approccio da essi adottato, ulteriore dimostrazione della loro correttezza ed elevata professionalità. Le loro indicazioni sono quindi ancora più interessanti in quanto viste in una ottica molto critica. La prima affermazione è di particolare rilievo: “I risultati indicano che il percorso con la decrescita mostra i più bassi livelli di rischio per la fattibilità e la sostenibilità, quando vengono messi a confronto con i percorsi adottati nel Rapporto SR1,5 dell’IPCC utilizzando i nostri indicatori di rischio sociale e tecnologico”. In sostanza, i controlli effettuati dai due economisti mettono in luce le conseguenze negative il troppo peso attribuito alla tecnologia oggi dominante da parte degli scienziati dell’IPCC.
Successivamente, viene sottolineato che i modelli utilizzati dai due ricercatori prendono in considerazione solo l’anidride carbonica e non tengono conto della presenza tra gli inquinanti dell’atmosfera del CH3, cioè del metano e del N2O, cioè del diossido di ozono, “per i quali le mitigazioni tecnologiche sono più problematiche di quelle per l’anidride carbonica”. E concludono affermando che “Includere tutti questi fattori dovrebbe aumentare in misura sostanziale le difficoltà delle mitigazioni. Ognuno di questi aumenti rafforza in misura rilevante l’opportunità di prendere in considerazione gli scenari di decrescita, poiché diventa ancora più rischioso l’affidarsi soltanto alla tecnologia per conseguire livelli più alti di mitigazione” E ancora,”quindi, integrando la tecnologia con delle riduzioni della domanda in una prospettiva spinta più avanti nel tempo attraverso il cambiamento sociale, diventa ancora più necessario se vogliamo che il grado e mezzo rimanga un obiettivo possibile da raggiungere”.
Segue una affermazione molto importante, anche se ancora mantenuta nell’ambito della modellistica: “Pertanto è necessario disporre di una gamma di scenari molto più ampia della nostra, se si vuole arrivare a delineare un quadro più completo della fattibilità. Tuttavia, noi continuiamo ad affermare che tale ricerca dovrebbe prendere esplicitamente in considerazione degli scenari di decrescita, ad esempio con le caratteristiche dello “Scenario di trasformazione Sociale” di Kuhnhem e altri, oppure quelle dello Scenario SSPO proposto dalla Otero e altri. Ancora più esplicita e inequivocabile l’affermazione successiva: “Specie in vista di una fattibilità socio-politica, noi siamo convinti che la mancata esplorazione di questi scenari oggi conduce solo a una profezia che si autorealizza: con una ricerca che in maniera soggettiva giudica fin dall’inizio tali scenari come non realizzabili, essi rimangono margina nei discorsi pubblici e quindi inibiscono il cambiamento sociale, e quindi lasciando che essi appaiano ancora meno fattibili agli scienziati e così via. Come affermano McCollum e altri (1) e Pye e altri, (2) chi elabora i modelli si deve assumere la responsabilità collettiva di valutare l’intero spettro delle possibilità future, ivi compresi scenari comunemente considerati politicamente improbabili”.
I due economisti hanno quindi una visione molta seria del loro lavoro e marcano una distanza molto forte dal folto gruppo di scienziati, oltre 2.500, che sono a disposizione dell’IPCC. E infatti continuano ad evidenziare i limiti del loro lavoro e affermano ancora una volta che secondo le loro conoscenze, non esiste alcuno studio approfondito che esamini i motivi che hanno condotto ad omettere degli scenari di decrescita nei 222 modelli costruiti per l’IPCC.
Si arriva così al punto fondamentale che ha motivato la scrittura del presente articolo. Sempre nelle valutazioni finali, i due economisti affermano che una società della decrescita dovrebbe funzionare in modo molto diverso in confronto alla società attuale:
“Quindi i parametri e le strutture dei modelli basati sul passato potrebbero non essere più validi. Inoltre sarebbe necessario riconoscere che il prodotto interno lordo è un indicatore inadeguato del benessere di una società, almeno nei paesi più ricchi. Invece, il punto focale dovrebbe essere orientato direttamente verso la soddisfazione di bisogni umani multi-dimensionali (3). Tutto ciò è particolarmente importante dato che molte proposte di decrescita comprendono un rafforzamento del lavoro non monetizzato, ad esempio come il lavoro di cura e l’impegno in senso comunitario, nonché una demercificazione dell’economia e delle attività orientate verso la condivisione, il dono e il bene comune”.
È indubbio che i due economisti siano informati su alcuni elementi essenziali di una società completamente alternativa al sistema economico dominante, però ho la sensazione che le loro conoscenze non siano particolarmente approfondite e che manchi una scelta decisamente orientata verso un cambiamento radicale (da effettuare oltretutto in tempi piuttosto rapidi). La mia sensazione si basa su alcuni elementi, che vorrei sottoporre al lettore affinché possa giudicare. In primo luogo, i testi citati sono pochi (vedi nota 3), tre di Kallis, e mancano i testi base del pensiero della decrescita (da Ivan Illich a Georgescu Roegen e Serge Latouche, solo per fare qualche nome) che descrivono in tutta la loro portata e profondità i mutamenti radicali che caratterizzano l’alternativa al sistema capitalistico. In secondo luogo, i due ricercatori esprimono la necessità di tener presenti, in eventuali successivi studi, una pluralità di visioni economiche per conseguire un quadro più completo della realtà socio-economica, ad esempio l’economia postKeynesiana, quella ecologica e quella di tipo Marxista, tra loro molto diverse. Infine, i due economisti ritornano al loro campo di specializzazione e citano le modifiche che si potrebbero apportare ai sistemi adottati dall’IPCC, trascurando il fatto essenziale che tutta l’impostazione di questo Comitato internazionale mira soltanto ad apportare mitigazioni e adeguamenti ai sistemi economici esistenti, in una ottica di pura sostenibilità che non tiene di fatto conto della drammaticità dei fenomeni ambientali indotti dalle attività umane. Cosa suggeriscono i due economisti: “Promettenti sviluppi in questa direzione sono messi in evidenza nella rete dei modelli IAM di MEDEAS, che mette in connessione approfondimenti economici nella biofisica con la dinamica dei sistemi e le analisi input-output. Un altro esempio recente è costituito dal modello EUROGREEN, che combina economia post Keynesiana ed ecologica in un coerente quadro di sistemi dinamici stock e flussi, con lo scopo di valutare le conseguenze sociali ed ecologiche di scenari di decrescita nazionali e di crescita verde”.
Anche nel titolo del saggio si parlava di “suggerire la necessità di seguire nuovi percorsi di mitigazione”, una delle parole chiave per comprendere l’effettivo ruolo dell’IPCC, che pur rappresentando in apparenza un grandioso tentativo di tutti gli Stati di collaborare nella soluzione dei problemi climatici, in realtà è chiaramente la sede di un ulteriore tentativo di mantenere intatte le logiche del sistema economico dominante.
In conclusione, mi sembra che non possiamo farci ingannare dall’uso della parola “degrowth”, traducendola con “decrescita”, come se per la prima volta fossimo in presenza di una accettazione in una importante sede internazionale del pensiero della decrescita. Viceversa, possiamo tentare di trarre una qualche utilità dalla lettura di questo corposo saggio. Sarebbe di estrema importanza che economisti come Keyberg e Lenzen concentrassero i loro sforzi analitici sulla transizione dall’economia dominante a quella descritta dal pensiero della decrescita, evidenziando percorsi di trasformazione, connessioni tra i passi successivi e tempi di realizzazione (imposti dalla crisi climatica). Pur con delle inevitabili imperfezioni e limitazioni, costituirebbe uno strumento di azione e uno stimolo al dibattito politico tra le forze in campo, di cui l’intera umanità ha urgente bisogno.
Nei pochi mesi che ci separano dalla prossima Conferenza delle Parti dell’IPCC e dall’apparizione di nuovi rapporti dei loro scienziati, non dovremo mai trascurare i dati relativi al dissesto del pianeta e al rischio della “sesta estinzione di massa”.
Note
McCollum D.L e altri, Energy modellers should explore extremes more systematically in Scenarios, Nat. Energy 5 104-107 (2020)
Pye e altri, Modellin net-zero emissions energy systemes requires a change in approach, Clim. Policy, 21, 222-231 (2020)
3. Kallis G. e altri, Research on degrowth, Annu. Rev. Eviron. Resour. 43,291-316
(2018)
Kallis G. In defence of degrowth, Ecol. Econ. 70 873-880 2011
Hickel J. E Kallis G. Is gren growth possible? New political economy, 25
469-486 2020
Hickel J. It is possible to achieve a good lif for all within planetaries boundaries?
Third World 40 18-35 2019
Hickel J. Degrowth: a theory of radical abundance, Real World Economics
Revue, 54-68 2019
Jewell J. E Cherp A., On the political feasibility of climate change mitigation
pathways: is it too late to keep warming below 1,5 C ? Wires Climate
Change 11 e621 2020
fonte: comune-info.net
=> Seguici su Blogger
=> Seguici su Facebook