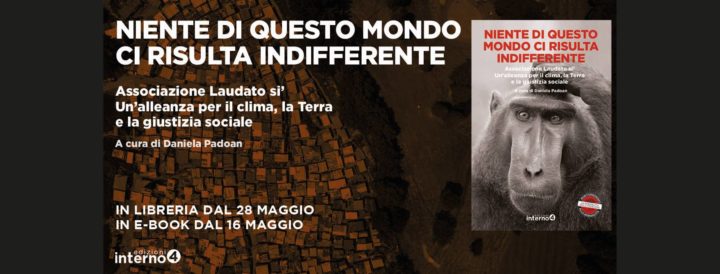Le morti premature dovute al degrado ambientale minacciano la salute pubblica
12,6 milioni di decessi nel 2012 attribuibili al deterioramento delle condizioni ambientali, il 23% del totale

Secondo il
rapporto tematico “
Healty environment, Healty People”, presentato alla seconda sessione dell’
United Nations Environment Assembly
(Unea-2) che si è aperta a Nairobi, «si stima che il degrado
ambientale e l’inquinamento causino fino a 234 volte il numero di morti
premature che si verificano ogni anno durante i conflitti, mettendo in
evidenza l’importanza di un ambiente sano per il raggiungimento degli
obiettivi della 2030 Agenda for Sustainable Development. Gli impatti
ambientali sono responsabili della morte di più di un quarto di tutti i
bambini di età inferiore ai cinque anni».
Il rapporto è stato realizzato da United Nations Environment
Programme (Unep), Organizzazione mondile della sanità (Oms), Convention
on Biological Diversity, Protocollo di Montreal Protocol sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono, e Convenzioni di Basilea, Rotterdam e
Stoccolma e analizza I pericoli posti alla salute e al benessere umano
da inquinamento dell’aria, prodotti chimici, cambiamento climatico ed
altri problemi ambientali.
Il rapporto rileva che, nel 2012, ben 12,6 milioni di decessi erano
attribuibili al deterioramento delle condizioni ambientali, il 23% del
totale. La più alta percentuale di decessi attribuibili per l’ambiente
si riscontra nel Sud-est asiatico e nel Pacifico occidentale
(rispettivamente 28% e il 27% dell’ammontare totale). Il numero di
decessi attribuibili all’ambiente è del 23% nell’Africa sub-sahariana,
del 22% nella regione del Mediterraneo orientale, dell’11% e del 15%
nei Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (Ocse) e nei Paesi non-Ocse della regione delle Americhe,
mentre l’Europa arriva al 15%.
In tutte le regioni del pianeta sono in aumento i decessi correlati a
malattie non trasmissibili. Nel 2012 i tre quarti delle morti a causa
di malattie non trasmissibili vivevano nei Paesi a basso e medio
reddito. Il rapporto evidenzia anche quali sono i driver degli impatti
riguardanti la salute ambientale, inclusi la distruzione degli
ecosistemi, il cambiamento climatico, la disuguaglianza,
l’urbanizzazione non pianificata, gli stili di vita insalubri e
dispendiosi e i modelli di consumo e di produzione non sostenibili – e
delinea i grandi vantaggi economici e per la salute che porterebbe
un’azione ambientale.
Secondo il rapporto, «il cambiamento climatico sta esacerbando la
scala e l’intensità dei rischi per la salute legati all’ambiente. Le
stime dell’Oms indicano che a causa del cambiamento climatico, tra il
2030 e il 2050, ogni anno potrebbero verificarsi 250.000 morti in più
, per lo più da malnutrizione, malaria, diarrea e stress da caldo».
I fattori ambientali chiave evidenziati nel rapporto comprendono:
l’inquinamento atmosferico, che
ogni anno uccide 7 milioni di persone in tutto il mondo. Di questi, 4,3
milioni sono causati dall’inquinamento atmosferico delle case, in
particolare tra le donne e bambini nei Paesi in via di sviluppo.
La mancanza di accesso all’acqua pulita e ai servizi igienici, che
si traduce in 842.000 persone che ogni anno muoiono di malattie
diarroiche, il 97% dei quali nei Paesi in via di sviluppo. Le malattie
diarroiche sono la terza principale causa dei decessi di bambini di età
inferiore ai 5 anni, che rappresentano il 20% di tutte le morti nei
bambini sotto i cinque anni.
L’esposizione chimica: circa
107.000 persone muoiono ogni anno per esposizione all’amianto e nel
2010 sono morte 654.000 persone per esposizione al piombo nel 2010.
Disastri naturali: Dalla
prima Conferenza sui cambiamenti climatici dell’Onu nel 1995, sono
morte 606.000 persone e 4,1 miliardi di esseri umani sono stati feriti,
rimasti senza casa o hanno avuto bisogno di assistenza di emergenza a
seguito di disastri legati al clima.
Il rapporto però dimostra anche che investire in un ambiente sano può
portare molteplici vantaggi: il successo della messa al bando di quasi
100 sostanze dannose per l’ozono ha permesso di evitare fino a 2 milioni
di casi di cancro della pelle e molti milioni di cataratta agli occhi
ogni anno entro il 2030, I benefici a livello globale dell’eliminazione
del piombo nella benzina sono stati stimati in 2.45 trilioni di dollari
l’anno, o il 4% del Pil mondiale, evitando circa 1 milione di morti
premature ogni anno. L’implementazione, misure economicamente
vantaggiose ha dimostrato di poter ridurre le emissioni di inquinanti
climalteranti di breve durata come il black carbon e il metano e
potrebbero ridurre il riscaldamento globale di 0,5° C entro la metà del
secolo e salvare 2,4 milioni di vite ogni anno con la riduzione
dell’inquinamento atmosferico entro il 2030. Gli investimenti da 18 – 60
dollari per lavoratore in programmi di prevenzione e per la salute nei
luoghi di lavoro salute possono ridurre le assenze per malattia del
27%, mentre il ritorno sugli investimenti nei servizi idrici e
igienico-sanitari è compreso tra 5 e 28 dollari per dollaro investito.
Per ottenere questi benefici, il rapporto raccomanda quattro approcci integrati:
Disintossicare: rimuovere le sostanze nocive e/o mitigare il loro impatto sull’ambiente in cui le persone vivono e lavorano.
Decarbonizzare: ridurre
l’uso di carburanti fossili e quindi le emissioni di anidride carbonica
(CO2) attraverso fonti rinnovabili. Nel ciclo di vita, l’impatto
ambientale di energia solare, eolica e idroelettrica legato a
inquinamento e salute umana è da 3 a 10 volte inferiore a quello delle
centrali elettriche a combustibili fossili.
Disaccoppiare l’uso delle risorse e cambiare stili di vita: Generare
l’attività economica e il valore necessari per sostenere la popolazione
mondiale con minor uso di risorse, meno sprechi, meno inquinamento e
meno distruzione ambientale.
Migliorare la resilienza degli ecosistemi e la protezione dei sistemi naturali del pianeta: Costruire
la capacità dell’ambiente, delle economie e delle società di
anticipare, reagire e recuperare a disturbi e shock attraverso la
protezione e la conservazione della diversità genetica e della
biodiversità terrestre, costiera e marina; rafforzare il ripristino
degli ecosistemi; ridurre le pressioni dall’allevamento del bestiame e
dell’industria del legname sugli ecosistemi naturali.
Il direttore esecutivo dell’Unep, Achim Steiner, ha detto: «Riducendo
l’infrastruttura ecologica del nostro pianeta e aumentando il nostro
impatto da inquinamento, abbiamo richiesto un prezzo sempre crescente in
termini di salute umana e il benessere. Dall’inquinamento atmosferico,
al l’esposizione chimica fino all’estrazione delle nostre risorse
naturali basilari, bbiamo compromesso i nostri vitali sistemi di
sostegno. Un pianeta più sano è una marea che solleva tutte le barche,
compresa la salute umana, ma anche le economie e le società. Attuando lo
sviluppo e il progresso nel campo della salute ambientale,
salvaguardiamo il nostro benessere. All’Unea-2, il mondo si sta
concentrando sui percorsi per garantire che l’ambiente sostenga la
salute umana, piuttosto che minacciarla».
L’Unea-2 analizzerà anche altri rapporti riguardanti salute umana e
attività antropiche: “Marine Plastic Debris and Microplastics: Global
Lessons and Research to Inspire Action and Guide Policy Change” rivela
che nel 2014 la produzione di plastica globale ha superato i 311 milioni
di tonnellate, un aumento del 4% rispetto al 2013. Tra 4,8 e 12,7
milioni di tonnellate finiscono in mare a causa di inadeguate politiche
di gestione e riutilizzo dei rifiuti e le microplastiche sono
particolarmente pericolose. In media, per ogni Km2 degli oceani del
mondo ci sono 63.320 particelle di microplastica che galleggiano in
superficie. Gli organismi marini – zooplancton, invertebrati, pesci,
uccelli marini e balene – possono essere esposti a microplastiche
attraverso l’ingestione diretta di acqua e indirettamente, come
predatori all’apice delle reti alimentari. I potenziali effetti negativi
dell’ingestione di microplastica comprendono risposte
immunotossicologiche, disturbi riproduttivi, sviluppo embrionale
anomale, alterazioni del sistema endocrino ed alterazioni
dell’espressione genica.
Un altro studio, “Gender and Plastic Management”, prende in esame i
diversi ruoli di uomini e donne nell’uso e consumo di plastica,
individuando le donne in regioni ricche come importanti per ridurre la
plastica nei beni di consumo di base.
Il “2016 Global Report on the Status of Legal Limits on Lead in
Paint” ha scoperto che gli sforzi per eliminare il piombo dalle vernici
stanno avendo successo: agli inizi del 2016, 70 dei 196 Paesi del mondo
avevano approvato dei limiti vincolanti per piombo nelle
vernici. Tuttavia, solo 17 Paesi richiedono che la vernice venga
testata e certificata riguardo al contenuto di piombo.
Unep Frontiers ha scoperto che «In tutto il mondo c’è stato un
aumento di zoonosi emergenti, focolai di zoonosi epidemiche, un aumento
della zoonosi di origine alimentare e una persistenza preoccupante delle
zoonosi trascurate nei paesi poveri. Mai prima d’ora così tanti animali
sono allevati da così tante persone e mai prima d’ora esistono così
tante opportunità esistevano per gli agenti patogeni di passare
dall’ambiente biofisico agli animali selvatici, dal bestiame alle
persone per le malattie zoonotiche o zoonosi».
Circa il 60% di tutte le malattie infettive negli esseri umani sono
zoonotiche, così come lo sono il 75% di tutte le malattie infettive
emergenti. Negli ultimi anni, diverse malattie zoonotiche emergenti
hanno fatto notizia per aver causato, o minacciato di causare, grandi
pandemie. Oltre all’influenza aviaria, la febbre della Rift Valley, la
sindrome respiratoria improvvisa acuta grave (SARS), la sindrome
respiratoria del Medio Oriente (MERS), il virus del Nilo occidentale,
Ebola e il virus Zika. Il rapporto conclude che negli ultimi 20 anni,
queste malattie emergenti hanno avuto costi diretti per più di 100
miliardi di dollari e che «Se questi focolai fossero diventati pandemie
umane, le perdite sarebbero state pari a diverse migliaia di miliardi di
dollari».
fonte: www.greenreport.it