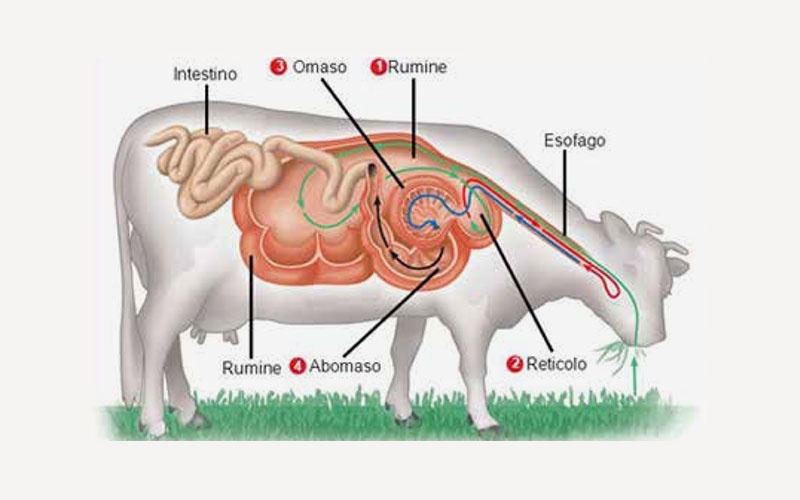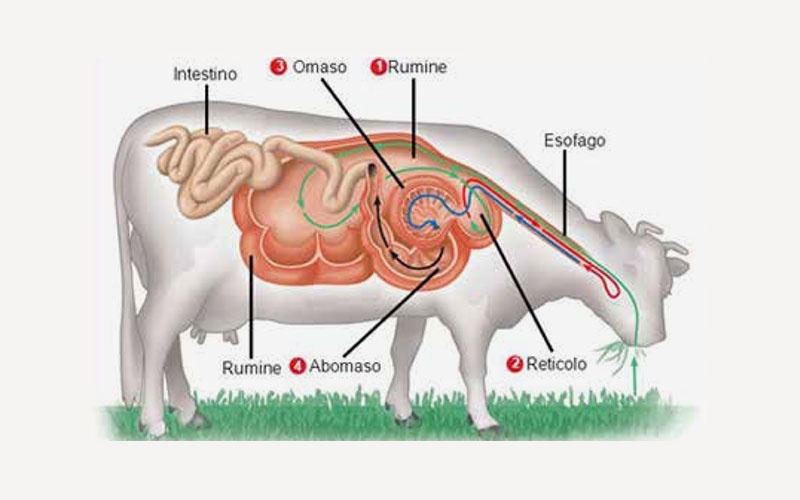Le fibre tessili sintetiche sono prodotte da combustibili fossili, petrolio e gas naturale, risorse non rinnovabili e generano impatti vari sull’ambiente sia in fase di produzione che di consumo ma anche successivamente quando si trasformano in rifiuti

La crisi dovuta al COVID-19 ha portato a un improvviso calo della domanda di prodotti tessili da parte dei consumatori, con conseguenti problemi di liquidità e disoccupazione nel settore, creando in questo comparto un vero e proprio shock, che potrebbe dare avvio a due diversi scenari:
il primo vede un rallentamento nella transizione verso un tessile più circolare e sostenibile
il secondo, al contrario, determina uno slancio verso il cambiamento radicale del comparto tessile rendendolo maggiormente circolare, con risultati economici e ambientali positivi.
Sappiamo che la ripartenza post COVID-19 dipenderà anche dall’adozione di nuovi modelli economici che terranno conto della potenzialità dell’economia circolare, ma affinché questa transizione si concretizzi, bisogna partire dall'analisi dei comparti produttivi, dagli elementi di criticità e dalla loro capacità di trasformazione.
Lo studio dell’Agenzia Europea dell’ambiente (di seguito EEA), "Plastic in textiles: towards a circular economy for synthetic textiles in Europe", pubblicato alla fine di gennaio 2021, vuole andare in questa direzione. Fornisce una panoramica sulla produzione di tessile sintetico in Europa, analizza gli impatti ambientali e indica alcuni ambiti su cui puntare maggiormente per trasformare il settore, rendendolo più sostenibile e circolare.
Non stiamo parlando di un settore di nicchia, in Europa i tessuti a base di plastica - o "sintetici" – fanno parte della nostra vita quotidiana. Sono presenti nei vestiti che indossiamo, negli asciugamani che usiamo e nelle lenzuola in cui dormiamo. Sono nei tappeti, nelle tende e nei cuscini con cui decoriamo le nostre abitazioni e gli uffici. Sono nelle cinture di sicurezza, nei pneumatici delle auto, nell'abbigliamento da lavoro e in quello sportivo.
Produzione e consumo
Il consumo globale di fibre sintetiche è passato da poche migliaia di tonnellate nel 1940 a più di 60 milioni di tonnellate nel 2018, e continua ad aumentare. Dalla fine degli anni '90, il poliestere ha superato il cotone come fibra più comunemente usata nel tessile.
La maggior parte delle fibre tessili sintetiche sono prodotte in Asia, l'Europa è il più grande importatore mondiale, pur essendo anch'essa una produttrice ed esportatrice. Secondo le stime sono state prodotte, nel 2018 in Europa, 2,24 milioni di tonnellate di fibre sintetiche, 1,78 milioni di tonnellate sono state importate, 0,36 milioni di tonnellate esportate e 3,66 milioni di tonnellate consumate.
Il grosso vantaggio delle fibre sintetiche è che sono economiche e versatili, consentendo la produzione di tessuti a basso costo, per questo sono molto utilizzate soprattutto nella fast fashion (moda usa e getta). Oltre il 70% delle fibre tessili sintetiche viene trasformato in abbigliamento e tessili per la casa. Il resto viene utilizzato per tessuti tecnici (ad esempio abbigliamento di sicurezza) e usi industriali (ad esempio materiali per veicoli e macchinari di vario genere).
Secondo l'European Bioplastic, la produzione e l'uso di fibre sintetiche a base biologica, purtroppo, ad oggi, è trascurabile.
Più della metà della produzione globale di fibre è costituita da poliestere, che risulta essere la fibra sintetica più comune (55 milioni di tonnellate nel 2018). Si tratta di una fibra resistente, prodotta a basso prezzo e utilizzata in una moltitudine di applicazioni. Dopo il poliestere, è il nylon la fibra sintetica più usata, nel 2018, ne sono state prodotte oltre 5 milioni di tonnellate e viene ampiamente utilizzata in collant, tappeti e ombrelli. di fibra di nylon.
Impatti sull’ambiente e sul clima delle emissioni in atmosfera
La produzione e il consumo di prodotti tessili generano pressioni e impatti ambientali come
emissioni di gas serra (GHG)
inquinamento dell'aria e dell'acqua
consumo del suolo, dell'acqua e di altre risorse.
La produzione di fibre sintetiche richiede grandi quantità di energia e contribuisce in modo significativo al cambiamento climatico e all'esaurimento delle risorse di combustibili fossili. Tuttavia, a differenza del cotone - la fibra naturale più comune - le fibre sintetiche quando vengono prodotte non richiedono l'uso di pesticidi o fertilizzanti tossici.
La gamma di impatti sull'ambiente dipende molto dal tipo di fibra. Fibre diverse hanno chiaramente impatti ambientali e climatici diversi, quindi non è facile valutare quali di queste sia da ritenersi più idonee.
Gli impatti ambientali e climatici specifici delle fibre sintetiche più comuni possono essere confrontati con il cotone, per chilogrammo di tessuto tinto. Il nylon, fibra sintetica, ha il più alto impatto, per chilogrammo, sul il cambiamento climatico e l'uso di combustibili fossili, mentre per quanto riguarda l'uso della terra, dell'acqua, l'eutrofizzazione e la scarsità di risorse minerali, è il cotone ad avere il più alto impatto per chilogrammo.
Un confronto simile può essere fatto tra poliestere e cotone: si stima che l'intero ciclo di vita di 1 kg di tessuto in poliestere sia responsabile del rilascio di più di 30 kg di anidride carbonica equivalente, mentre il cotone ne rilascia circa 20 kg.
È importante tenere presente che gli impatti dipendono anche dai volumi di produzione delle fibre e dei tessuti. Per esempio, mentre la produzione di poliestere usa meno energia del nylon, il suo tasso di produzione annuale è molto più alto e quindi comporta impatti complessivi maggiori.
Inoltre bisogna valutare gli effetti ambientali nel loro complesso, in quanto questi non sono generati solo durante la produzione di tessuti ma anche durante l'uso, si pensi al lavaggio domestico e/o industriale, all'asciugatura e alla stiratura. Se da un lato queste attività richiedono molta energia e contribuiscono al cambiamento climatico, dall'altro consentono un uso più lungo e intenso del prodotto, aumentandone la durata.
Ai problemi sopra menzionati si aggiunge quello delle microplastiche, problema ambientale abbastanza recente, oggetto di ricerca e, in genere, non valutato nella tipica analisi del ciclo di vita di un tessuto. C'è ancora molto da studiare e da capire sulla portata e sull' impatto delle microplastiche sulla salute umana e sull'ambiente. Le microplastiche vengono rilasciate dai tessuti sintetici durante tutto il loro ciclo di vita: in fase di produzione di fibre e tessuti, durante l'uso e il lavaggio fino allo smaltimento, che sia tramite discarica, incenerimento o riciclaggio. Si stima che ogni anno entrino nell'ambiente marino tra le 200 000 e le 500 000 tonnellate di fibre microplastiche provenienti dai tessuti.
Verso un’economia circolare delle fibre sintetiche
Nel piano d'azione per l'economia circolare del 2020, la Commissione europea ha identificato il tessile come un settore tra quelli prioritari su cui lavorare per raggiungere modelli di economia circolare. Il piano d'azione riconosce che "i tessili sono la quarta categoria a più alta pressione per l'uso di materie prime primarie e acqua, dopo il cibo, l'alloggio e i trasporti, e la quinta per le emissioni di gas serra". Il piano d'azione contempla la strategia dell'UE per il settore tessile volta a "rafforzare la competitività industriale e l'innovazione, dando impulso al mercato europeo dei tessili sostenibili e circolari, compreso il mercato del riutilizzo dei tessili, meno improntato al fast fashion e rivolto a nuovi modelli di business".
In linea con il piano d'azione per l'economia circolare del 2020, questo studio e la relazione ETC/WMGE evidenziano alcuni ambiti su cui lavorare per rendere la produzione e il consumo di tessuti sintetici più circolare e sostenibile:
scelta di fibre sostenibili
controllo del rilascio di microplastiche
miglioramento della raccolta differenziata, riutilizzo e riciclaggio.
Per quanto riguarda la scelta di fibre sostenibili, questa definisce le proprietà e le prestazioni del prodotto tessile, ma determina anche l'impatto ambientale risultante. Il passaggio alle fibre naturali o a base biologica può ridurre l'uso di risorse come i combustibili fossili e anche limitare le emissioni di gas serra.
Il principio guida, secondo l'EEA, è che la scelta della fibra dovrebbe corrispondere all'applicazione del prodotto tessile, alle proprietà richieste, alla durata prevista e ai processi di fine vita. Nella fase di progettazione, vengono fatte scelte importanti sui tipi di fibre da usare per un particolare prodotto o una specifica applicazione. L'importanza della selezione delle fibre adatte allo scopo implica che non serve escludere certi tipi di fibre - per esempio quelle sintetiche - e che non esiste un tipo di fibra che da solo possa rappresentare l’industria tessile sostenibile.
Per quanto attiene, invece, il controllo del rilascio di microplastiche, possiamo dire che, al momento, sono state avviate diverse iniziative per studiare i fattori che influenzano il rilascio di microplastiche - e per valutare il loro effetto sulla salute umana e sull'ambiente. Allo stesso tempo, si stanno studiando molte soluzioni, come la produzione di materiale tessile adattato ai filtri nelle lavatrici, per ridurre la perdita di microplastiche nell'acqua o nell’aria durante il ciclo di vita del tessuto.
Con riferimento infine al miglioramento della raccolta differenziata, del riutilizzo e del riciclaggio, questi si mostrano fondamentali per ridurre la domanda di fibre vergini e quindi raggiungere un'economia circolare.
Il riciclaggio delle fibre è particolarmente impegnativo nel caso dei tessili sintetici, sia per ragioni tecniche che economiche. Una migliore raccolta differenziata dei tessili, un'accurata selezione automatizzata e un riutilizzo e riciclaggio dei tessili di alta qualità hanno un potenziale significativo per ridurre l'impatto ambientale.Tuttavia, molte sfide tecniche, economiche e sociali dovranno essere superate per facilitare e incoraggiare il riutilizzo e rendere il riciclaggio delle fibre tecnicamente ed economicamente fattibile.
"Plastic in textiles: towards a circular economy for synthetic textiles in Europe"
fonte: www.arpat.toscana.it
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria