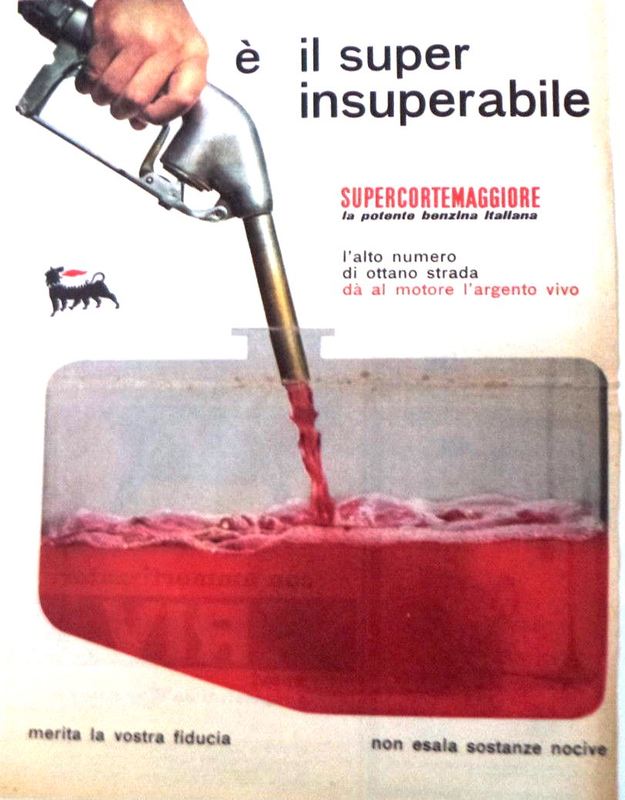VINCENZO MIGALEDDU, FERDINANDO LAGHI, AGOSTINO DI CIAULA,
CARLO ROMAGNOLI, PATRIZIA GENTILINI
Introduzione
Il petrolio è una miscela
naturale di idrocarburi che può presentarsi,
in giacimenti
sotterranei, alla stato solido, simil–solido, liquido o
gassoso.
La gravità specifica
della miscela liquida –cioè la sua densità rispetto
a quella dell’acqua, alla
temperatura di 15,5°C– ne caratterizza il
cosiddetto grado API
(acronimo derivante da American Petroleum
Institute, il principale
ente professionale USA nel campo chimico e
petrolchimico), che è
l’unità di misura internazionale di pesantezza o
leggerezza del greggio.
Tanto più il greggio è leggero, tanto maggiore
è la sua qualità.
La perforazione dei pozzi
avviene attraverso uno scalpello rotante,
collegato ad una piastra
rotante e spinto da aste cave all’interno delle
quali circolano i fluidi di perforazione. Mentre il pozzo
progredisce in
profondità, viene
rivestito da tubazioni
telescopiche di
diversi diametri
— da 75 cm, a scalare, fino a 15–20 cm —, cementate fra loro
e alle
pareti rocciose del foro.
Al suo interno viene collocato il tubo di
produzione. La sempre
maggiore profondità dei pozzi, ha richiesto
nuove tecnologie di
perforazione, che sono risultate più costose, più
impattanti e non prive di
criticità ambientali e sanitarie.
I fluidi di perforazione (drilling fluids), di cui spesso non si
conosce
quali composti e sostanze
chimiche contengano, sono immessi in
un circuito idraulico e
spinti nuovamente verso il fondo del pozzo,
dopo esser risaliti in
superficie e dopo essere stati filtrati, o vagliati,
dai detriti di perforazione. La perforazione di un
pozzo può avvenire
sulla terra ferma (onshore) o in mare (offshore); gli impatti ambientali
e
sanitari,
conseguentemente, saranno di diversa natura e graveranno
in maniera differente in questi differenti contesti.
Da alcuni anni i pozzi
tradizionali, verticali, sono stati sostituiti da
perforazioni non
convenzionali, direzionali (oblique, orizzontali —
singole e multiple). La
perforazione idraulica (hydraulic frackturing/
fracking) delle rocce viene
utilizzata per massimizzare la produzione
di gas, petrolio e
risorse geotermiche incarcerate in piccole riserve,
nei sedimenti geologici
frantumati dalla forte pressione dei liquidi
iniettati nei pozzi.
In ogni caso, i possibili
inquinamenti dell’aria, del suolo, delle falde
acquifere di superfice e
di profondità, del mare e delle coste, possono
avvenire per:
a) emissioni in aria;
b) spandimenti di scarti
di perforazione e/o produzione (fanghi,
detriti, acque di
scarto);
c) esplosioni, blowout
(emissioni incontrollate);
d) incendi;
e) perdite dai pozzi;
f ) perdite dai serbatoi;
g) perdite dalle condotte
sottomarine o di superfice;
h) perdite dai mezzi di
trasporto (navi, autocisterne, etc.) (1).
Trivellazioni in mare (offshore)
Prospezione
I danni all’ambiente
marino e ai suoi ecosistemi possono avvenire
già nella fase
esplorativa. Tra i metodi di prospezione geo–fisica dei
fondali marini, viene
proposto prevalentemente la tecnica dell’air gun.
Tale sistema funziona con
un compressore, solitamente posto su un
battello, che dopo aver compresso
l’aria tramite un tubo, la immette
nell’air gun. Una volta
iniettata in una camera stagna immersa nell’acqua,
raggiunta la pressione
richiesta, l’aria viene espulsa velocemente,
generando una bolla al di
sotto della superficie dell’acqua: l’espansione
improvvisa produce
un’onda di compressione nel mezzo liquido. A
livello del fondo marino
si produce una riflessione e una vibrazione,
utili per valutare la
presenza di giacimenti di idrocarburi (2). L’esplosione
di un air gun produce
rumore, con un pressione sonora fino 235
db, che aumenta allorché
più air gun sono disposti in batteria. Questi
valori possono recare
danni alla fauna
marina ed in particolare ai cetacei
(3–5).
Produzione
Impatti ambientali. In una prima fase,
l’inquinamento dell’ambiente
marino interessa
prevalentemente la colonna d’acqua di mare sottostate
la piattaforma di
estrazione. Gli idrocarburi a catena pesante
tendono a depositarsi sul
fondo, mentre quelli a catena leggera galleggiano in superficie ed evaporano. Gli impatti possono
essere differenti, in relazione
all’entità e alla tipologia dello sversamento a mare (spandimenti di scarti di
perforazione e produzione, esplosioni, blowout, incendi, perdite da pozzi e
serbatoi, condotte sottomarine o di superficie
e mezzi di trasporto). In
assenza di incidenti rilevanti, è interessante
quanto riportato in un
recente rapporto di Greenpeace, relativo alle
attività estrattive in
Adriatico (34
piattaforme, sulle 130 piattaforme
offshore attive in Italia),
esaminate dal 2012
al 2014. Tra i composti che
superano con maggiore
frequenza i valori definiti dagli Standard di
Qualità Ambientale (o
SQA, definiti nel DM 56/2009 e 260/2010), rilevati
nei sedimenti prossimi
alle piattaforme, troviamo metalli pesanti,
quali cromo, nichel, piombo
(e talvolta anche mercurio, cadmio e arsenico).
Inoltre, sono risultati
rilevabili anche idrocarburi
policiclici aromatici
(IPA), come fluorantene,
benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene,
benzo[a]pirene e altri,
variamente associati. Alcune tra queste sostanze
sono cancerogene e in
grado di risalire la catena alimentare attraverso
la bio–magnificazione,
raggiungendo così l’uomo in concertazioni
elevate, tali da causare
seri danni all’organismo.
La relazione tra
l’impatto dell’attività delle piattaforme e la catena
alimentare emerge ancora
più chiaramente dall’analisi dei tessuti dei
mitili prelevati presso
le piattaforme stesse. Gli inquinanti monitorati,
in riferimento agli SQA
identificati per questi organismi (appartenenti
alla specie Mytilus galloproncialis), sono tre: mercurio, esaclorobenzene
ed esaclorobutadiene. Di queste tre sostanze,
solo il mercurio viene
abitualmente misurato nei
mitili nel corso dei monitoraggi ambientali.
I risultati mostrano che
circa l’86% del totale dei campioni
analizzati
nel corso del triennio 2012–2014 superava il limite di
concentrazione
di mercurio indicato
dagli SQA (6).
Esposizione lavorativa: nella valutazione dei
rischi sanitari, per i lavoratori
delle piattaforme vengono
presi in considerazione diversi fattori,
in relazione all’epoca di
svolgimento dell’attività estrattiva. Infatti, in
alcuni studi si mette in
evidenza la maggiore complessità di estrazione
dei giacimenti più
recenti di petrolio e gas, “difficili” a causa della loro
posizione remota (regioni
artiche, distanze notevoli dalle coste), per
la loro eccessiva
profondità –sia in mare che sotto la crosta terreste–,
per l’elevata quantità di
idrogeno solforato (H2S). Questi fattori
richiedono
un maggiore sforzo per
raggiungere elevati livelli di sicurezza
impiantistica e
gestionale. L’esempio delle sabbie bituminose canadesi
è esplicativo della
maggiore complessità impiantistica necessaria per
ottenere un prodotto
commerciale (7).
Tra le esposizioni
studiate dal 1970
al 2005, vengono riportati 18
agenti cancerogeni, tra
certi e sospetti, tra cui il benzene, le fibre d’asbesto
e di ceramica refrattaria,
la formaldeide, il tetracloroetilene, oli minerali
misti, vapori e particolato
respirabile (8). Tra le esposizioni più
recenti
troviamo anche l’H2S e la conferma dei
comuni agenti chimici descritti
in precedenza. Nè vengono
trascurati, nell’ambito dei rischi per la
salute, l’esposizione ai
rumori, ad agenti biologici ed a condizioni di
stress da lavoro per
mancato rispetto dei principi ergonomici (7).
Recentemente è stato
pubblicato uno studio riguardante l’incidenza
tumorale su un’ampia
coorte—41.140 addetti– di lavoratori
norvegesi,
divisi per sesso,
impiegati sulle piattaforme petrolifere. È stato rilevato
un rapporto
standardizzato di incidenza (SIR) di 1.17 (95% CI 1.02–1.34),
rispetto agli attesi, per
tutti i tumori in entrambi i sessi. Tra le donne
è risultata elevata
l’incidenza per la leucemia
mieloide acuta (SIR
5.29,
95% CI 1.72–12), per il melanoma maligno (SIR 2.13, 95% CI 1.41–3.08) e
per il tumore del polmone (SIR 1.69, 95% CI 1.03–2.61). Tra i maschi, il
numero totale di tutti i
tumori è risultato solo lievemente superiore
agli attesi (SIR 1.03, 95% CI 0.99–1.08), ma non per i tumori della pleura
(SIR 2.56, 95% CI 1.58–3.91) e della vescica (SIR 1.25, 95% CI 1.05–1.49)
che, invece, hanno
mostrato un notevole incremento (9).
Trivellazioni in Terra
(onshore). In
questo paragrafo vengono riassunti non soltanto gli impatti ambientali e
sanitari delle trivellazioni
non convenzionali –per
profondità e/o direzione, e non solo– per la
ricerca di idrocarburi
liquidi o gassosi, ma anche quelli per la ricerca
di risorse geotermiche di
profondità (oltre i 2.000 metri).
Trivellazioni e rischi sanitari da emissioni
In questo ambito, uno dei
risultati inaspettati è il rilievo di un rischio
sanitario da emissioni in impianti
di perforazione direzionale o di fratturazione idraulica. A tal proposito,
infatti, sono stati stimati i rischi
sanitari per
l’esposizione alle emissioni in atmosfera derivanti da un
progetto di trivellazione
di un pozzo per ricerca di gas naturale in
una località del
Colorado, con l’obiettivo di migliorare la prevenzione
primaria, con la
valutazione dell’impatto sanitario di tale attività. Sono
stati valutati, secondo
le linee guida dell’EPA (Agenzia americana per
l’ambiente), gli indici
di pericolo per le patologie croniche e sub croniche
non tumorali e il rischio
per tumore nelle popolazioni residenti
entro mezzo miglio e oltre
mezzo miglio dal pozzo. Lo studio dimostra che
i residenti entro mezzo miglio
dal pozzo hanno un rischio sanitario
superiore a chi vive a
distanza maggiore. Le esposizioni sub croniche
all’inquinamento
atmosferico, durante le attività di completamento
del pozzo, si sono
dimostrate nello studio il fattore di rischio più
elevato.
L’indice di pericolo sub
cronico non tumorale (HI),
di 5, nei residenti
entro le cinque miglia
dal pozzo, è stato attribuito principalmente all’esposizione al
trimetilbenzene, allo xilene e agli idrocarburi alifatici.
L’indice di pericolo cronico è stato valutato di 1 e di 0,4, rispettivamente,
nei residenti entro e
oltre il mezzo miglio dal pozzo. Il rischio cumulativo
per cancro è risultato di
10
e di 6 su un milione,
rispettivamente
nei residenti entro e
oltre il mezzo miglio dal pozzo; il benzene è stato
identificato come il
maggiore determinante del rischio. Il lavoro indica
come una analisi del
rischio, con l’impiego degli indici di pericolo, sia
necessaria alla
prevenzione di rischi sanitari; è evidente che alla luce
di tali dati, il
presupposto che un pozzo esplorativo non abbia impatto
sanitario, viene a cadere
non solo per il lavoratori ma anche per la
popolazione che vive nei
pressi del pozzo (10).
Emissione di H2S
Spesso, negli studi di
impatto ambientale relativi a pozzi per la ricerca
di idrocarburi solidi o
gassosi –ma anche per ricerca di risorse geotermiche–, il problema dell’H2S non viene affrontato o è sottovalutato
sul piano dell’adozione di adeguate misure di protezione. Questo è ancor
più vero per i pozzi che
riguardano la ricerca di risorse geotermiche
che vengono fatte passare
come innocue e senza impatti sul piano
ambientale e sanitario.
Eppure sul sito ENI Scuola possiamo leggere:
L’energia geotermica
viene di solito considerata un’energia pulita. La sua
produzione in teoria non
dovrebbe infatti produrre polveri o sostanze tossiche
che vengono poi immesse
nell’atmosfera e non vi dovrebbero essere
rifiuti tossici da
smaltire: l’unico sottoprodotto del processo energetico sono
i pennacchi bianchi delle
nuvole di vapore acqueo che si liberano dalle torri
di raffreddamento. Tuttavia,
purtroppo, le cose in natura non sono così
semplici e “pulite”. Le
acque che circolano nel sottosuolo raramente sono
acque dolci: nella
maggior parte dei casi si tratta di soluzioni saline altamente
concentrate, spesso
contenenti sostanze fortemente inquinanti e tossiche. Il
vapore acqueo è in genere
associato ad altri gas, come H2S
e CO2, mentre
nelle acque sono spesso
presenti metalli
pesanti o arsenico.
Questa caratteristica,
tra le altre cose,
impedisce un uso diretto delle acque geotermiche:
a causa delle
caratteristiche chimiche combinate con le elevate temperature,
queste acque sono
fortemente aggressive e corrodono rapidamente
le tubature e le
attrezzature con cui vengono a contatto, per cui si rende
necessario l’utilizzo di
materiali speciali. Acque con queste caratteristiche,
ovviamente, non possono
nemmeno venire a diretto contatto con suoli e
prodotti agricoli,
animali o cibi e il loro uso deve necessariamente essere
interdetto (11).
È, dunque, la stessa ENI
a smentire l’innocuità delle emissioni di
H2S e CO2 delle acque geotermiche.
La perforazione del sottosuolo fino
ad una profondità di 2.000– 3.000 metri, per ricerche
geotermiche o
di idrocarburi liquidi o
gassosi, non può non porsi i problema dell’H2S.
A tal proposito, va
ricordato come evidenze scientifiche riportino per
esposizione cronica, già
per basse concentrazioni, comprese tra 0,0057
e 0,01 ppm, disturbi, quali
bruciori agli occhi e al naso, tosse, mal
di testa, disturbi
neuro–psicologici, ritardi verbali, deficit motori di
coordinazione ad occhi
chiusi, riduzione della presa manuale e del
riconoscimento cromatico
(12–16 ). Alla luce di tali
prove, il Governo
Federale USA ha stabilito
un limite soglia di 0.001
ppm
con valore minimo
nello
stato del Massachusetts di 0.00065 ppm (17, 18). In esposizione acuta,
come può accadere in presenza di incidenti, con valori compresi tra i
300 e fino a 1.000 ppm, si può avere edema
polmonare, intossicazione
acuta, danni al sistema
nervoso, collasso, paralisi, morte immediata
(19).
Radon
Nella fase di cantiere,
nella fase di perforazione del pozzo e nella fase
di prova e di produzione,
non vengono mai presi in esame emissioni
come il trimetilbenzene,
lo xilene, gli idrocarburi alifatici e il benzene,
né, tanto meno, vengono
presi in considerazione il particolato fine e
ultrafine (PM 2,5, PM 0,1), le nanoparticelle e il
Radon. Le nanopolveri
possono essere
responsabili di patologie respiratorie come bronchiti,
asma, enfisema polmonare
e tumori. Le polveri più sottili sono in
grado di penetrare
all’interno della struttura cellulare e modificarne
la composizione. Il Radon
222
è un gas radioattivo
espressione del
decadimento della catena
dell’Uranio 238/235 e Radio. La principale
fonte di questo gas
risulta essere il terreno con elevate concentrazioni
in particolari reservoir sotterranei. È
cancerogeno (gruppo 1
IARC)
se inalato, in quanto
emettitore di particelle alfa (20).
La normativa
statale fa riferimento al
Decreto legislativo 26/05/00 n. 241 dove si è
fissato un livello di 500 Bq/metro cubo.
È perciò evidente come il
Radon ponga un problema di
emissioni
in atmosfera e diffusivo nell’acqua (quindi
delle falde
eventualmente
intercettate).
Una particolare
attenzione va posta al trattamento dei fanghi che
risulterebbero dei TENORM
(Technologically Enhanced Naturally
Occuring Radioactive
Materials), cioè rifiuti che in seguito alla lavorazione vedono incrementare la
concentrazione di uranio 238/235
da dove origina in Radon.
(20). Spesso si ignora il
regime normativo
USA, ma soprattutto
Comunitario e quello statale italiano. Infatti,
come noto, le attività di
perforazione possono produrre materiale
contenente elementi
radioattivi che devono essere debitamente classificati, stoccati e messi in
assoluta sicurezza per essere smaltiti. L’EPA definisce come NORM (Naturally
Occuring Radioactive Materials) i
materiali che contengono
radionuclidi naturali quali il 40K
ed i membri
delle tre famiglie
radioattive naturali, dell’238U, dell’235U e del 232Th in
concentrazioni superiori
alla media della crosta terrestre; essi sono
responsabili dell’86% dell’esposizione a cui
è soggetto l’uomo. L’acronimo TENORM (Technologically Enhanced NORM) si
riferisce,
invece, ad un materiale
che, a differenza del NORM, vede una
concentrazione di radionuclidi naturali aumentata a causa della tecnologia del
processo di lavorazione subita dalla materia prima.
Che si tratti di evidenze
scientifiche ben consolidate, lo dimostra
la presenza di un
riferimento legislativo anche nel sistema normativo
della Repubblica Italiana
(vedi il D. Lgs n°241 del 26/05/2000 “Attuazione
della Direttiva 96/29/EURATOM in materia di
protezione sanitaria della
popolazione e dei
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”,
G.U. n. 203 del 31 agosto 2000–Supplemento Ordinario n.140) che
individua tra le attività
che producono TENORM e che richiedono
un controllo: le attività
industriali che utilizzano minerali fosfatici e i
depositi per il commercio
all’ingrosso dei fertilizzanti; la lavorazione
di minerali nella
estrazione di stagno, di ferro niobio da pirocloro e di
alluminio da bauxite; la
lavorazione di sabbie zirconifere e la produzione
di materiali refrattari;
la lavorazione di terre rare; la lavorazione e
l’impiego di composti del
torio (elettrodi per saldatura, produzione di
lenti, reticelle per
lampade a gas); l’estrazione
e la raffinazione di petrolio
e l’estrazione di gas.
Tali norme sono state
confermate e attualizzate dalla Direttiva
2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013. In tale direttiva, alla
SEZIONE
2 “Controllo
regolamentare”, l’articolo 23 riguarda l’individuazione
di pratiche che
comportano l’impiego di materiali contenenti
radionuclidi presenti in
natura:
Gli Stati membri
garantiscono l’individuazione di classi o tipi di pratiche
che comportano l’impiego
di materiali contenenti radionuclidi presenti in
natura e che determinano
un livello di esposizione dei lavoratori o individui
della popolazione non
trascurabile dal punto di vista della radioprotezione.
L’individuazione è effettuata con i mezzi
appropriati, tenendo conto dei
settori industriali
elencati nell’allegato VI.
La dispersione di
radioisotopi nell’ambiente, in seguito a eventi
naturali, a situazioni
incidentali o a carenze di controllo può esporre la
popolazione a dosi da
irraggiamento esterno (contatto) e da irraggiamento interno (ingestione e
inalazione) con esposizioni che possono protrarsi anche per lunghi periodi e
che vanno ad aggiungersi a quelle medie naturali. I radioisotopi dispersi
nell’ambiente possono subire il fenomeno della bio–magnificazione entrando nelle catene biologiche e
quindi subire processi
che possono portarli ad accumularsi in alcune
sostanze destinate
all’alimentazione animale e umana, dando luogo così a
condizioni di rischio
particolari. Sugli
effetti deterministici e
stocastici
sugli esseri viventi e in
particolare sugli esseri umani, si rimanda ad
una letteratura più che
consolidata.
Fluidi di perforazione e
rischi sanitari
L’impiego di fluidi di
perforazione a base di acqua può apparire rassicurante.
A tali fluidi vengono,
per altro, addizionati altri materiali,
per migliorare le
capacità di trasporto e di appesantimento e vengono
inoltre aggiunti additivi
chimici per controllare la loro capacità
di fluidificazione,
variandone la viscosità. Tra le sostanze chimiche
additive vengono anche
impiegate antischiumogeni, lubrificanti e anticorrosivi.
Durante le perforazioni
possono essere impiegati fluidi
di perforazione con
caratteristiche differenti, in relazione alle
diverse
condizioni di
perforazione che si possono verificare nell’avanzamento
del pozzo. I composti per
formare i fluidi di perforazione miscelati
in diverse proporzioni, a
seconda delle varie fasi della perforazione,
sono: la soda ash, il visco xc 84, avasil ft, il cloruro di potassio, la barite,
il visco 83 xlv, l’avapolymer 5050, mica c/f, granular m, granular f, avacid
50, intasol, avagreenlube, avatensio lt, de block s lt. Questi composti chimici
agiscono, come detto, con
funzioni diverse (riduttori di filtrato,
viscosizzanti, biocida,
intasanti, antipresa, lubrificanti, stabilizzatori di
argille, antischiuma).
Per la pericolosità di
questi prodotti utilizzati nelle attività di estrazione
petrolifera, si fa spesso
riferimento al Offshore Chemical Notification
Scheme (OCNS) dove essi vengono
classificati tra i meno pericolosi
(E), ma dove non viene
certificata l’assenza di pericolosità né, tanto
meno, la loro innocuità.
In letteratura, invece, è stata recentemente
riportata la pericolosità
relativa all’impiego di tali liquidi di perforazione,
legata all’impatto sulla qualità delle
acque profonde e superficiali,
nonché la possibile tossicità dei liquidi e dei
fanghi in risalita (21–24). In
particolare, si fa
riferimento, per quanto riguarda i liquidi di perforazione,
alla assenza del numero
CAS (Chemical Abstracts Service) che
ne identifica i
componenti — presenti nelle miscele di vari prodotti —
e i loro corrispondenti effetti sulla salute (22).
La soda ASH può avere un’azione acuta
irritante su pelle, congiuntiva
e mucosa dell’apparato
respiratorio e digerente; un’azione cronica
può determinare danni
agli organi bersaglio. La barite nelle monografie
IARC (25) può essere cancerogena
(gruppo 1) se inalata. Spesso,
negli studi di impatto
ambientale, non viene fatto nessun riferimento
a questo possibile
fattore critico durante le fasi di lavorazione e di
trasporto. Si fa
semplicemente cenno al contenimento della barite in
un silos: . . . nelle vicinanze della
vasca di stoccaggio delle acque industriali,
sarà predisposta una
soletta in calcestruzzo per la dislocazione dei silos
contenenti la barite
necessaria ad appesantire opportunamente il fluido di
perforazione.
In letteratura su 994 prodotti usati come
liquidi di perforazione,
ben 353 sostanze, identificate
con il corrispettivo numero CAS, hanno
effetti sulla salute. In
particolare, più del 75% delle sostanze chimiche
hanno effetti sulla pelle, sulle
congiuntive, sugli organi di senso e
sulle mucose
dell’appartato respiratorio e gastro–intestinale; il 40–50%
hanno effetti sul sistema nervoso
centrale e periferico, il sistema immunitario,
cardiovascolare e
urinario; il 37
% hanno effetti sul sistema
endocrino; il 25% può avere una azione
geno–tossica e cancerogena
(24).
L’Unione Europea ha
selezionato 564
sostanze sospettate di
essere
interferenti endocrini: di queste, 147 possono essere
persistenti nell’ambiente o prodotte in grandi volumi; 66 è provato che possano
agire come interferenti endocrini (categoria 1), mentre di 52 c’è solo qualche prova
che siano potenziali interferenti endocrini (categoria 2).
Fonte Ministero
dell’Ambiente: Gli
interferenti endocrini, secondo il
Regolamento REACH,
appartengono alla categoria delle sostanze individuate
come “estremamente
preoccupanti”, per le quali è previsto l’obbligo di
autorizzazione.
Per sostanze estremamente preoccupanti si intendono, ai sensi
dell’art.
57 del Regolamento, le
sostanze classificate come cancerogene,
mutagene e tossiche per la
riproduzione (CMR),
le sostanze identificate
come persistenti,
bioaccumulabili e tossiche (PBT), quelle identificate
come molto persistenti e
molto bioaccumulabili (vPvB) ed infine le
sostanze aventi proprietà
che perturbano il sistema endocrino, per le
quali è scientificamente
comprovata la probabilità di effetti
gravi per
Impatti ambientali e
sanitari delle trivellazioni per terra e per mare 167
la salute umana o per
l’ambiente e che danno adito ad un livello di
preoccupazione
equivalente a quella delle altre sostanze”.
Anche se a tutt’oggi i
criteri per classificare queste sostanze non
sono stati ancora
stabiliti e mancano strategie condivise a livello internazionale, per quanto
concerne i test di valutazione, alcune sostanze, riconosciute come interferenti
endocrini, sono comunque già oggetto di restrizioni e/o limitazioni a livello
europeo, in relazione alle
loro proprietà di
persistenza e bioaccumulo, e quindi sottoposte agli
obblighi di
autorizzazione previsti per le sostanze PBT e vPvB.
Riferimenti bibliografici
[1] COLELLA
A;CIVITA
M. L’impatto ambientale del petrolio. In mare e in terra,
Galaad Edizioni, 2015.
[2] ROBERT
E. SHERIFF. Encyclopedic Dictionary of Exploration Geophysics —
Third Edition, Tulsa, Society of
Exploration Geophysicists, 1991.
[3] THIELE, L. & ODENGAARD, J. Underwater noise from the propellers of a triple
screw container ship. Rep. 82.54. Copenhagen: Odengaard and Danneskiold–
Samsoe K/S. (1983).
[4] TODD, S., STEVICK,
P., LIEN, J., MARQUES,
F. & KETTEN, D. Behavioural
effects
of exposure to underwaterexplosions in humpback whales (Megaptera
novaeangliae). « Can. J. Zool ». 74, 1661–1672, 1996.
[5] WARDLE, C.S., CARTER,
T.J., URQUHART, G.G., JOHNSTONE,
A.D.F., ZIOLKOWSKY,
A.M., HAMPSON,
G., E D.MACKIE
(2001). Effects of seismic air guns
on marine fish. Continental Shelf Research Vol. 21 pp. 1005–1027.
[6] http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2016/Trivelle_
Fuorilegge.pdf.
[7] NIVEN
K. AND. MCLEOD
R. Offshore industry: management of health
hazards
in the upstream petroleum industry; Occupational Medicine 2009;
59:304–309.
[8] STEINSVAG
K, BRATVEIT
M, MOEN
BE. Exposure to carcinogens for defined
job categories in Norway’s offshore petroleum industry, 1970 to 2005
;
« Occup Environ Med » 2007;64:250–258.
[9] STENEHJEM
J. S., KJÆRHEIM K.,
RABANAL K. S. AND.
GRIMSRUD T. K. Cancer
incidence among 41 000 offshore
oil industry workers «
Occupational Medicine
» 2014;64:539–545.
168 Vincenzo Migaleddu,
Ferdinando Laghi, Agostino Di Ciaula, [. . . ]
[10] LISA
M. MCKENZIE, ROXANA
Z. WITTER, LEE
S. NEWMAN, JOHN
L. ADGATE
Human health risk assessment of air
emissions from development of
unconventional natural gas resources. « Sci Total Environ »; 2012.
[11]
http://www.eniscuola.net/wp–content/uploads/2013/11/migrazione/
assets/7214/pdf_geotermica_3.pdf.
[12] Environmental Protection Agency of the
United States of America, Report
to congress on hydrogen sulfide air
emissions associated with the extraction
of oil and natural gas, EPA–36453/R–93–045
1993.
[13] M. S. LEGATOR,
C. R. SINGLETON, D. L. MORRIS AND D.
PHILLIPS Health
effects
from Chronic low–level exposure to hydrogen sulfide, Archives of
Environmental Health 56 123; 2001.
[14] K. PARTTI–PELLINEN, O. MARTILLA,V.
VILKKA V The South Karelia air pollution
study: Effects of low–level exposure to malodorous
sulfur compounds on
symptoms Archives of Environmental Health, 51 315 1996.
[15] K. H. KILBURN.
Evaluating health effects from exposure to hydrogen sulfide:
central nervous system dysfunction, Environmental Epidemiology and
Toxicology 207;
1999.
[16] D. C. FULLER AND A.J.
SURUDA. Occupationally related hydrogen sulfide
deaths in the United States from 1984 to 1994,
Journal of Occupational and
Environmental Medicine 42 939; 2000.
[17] FY2006
Government Unique Standards used in lieu
of Voluntary Consensus
Standards,
http:www.whitehouse.govombinforegreports8th annual
nist rpt 2004.pdf.
[18] Toxicological profile for hydrogen
sulfide u.s. department of health
and human services; Public Health Service Agency for Toxic
Substances and
Disease Registry; July 2006.
[19] C. H. SELENE AND J.
CHOU. Hydrogen sulfide: human effects, Concise International
Chemical Asessment Document 53, World Health Organization
Ginevra 2003 http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/
cicad53.pdf
ultima vista 2–6– 2013.
[20] NICOLL
G. Radiation sources in natural gas well activities. « Occup Health
Saf »;81(10):22, 24, 26; Oct 2012.
[21] SG OSBORN,
A VENGOSH, NRWARNE.
Methane contamination of drinking
water accompanying gas–well drilling and
hydraulic fracturing;
« National
Acad Sciences », 2011.
[22] THEO
COLBORN, CAROL
KWIATKOWSKIA, KIM
SCHULTZA&MARY BACHRANA.
Natural Gas Operations from Health
Perspective; Human and EcoloImpatti
ambientali e sanitari delle
trivellazioni per terra e per mare 169
gical Risk Assessment: An International
Journal; Volume 17, Issue 5,
2011.
[23] VIDIC
RD, BRANTLEY SL,
VANDENBOSSCHE JM, YOXTHEIMER D,
ABAD JD.
Impact of shale gas development on
regional water quality. Science.
2013.
[24] Shale gas development impacts on surface water quality in
Pennsylvania.
« Proc Natl Acad Sci » U S A. 2013 Mar 26;110(13):4962–7. doi: 10.1073/pnas.
1213871110. Epub 2013 Mar
11.
[25] Monografia IARC,
Vol 68, 1997.
fonte: www.isde.it