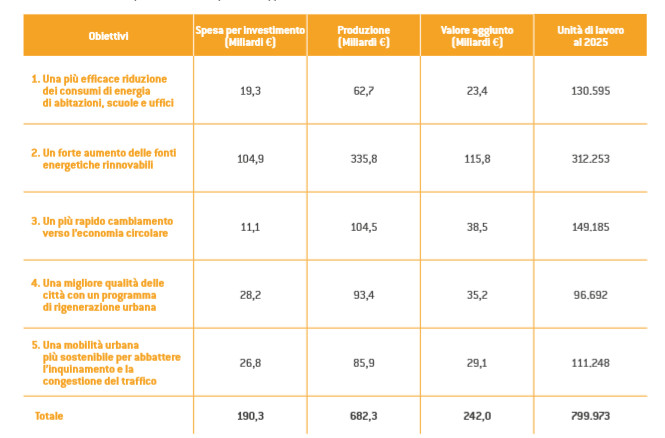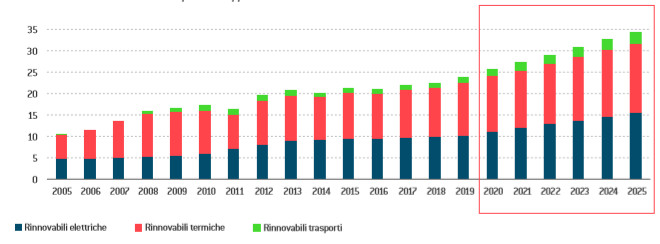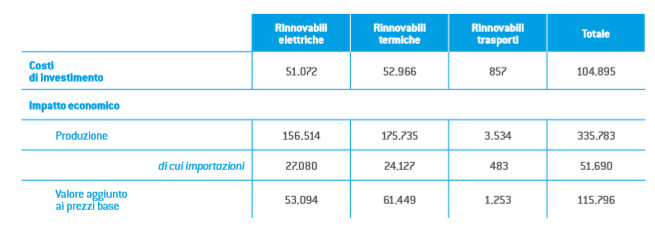Ascolto e partecipazione: due attività che l’associazione Via Milano 59 di Brescia ha fatto proprie fin dal momento della sua costituzione. A maggio del 2020 nasce per rispondere ad esigenze concrete – scaturite dalla pandemia – del quartiere in cui ha sede, il Quartiere Milano appunto. Questo rappresenta una delle aree più critiche e complesse della città. La multietnicità che lo anima convive con situazioni, talvolta estreme, di tensione sociale o abbandono degli spazi urbani a loro stessi, che spesso intimoriscono il resto della cittadinanza.
Prendersi cura di questo quartiere è l’obiettivo dell’associazione, che in un solo anno è cresciuta da 9 a 118 soci. Residenti e non hanno preso parte a questo progetto e da allora l’impegno volontario e la partecipazione hanno permesso di creare numerosi attività e servizi che stanno trasformando il quartiere da luogo di degrado a spazio di accoglienza e convivialità.
L’associazione ha fondato la sua operatività sul concetto di partecipazione attiva per dare risposte concrete alle necessità del quartiere. Nei primi mesi della sua attività ha così organizzato assemblee pubbliche per individuare le tematiche più sensibili e urgenti da affrontare. Da questi incontri sono emerse quattro tematiche diventate poi oggetto di quattro tavoli di lavoro, sempre condivisi e partecipati, dove da allora insieme si discute e decide. Mutualismo e solidarietà, parchi e cortili, salute e sanità, animazione e educazione sono i quattro ambiti nei quali si muove l’associazione e il quartiere.
Il primo grande tema affrontato è il diritto alla salute talvolta negato alle famiglie. La ricerca attivata ha permesso di giungere alla soluzione del problema: il Difensore Civico, una figura che è stata promossa e spiegata nel quartiere tramite la divulgazione di volantini in doppia lingua che permettono a tutti di comprendere e attivarsi.
Bambini e adolescenti sono l’altro tema che interessa il quartiere. Dal tavolo su animazione ed educazione è emersa la necessità di creare attività per i giovanissimi, che dopo mesi di chiusura in situazioni spesso disagevoli, avevano estrema necessità di fare attività all’aperto. Così maestre e docenti in pensione o ancora nella scuola, nell’estate 2020 hanno programmato un palinsesto di attività gratuite che hanno coinvolto più di cento bambini e adolescenti. Quest’anno per organizzare il nuovo calendario l’associazione ha coinvolto direttamente i ragazzi della scuola media del quartiere chiedendo a loro quali attività realizzare.

Il mutualismo e la solidarietà hanno dato luogo, durante il lockdown, a una dispensa alimentare (per 90 nuclei familiari) che agisce diversamente dal classico mutualismo caritatevole. Alle famiglie che accedono viene chiesto infatti di partecipare alle attività dell’associazione prestando aiuto alle persone in difficoltà o contribuendo al servizio della dispensa stessa, partecipando in base alle possibilità. La dispensa si trasforma così in uno strumento di coinvolgimento per quelle persone che ne usufruiscono, spesso poco partecipi alle iniziative.
La dispensa sociale ha dato poi origine al progetto “Negozi Solidali”, per vendere altro oltre ai viveri. Sono stati coinvolti 23 negozi tramite un sistema di buoni spesa che, pagati da altri residenti, possono essere utilizzati dalle famiglie in difficoltà assicurando loro beni che, seppur non di prima necessità, aiutano a migliorare la qualità della vita.
Il quartiere è uno spazio ricco di aree non utilizzate spesso diventate sedi di spaccio e malavita. Il tavolo spazi e parchi affronta questo problema cercando di rivitalizzare quegli spazi pubblici che potenzialmente potrebbero trasformarsi in aree gioco e di socialità. La prima idea nata dal tavolo di lavoro è la riapertura dei cortili del quartiere, spazi di condivisione fino agli anni ’70 e divenuti oggi parcheggi e zone di transito.

Così, nell’estate del 2020, ha preso il via il progetto il “Treno dei Desideri”, spettacolo teatrale itinerante che vede come protagonista un treno “viaggiatore” che sosta nei cortili dei palazzi offrendo ai residenti divertimento e, per molti, un’esperienza unica. Le persone del quartiere si spostano per seguire il Treno, e così facendo si incontrano, si conoscono e creano legami. Oggi l’impegno del tavolo è riportare in vita un’area verde abbandonata per offrire al quartiere uno spazio verde – rinominato “Parco del Sole Autogestito” – dove giocare e, come sempre, incontrarsi.
Questi sono i primi dodici mesi di vita di Associazione Via Milano 59, una realtà esplosiva che considera la cultura e la socialità come “cure” in grado di migliorare la vita delle persone. Stare insieme per stare bene, star bene stando insieme, questo il filo rosso che muove con successo l’associazione.
fonte: www.italiachecambia.org
#Iscriviti QUI alla #Associazione COORDINAMENTO REGIONALE UMBRIA RIFIUTI ZERO (CRU-RZ)
=> Seguici su Blogger
https://rifiutizeroumbria.blogspot.com
=> Seguici su Facebook
=> Seguici su Facebook