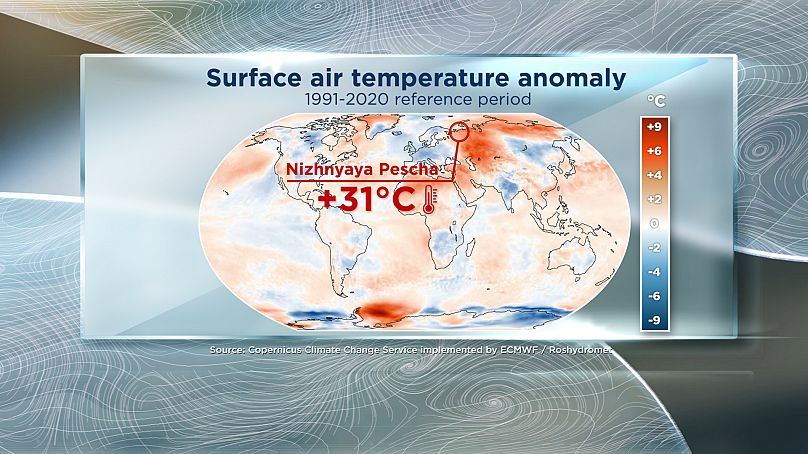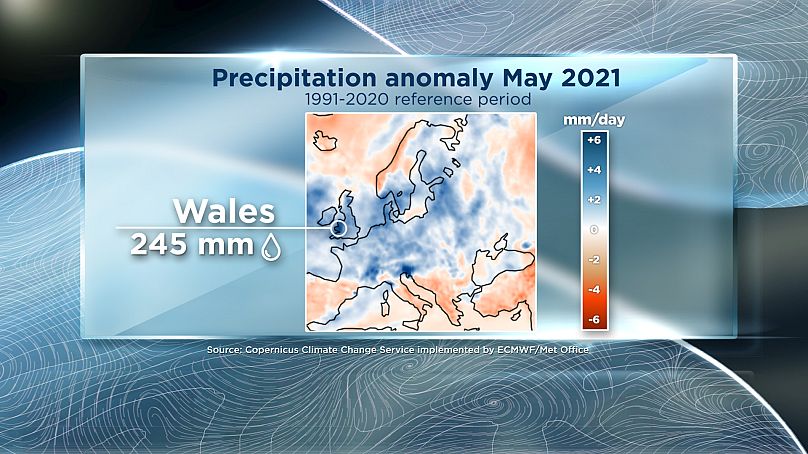Con una media di 400 rifiuti ogni 100 metri le nostre spiagge sono diventate delle piccole discariche. I rifiuti più abbondanti (60%) sono oggetti che abbiamo utilizzato per massimo cinque minuti: borse per la spesa, cotton fioc, posate usa e getta, cannucce, bottiglie. In alcune aree, anche i rifiuti spiaggiati che derivano dalle attività di pesca e acquacoltura sono molto abbondanti. Fra questi ci sono le “reste”, reti tubolari in plastica utilizzate per l’allevamento dei mitili (cozze), che costituiscono un problema molto sentito soprattutto lungo le coste dell’Adriatico, il mare italiano dove la mitilicoltura è più diffusa. In alcune regioni sono state trovate più di 100 reste ogni 100 m di spiaggia, in pratica una ogni metro. Questo particolare tipo di rifiuto è costituito di polipropilene (PP), un materiale estremamente resistente e duraturo.
Inquinamento: i rifiuti più abbondanti in mare sono oggetti che abbiamo utilizzato per massimo cinque minuti
La situazione non migliora nei fondali dove si deposita più del 70% dei rifiuti marini, il 77% dei quali è plastica. In alcune aree dell’Adriatico per esempio si trovano più di 300 oggetti per chilometro quadrato e la plastica rappresenta più del 80%. È stato stimato, da alcuni studi dell’Ispra, che un pescatore di Chioggia può arrivare a pescare fino a 8 tonnellate di rifiuti in un anno, ovvero 9 kg di rifiuti ogni 100 kg di pesce.
Uno dei principali impatti dei rifiuti marini sugli organismi è rappresentato dall’ingestione della plastica. Nel Mediterraneo più del 63% di tartarughe marine ha ingerito plastica. Altri studi effettuati dall’Ispra nel Mar Tirreno, rivelano che più del 50% di alcuni pesci analizzati e il 70% di alcuni squali che vivono in profondità avevano ingerito plastiche. Inoltre, in profondità, gli attrezzi da pesca, persi accidentalmente o deliberatamente abbandonati hanno un impatto sugli ambienti profondi perché intrappolano spugne, gorgonie, coralli neri. Occorre incoraggiare la marcatura delle attrezzature da pesca, in modo da poter risalire al proprietario in caso di perdita o abbandono in mare e gestire le attrezzature dismesse, favorendone, dove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.
fonte: www.ilfattoalimentare.it
La situazione non migliora nei fondali dove si deposita più del 70% dei rifiuti marini, il 77% dei quali è plastica. In alcune aree dell’Adriatico per esempio si trovano più di 300 oggetti per chilometro quadrato e la plastica rappresenta più del 80%. È stato stimato, da alcuni studi dell’Ispra, che un pescatore di Chioggia può arrivare a pescare fino a 8 tonnellate di rifiuti in un anno, ovvero 9 kg di rifiuti ogni 100 kg di pesce.
Uno dei principali impatti dei rifiuti marini sugli organismi è rappresentato dall’ingestione della plastica. Nel Mediterraneo più del 63% di tartarughe marine ha ingerito plastica. Altri studi effettuati dall’Ispra nel Mar Tirreno, rivelano che più del 50% di alcuni pesci analizzati e il 70% di alcuni squali che vivono in profondità avevano ingerito plastiche. Inoltre, in profondità, gli attrezzi da pesca, persi accidentalmente o deliberatamente abbandonati hanno un impatto sugli ambienti profondi perché intrappolano spugne, gorgonie, coralli neri. Occorre incoraggiare la marcatura delle attrezzature da pesca, in modo da poter risalire al proprietario in caso di perdita o abbandono in mare e gestire le attrezzature dismesse, favorendone, dove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.
fonte: www.ilfattoalimentare.it
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
#Iscriviti QUI alla #Associazione COORDINAMENTO REGIONALE UMBRIA RIFIUTI ZERO (CRU-RZ)
=> Seguici su Blogger
https://rifiutizeroumbria.blogspot.com
=> Seguici su Facebook
=> Seguici su Facebook