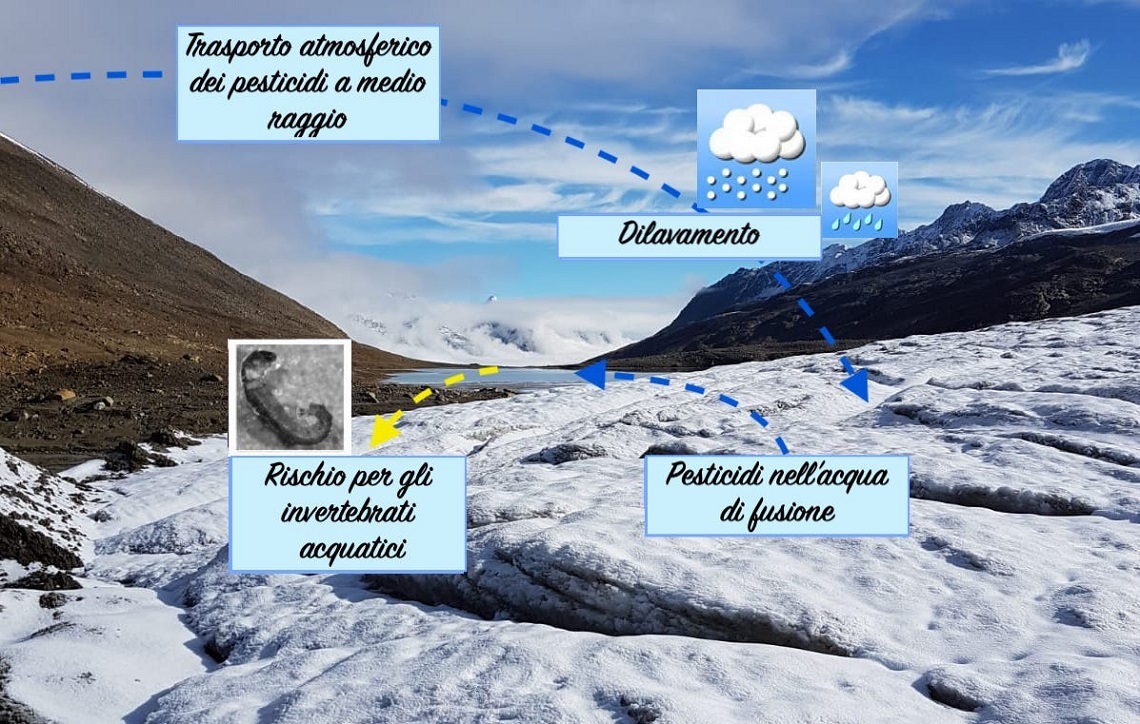Le correlazioni vengono al pettine: l'inquinamento, soprattutto quello atmosferico, potrebbe aver preparato il terreno al Coronavirus e alla sua diffusione. Quantomeno i dati evidenziano una relazione tra i superamenti dei limiti di legge per il Pm10 e il numero di casi infetti da Covid-19.
Lo dimostra uno studio curato da una dozzina di ricercatori italiani e medici della Società italiana di Medicina Ambientale (Sima). Leonardo Setti dell'Università di Bologna e Gianluigi de Gennaro dell'Università di Bari hanno passato gli ultimi venti giorni sui dati registrati nel periodo tra il 10 e il 29 febbraio e li hanno incrociati: da una parte quelli provenienti dalle centraline di rilevamento delle Arpa, le agenzie regionali per la protezione ambientale, dall'altra i dati del contagio da Covid19 riportati dalla Protezione Civile, aggiornati al 3 marzo, lasso temporale necessario considerando il ritardo temporale intermedio di 14 giorni pari al tempo di incubazione del virus. La conclusione è che si evidenzia una relazione tra i superamenti dei limiti di legge delle concentrazioni di Pm10 e PM2,5 e il numero di casi infetti da Covid-19.
La Pianura padana è in codice rosso anche nello studio: qui si sono osservate le curve di espansione dell’infezione che hanno mostrato accelerazioni anomale, in evidente coincidenza, a distanza di due settimane, con le più elevate concentrazioni di particolato atmosferico.
Il Pm10 avrebbe, secondo la ricerca, esercitato un'azione di boost, cioè di impulso alla diffusione virulenta dell'epidemia. Leonardo Setti lo mette in luce: «Le alte concentrazioni di polveri registrate nel mese di febbraio in Pianura padana hanno prodotto un'accelerazione alla diffusione del Covid19. L'effetto è più evidente in quelle province dove ci sono stati i primi focolai».
Potrebbe quindi essere questo uno dei motivi per cui la Pianura padana, rispetto alle altre zone d'Italia, ha cullato il virus in maniera più concentrata. A questo proposito è emblematico il caso di Roma, in cui la presenza di contagi era già manifesta negli stessi giorni delle regioni padane senza però innescare un fenomeno così virulento. Brescia è tra le città più colpite per inquinamento e caso di focolai di Coronavirus.
L'idea che l'inquinamento da Pm10 sia facilitatore delle infezioni non è nuova, a partire da polmonite e morbillo. La letteratura è lì a dimostrarlo e a suggerire norme importanti per ridurre l'inquinamento.
Il presupposto con il Coronavirus è lo stesso: il particolato funge da carrier per il trasporto del virus. Anche nell'etere. Forse tanto quanto una stretta di mano: «Più ci sono polveri sottili – afferma Gianluigi de Gennaro, dell'Università di Bari - più si creano autostrade per i contagi. È necessario ridurre al minimo le emissioni».
È noto che il particolato atmosferico funziona da vettore di trasporto per molti contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus che si “attaccano” (con un processo di coagulazione) anche per ore, giorni o settimane. Inoltre, sarebbero lunghe le distanze che il virus potrebbe percorrere così trasportato.
Lo studio mette in luce un altro fattore: «L'attuale distanza considerata di sicurezza – fa notare Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) riferendosi allo spazio di un metro - potrebbe non essere sufficiente». Così come evidentemente non sono sufficienti le misure finora adottate per contenere l'inquinamento atmosferico.
fonte: https://www.ilsole24ore.com