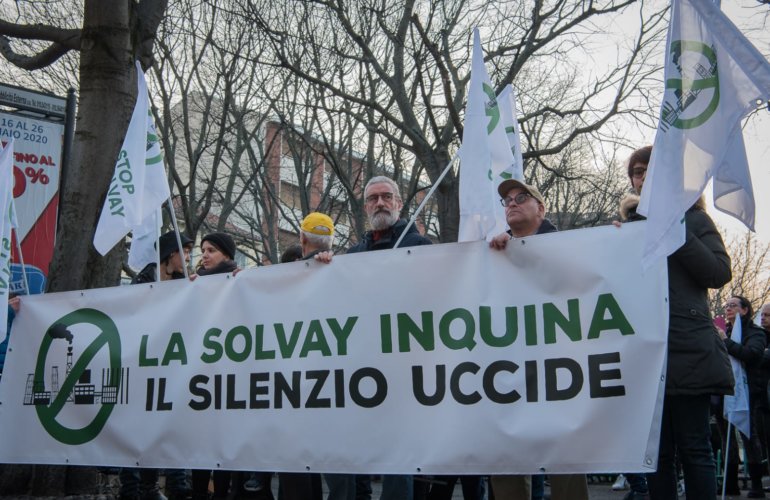Alla fonderia Tacconi è stato cambiato il nome, ma industria insalubre di
prima classe (così riconosciuta con una delibera della Giunta comunale dal
1996) rimane per il tipo di lavorazioni svolte.
Per legge questo vuol dire che deve essere isolata nella campagna e non può
stare nel centro dell'abitato di S. Maria degli Angeli.
Stefania Proietti, Sindaco di Assisi, alla riunione del 29 novembre scorso
con la cittadinanza di S. Maria degli Angeli ha continuato a ribadire che il
Sindaco, seppure massima autorità sanitaria, non avrebbe poteri sanitari aldilà
di intervenire in caso di trattamento sanitario obbligatorio e ove ci
fosse obbligo di tutela sancito da Arpa. Questo vorrebbe dire: aspettiamo che
avvenga un incidente o un incendio e poi… chiudiamo le finestre!
Forse c'è un po' di confusione.
Il Sindaco ha poteri regolamentari igienico-sanitari ex art. 50 d.lgs.
267/2000 e anche poteri contingibili e urgenti, nei casi di pericolo per la
salute.
Nei casi di dimostrati disagi e danni ascrivibili ad emissioni d'industrie
insalubri, quali fastidi alla gola e alla respirazione e odori nauseabondi,
come sono costretti a sopportare gli abitanti di via Protomartiri Francescani (e
non solo) a S. Maria degli Angeli, peraltro dimostrati dalla polvere che si
deposita perfino all'interno delle abitazioni, il Sindaco deve imporre al
produttore di rischio, attraverso il supporto tecnico di Arpa ed Asl, di
evitare tale disagio nel centro abitato.
Il Comitato di via Protomartiri Francescani ricorda che i monitoraggi delle
emissioni provenienti dalla fonderia, eseguiti fino ad oggi, mostrano la
presenza di inquinanti che non rientrano nei parametri normali.
C'è da dire, inoltre, come asseriscono i medici per l'Ambiente che
supportano il Comitato, che il rispetto di valori limite non rappresenta
necessariamente una garanzia per la salute. Certi inquinanti non devono proprio
esserci!
In merito al nuovo nome Fonderie di Assisi dato alla fonderia ex FOM Tacconi
ci sembra del tutto inopportuno associare, perché in palese contraddizione, la
parola Fonderie con Assisi che, ricordiamo, è la città di San Francesco patrono
dell'ecologia.
E ci domandiamo anche: ma la Soprintendenza competente, visto che questo
'catafalco' insiste sul cono panoramico di Assisi, dove volge il proprio
sguardo?
La Soprintendenza deve tutelare primariamente
l'interesse pubblico rappresentato dai valori ambientali e paesaggistici e dal
patrimonio storico e artistico della Nazione.
Così stabilisce la Costituzione della Repubblica
(art.9)
La conservazione del paesaggio è la risorsa principale per uno sviluppo
turistico sano e fruttuoso.
Sia i funzionari dello Stato che gli Amministratori devono rispettare le
leggi.
Attendiamo provvedimenti delocalizzativi delle Fonderie in un'area che
non crei altri disagi.
Solo così il Sindaco fa il Sindaco.
Prima la salute e poi il profitto, ne va del bene di tutti, lavoro
compreso!
ASSISI 18-12-2019
COMITATO DEI CITTADINI DI VIA
PROTOMARTIRI FRANCESCANI