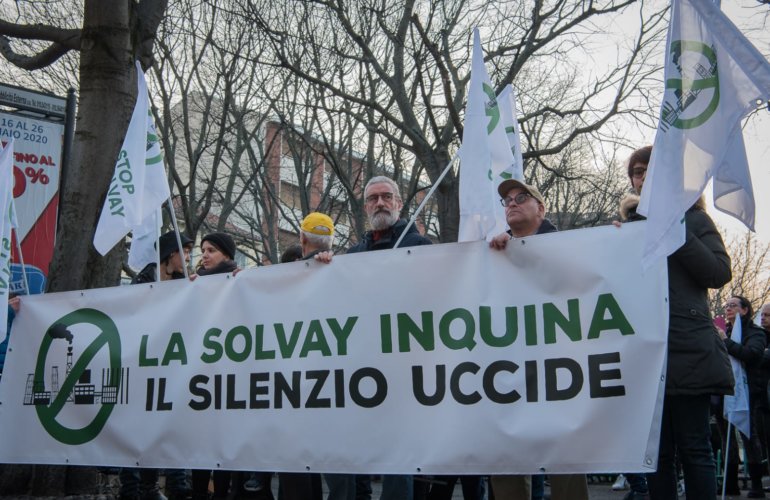I FRIDAYS DI CINEMAMBIENTE JUNIOR
Proiezioni e incontri online per le scuole(29 gennaio – 15 aprile 2021)
Il 23° Festival CinemAmbiente completa nel nuovo anno la sua attività proponendo dal 29 gennaio al 15 aprile 2021 l’ormai consueta rassegna di film e incontri a tema ambientale dedicati alle scuole.
In genere antecedente al Festival, ma posticipato a causa della pandemia, CinemAmbiente Junior si presenta quest’anno con un’edizione speciale che si svolge interamente online ed è quindi aperta al pubblico scolastico dell’intero territorio nazionale.Il cartellonecinematografico si articola in dieci proiezioni, ad accesso gratuito, che saranno disponibili, dietro prenotazione, su diverse piattaforme raggiungibili attraverso il sito del Festival www.cinemambiente.it.
Rivolti alle Scuole dei diversi ordini e gradi, i film si succederanno a cadenza settimanale, in concomitanza con i Fridays for Future, le giornate di mobilitazione scolastica dedicate all’ambiente.
Ogni venerdì alle ore 9.00 verrà proposto un nuovo titolo seguito dall’intervento di un esperto che dialogherà (sulla piattaforma Zoom) con il giovanissimo pubblico presente alla prima proiezione.
Il film e la registrazione dell’incontro rimarranno disponibili per la visione dalla prima proiezione per un’intera settimana.
Organizzata dall’Associazione Cinemambiente in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e MI, la rassegna si propone non solo come utile strumento di educazione ambientale, modellato con l’edizione online sulle attuali esigenze della didattica a distanza, ma anche come concreto complemento dei programmi scolastici. In particolare, le proiezioni proposte possono offrire spunti e contenuti specifici per l’insegnamento di educazione civica che, diventata da quest’anno materia con voto dedicato e obbligatoria in tutti i gradi d’istruzione, contempla come sua specifica area tematica anche quella dello sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Organizzata con la collaborazione di enti e associazioni che figurano tra i più importanti attori nazionali e locali impegnati nella tutela dell’ambiente e del territorio – Legambiente, WWF Italia, Slow Food, Società Meteorologica Italiana, Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, Arpa Piemonte, Casa Comune, Achab Group e Eduiren – e che mettono a disposizione le competenze dei loro esperti e studiosi negli incontri successivi alle proiezioni, la rassegna affronta svariati temi green con film diversificati secondo l’età scolastica.
Info e prenotazioni
Le proiezioni sono gratuite previa prenotazione obbligatoria. Alle classi prenotate verrà comunicata una password con cui sarà possibile accedere alla proiezione in qualunque momento nell’arco della programmazione settimanale del film prescelto.
Posti disponibili per ciascun film 1000.
Consulta il programma
Per informazioni e prenotazioni: junior@cinemambiente.it
fonte: https://www.snpambiente.it
#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria