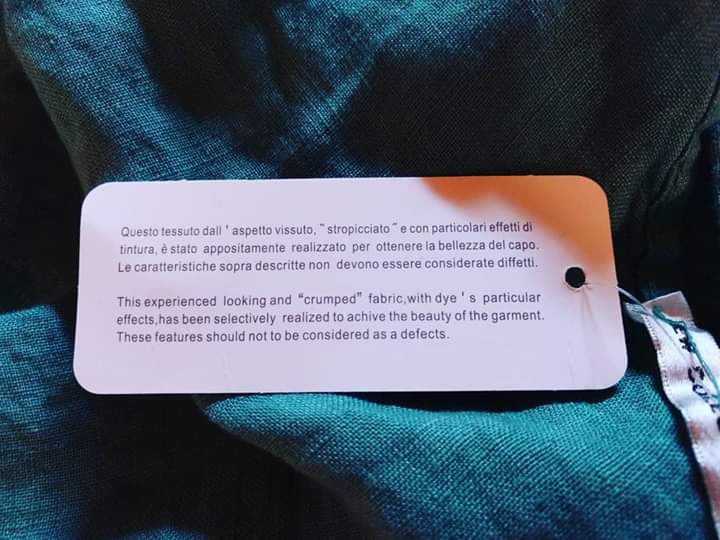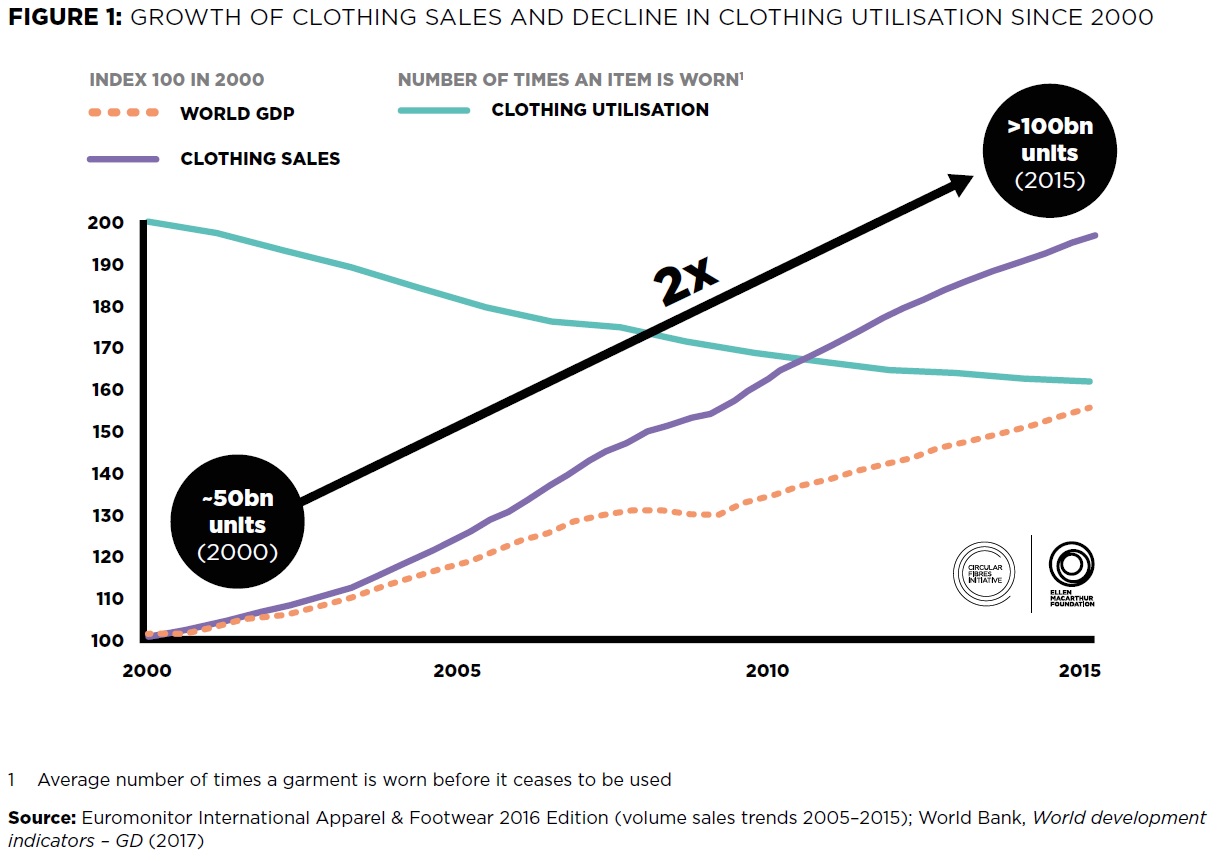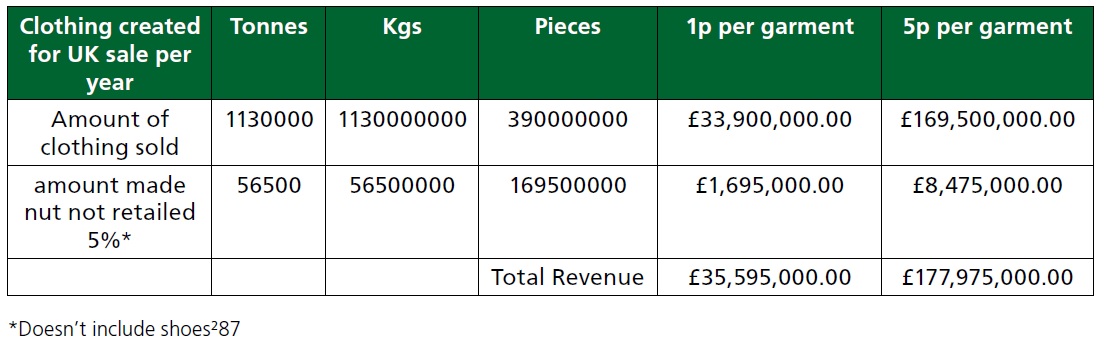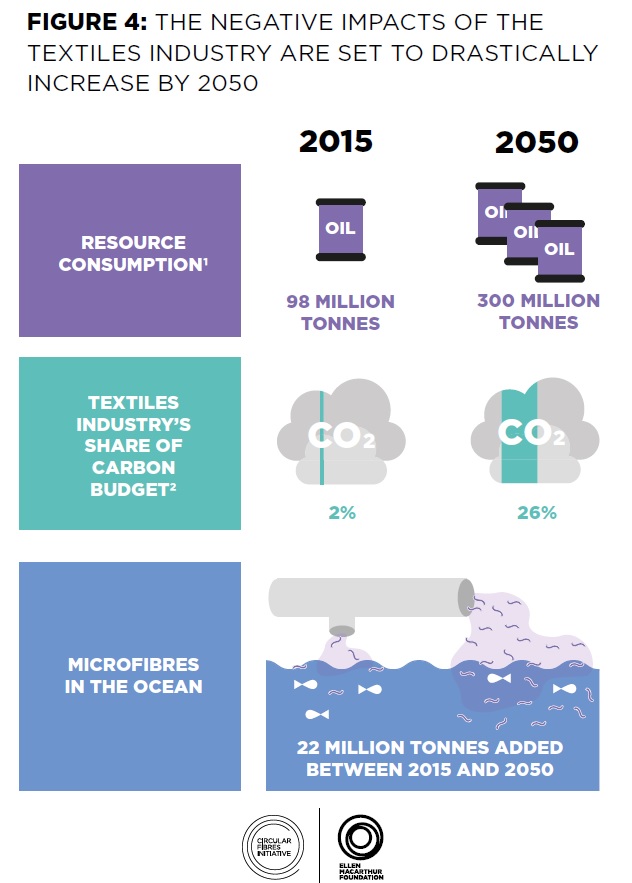La Lega non è soddisfatta: "Snaturato il testo iniziale, pescatori demonizzati"
Un riconoscimento, e non più una certificazione, per gli imprenditori della pesca che usano materiali a basso impatto ambientale e che prendono parte a campagne di pulizia marina e, allo stesso tempo, smaltiscono i rifiuti trovati accidentalmente in mare. Questo il senso di un emendamento al ddl Salvamare all'esame della commissione Ambiente alla Camera. L'emendamento di Rossella Muroni di LeU e Paola Deiana del M5s, relatrici al provvedimento, è stato approvato dalla commissione, e modifica così il testo.
Il disegno di legge “Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare” (legge Salvamare) contempla 7 articoli e sostanzialmente punta a trasformare i pescatori in eco-spazzini del mare, permettendogli di portare a terra i rifiuti tirati su durante la loro normale attività e conferirli all'impianto dedicato.
La commissione Ambiente ha dato il via libera anche ad altre proposte di modifica, come l'allargamento del raggio d'azione del decreto end of waste sui rifiuti accidentalmente pescati (sempre delle relatrici); si dovrà così pensare oltre che alla plastica e al suo riciclo anche ai "materiali non compatibili con l'ecosistema marino".
La Lega protesta - "La Lega compatta si è astenuta dal voto del cosiddetto ddl Salvamare in commissione Agricoltura: il testo iniziale è stato totalmente snaturato e con l'introduzione di una voce sui bollettini della Tari per il conferimento dei rifiuti recuperati dai fondali. Si demonizzano ingiustamente i pescatori. Sono inoltre spariti i criteri di premialità, che la Lega aveva proposto, nel sistema punti per le infrazioni, sull'attività di raccolta accidentale dei rifiuti da parte dei nostri pescatori". Così i deputati della Lega in Commissione Agricoltura di Montecitorio: Lorenzo Viviani (capogruppo), Mario Lolini (vicepresidente), Guglielmo Golinelli, Aurelia Bubisutti, Dimitri Coin, Flavio Gastaldi, Marzio Liuni, Carmelo Lo Monte e Martina Loss. "Il governo giallofucsia è uscito allo scoperto e ha varato la prima tassa sulle spalle degli italiani con l'introduzione di una nuova voce nel bollettino Tari, la tassa sui rifiuti, nascosta tra le maglie del ddl Salvamare. La Lega, in commissione Ambiente alla Camera, si è opposta a questo balzello che colpirà tutte le famiglie e le imprese, ma la maggioranza ha votato contro la nostra proposta sulla copertura con risorse statali".
fonte: http://www.e-gazette.it