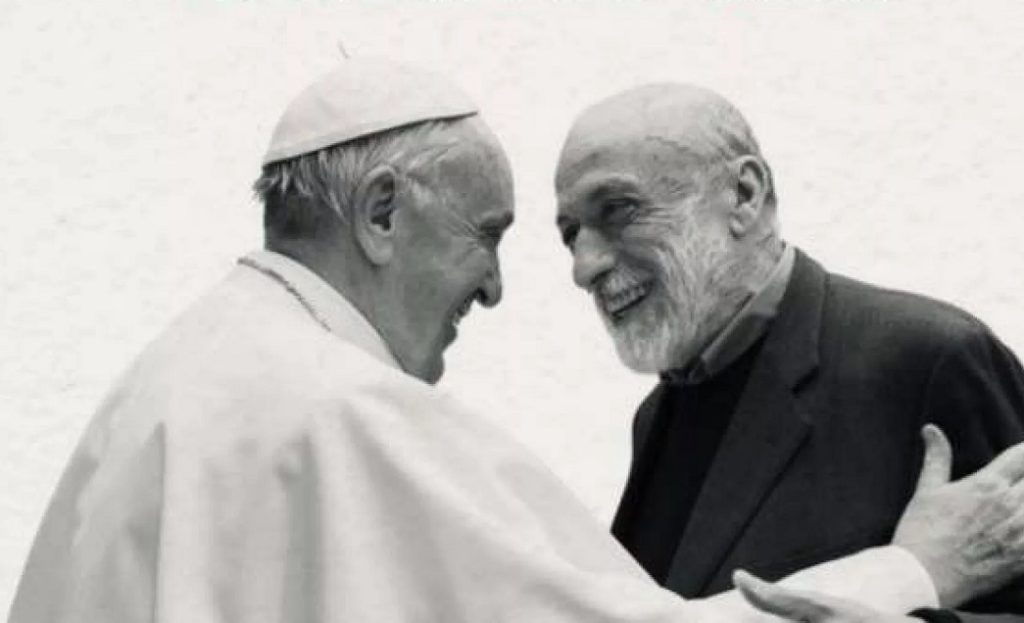Quest’anno il tema della Giornata mondiale della Terra è il ripristino degli ecosistemi. Ne abbiamo parlato con Alessandra Prampolini che, dallo scorso gennaio, è direttrice generale del Wwf Italia, prima donna a ricoprire questa carica nell’associazione. Dal consumo di cibo non più sostenibile all’agricoltura, dall’allevamento fino alla deforestazione, Alessandra Prampolini invita ad analizzare la crisi climatica e quella della biodiversità come fenomeni interconnessi, rispetto ai quali vanno messe in campo azioni integrate e trasversali. In quest’ottica, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che l’Italia si appresta a presentare a Bruxelles costituisce uno snodo fondamentale, perché le modalità con le quali decideremo di declinarlo tracceranno il solco lungo il quale ci muoveremo nei prossimi anni.
In occasione della Giornata mondiale della Terra il Wwf ha lanciato la campagna Food4Future. Qual è il messaggio principale che volete veicolare?
Dobbiamo modificare i sistemi agroalimentari sia dal punto di vista della produzione che da quello del consumo. Per come sono oggi, hanno impatti eccessivi sul pianeta e non sono efficienti: né per quanto riguarda la distribuzione – pensiamo al tema dei rifiuti e a quello della fame nel mondo –né per quanto concerne la salute, perché la gran parte del cibo che produciamo non è salutare. I sistemi agroalimentari vanno rivisti alla luce delle necessità umane e dei limiti del pianeta.Alessandra Prampolini è direttore generale del Wwf Italia dallo scorso mese di gennaio © Giovanna Quaglieri
Quali sono gli impatti negativi sull’ecosistema di un consumo di cibo poco sostenibile?
Clima e biodiversità sono crisi planetarie che rappresentano due facce della stessa medaglia: l’80 per cento della perdita di biodiversità è causata dall’agricoltura e dall’allevamento, che sono responsabili anche del 24 per cento delle emissioni nocive. C’è poi il grande tema del consumo del suolo: abbiamo già consumato i tre quarti delle terre emerse e la prima causa della deforestazione sono proprio le nuove coltivazioni e l’allevamento, che già occupano il 40 per cento delle terre emerse. Un altro punto importante è quello dei cicli biogeochimici: consumiamo fertilizzanti minerali in numero dieci volte maggiore rispetto a 50 anni fa, e ciò si traduce in inquinamento, degrado del suolo e peggiore qualità delle acque. In proposito, l’uso scorretto della risorsa idrica ha portato a un consumo triplicato in 50 anni dell’acqua destinata all’agricoltura, senza dimenticare che l’80 per cento dei laghi italiani versa in uno stato ecologico non buono.
Abbiamo già consumato i tre quarti delle terre emerse e la prima causa della deforestazione sono proprio le nuove coltivazioni e l’allevamento, che già occupano il 40 per cento delle terre emerse.
Il tema della Giornata della Terra 2021 è il ripristino degli ecosistemi. In proposito, un vostro recente report ha quantificato gli impatti sulla deforestazione legati al commercio internazionale. Cosa emerge in particolare da questo lavoro?
Emerge l’enorme impatto della deforestazione importata, nascosta nelle nostre abitudini di consumo e in quello che mangiamo. Un tempo le foreste si utilizzavano principalmente per realizzare utensili in legno o per il riscaldamento domestico, mentre ora la produzione di soia, olio di palma e carne bovina è la principale responsabile della deforestazione. Il Wwf sta lavorando con l’Unione europea a una proposta legislativa per ridurre l’impronta dei consumi, ponendo limiti all’importazione di prodotti che abbiano origine forestale o che siano legati alla deforestazione. Quella nascosta pesa ormai per l’80 per cento rispetto alla deforestazione in tutto il mondo; l’Europa è seconda solo alla Cina in termini di deforestazione importata, e l’Italia figura al secondo posto in Europa.
![]()

La deforestazione dell’Amazzonia brasiliana © Mario Tama/Getty Images
Sempre in riferimento anche al cibo che arriva sulle nostre tavole, stiamo perdendo il prezioso esercito degli insetti impollinatori. Qual è il quadro e quali sono le conseguenze?
Si tratta di una delle crisi più drammatiche a livello globale, di un fenomeno che procede a velocità spaventosa e che spesso in passato è stato ignorato. Il numero dei volatori in Europa si è ridotto del 70 per cento negli ultimi 30 anni, e oggi a livello globale il 40 per cento degli insetti più comuni come api selvatiche, farfalle e coleotteri rischiano l’estinzione. Ben l’80 per cento delle 1.400 piante da cui si produce cibo nel mondo richiede l’impollinazione: il venir meno di questo servizio ecosistemico fa crollare le possibilità di portare in tavola alimenti che garantiscono la nostra salute e il nostro sostentamento. La riduzione di cibi legati a una dieta sana come frutta, verdura, noci e semi, aumenta i rischi di diabete e di malattie cardiovascolari; anche perché al contempo si assiste alla crescita di colture alimentari povere di nutrienti come riso, soia, mais e patate.
Tra le principali cause dell’estinzione degli impollinatori ci sono anche i cambiamenti climatici. A livello globale si sta facendo abbastanza per contrastarne gli effetti?
Ancora no, purtroppo. Come Unione europea ci siamo posti l’obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e target progressivi intermedi con orizzonte al 2030. A fronte dell’Accordo di Parigi, manca però l’implementazione di un piano di azione vincolante per i diversi Paesi: gli obiettivi devono essere legati alla riduzione delle emissioni e a un aumento delle energie rinnovabili, e al contempo serve una chiara scansione temporale per il loro raggiungimento. Lo scorso anno non ha aiutato lo slittamento della Cop26 a causa dell’emergenza pandemica, perché avrebbe rappresentato un importante momento di confronto a cinque anni dagli accordi di Parigi.

L’agricoltura intensiva e il dissennato utilizzo di pesticidi hanno causato un allarmante declino degli insetti impollinatori, tra cui le api © Ingimage
Il Wwf ha rimarcato le “enormi prospettive di collaborazione” che esistono tra uomo e natura nel contrasto ai cambiamenti climatici.
Un aumento delle temperature causa una perdita di biodiversità, ma è bene rimarcare che è vero anche il contrario: ci sono tante specie animali che sono preziose alleate nel contrasto al cambiamento climatico. Faccio qualche esempio. Elefanti, gibboni e macachi svolgono un ruolo essenziale per diffondere i semi di molte specie arboree, e in questo modo contribuiscono all’espansione della biodiversità in habitat anche molto diversi fra di loro. In vita, le balene accumulano carbonio nei tessuti e quando muoiono lo depositano sui fondali marini: ogni balena adulta cattura in media 33 tonnellate di CO2. Anche le formiche, con il loro instancabile lavoro, generano una serie di reazioni chimiche che facilitano assorbimento della CO2 da parte del suolo: i suoli abitati da formiche hanno una capacità di assorbimento 300 volte superiore rispetto agli altri.
Il Next Generation Eu può rappresentare una svolta per la transizione ecologica dell’Europa?
Il Next Generation Eu è lo strumento del secolo e le modalità con le quali decideremo di utilizzarlo daranno l’impronta dei prossimi anni. Rappresenta insomma un’occasione unica e come Wwf stiamo chiedendo che l’approccio sia quello della transizione ecologica, a patto che lo sia realmente. Il primo principio è che il valore della natura deve essere, con un approccio trasversale, incorporato in tutti i processi decisionali.
In Italia si avrebbe entro il 2030 la creazione di 163 mila nuovi posti di lavoro grazie alle rinnovabili © Nicholas Doherty, Unsplash
Alessandra Prampolini, il 30 aprile l’Italia dovrà presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza all’Ue, su cosa si dovrebbe puntare con maggiore decisione?
Almeno il 37 per cento delle risorse deve essere destinato in azioni in difesa del clima e a tutela della biodiversità. In secondo luogo, l’azione di rilancio del nostro Paese deve prevedere un rinnovamento della strategia industriale, il cui fine ultimo deve essere la completa decarbonizzazione: ciò potrà avvenire solo con target di riduzione delle emissioni molto chiari e con investimenti massicci sulle energie rinnovabili. Va infine riqualificata la natura: in Italia abbiamo uno dei patrimoni più importanti in Europa, ma anni di consumo incauto di suolo hanno fatto sì che siano sopravvissute piccole isole di biodiversità, non collegate fra di loro, che oltretutto si stanno riducendo. Servono quindi azioni per la tutela, il ripristino e la riconnessione delle tante aree che il nostro Paese ospita: ciò a vantaggio non solo del turismo, ma anche di attività come l’agricoltura e la pesca.
fonte: www.lifegate.it
#RifiutiZeroUmbria
- Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria