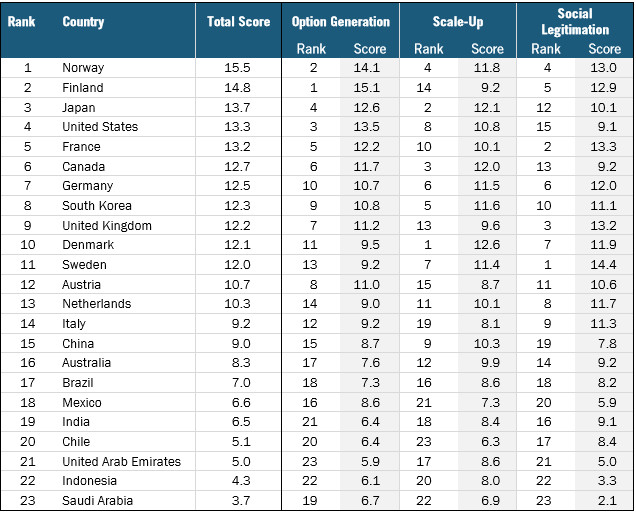Dieci i progetti innovativi o start up selezionati nella terza edizione di Next Energy, per la Call for Ideas, che accederanno a un programma di empowerment imprenditoriale e di incubazione a cura di Cariplo Factory, della durata di 3 mesi, diffuso su tutto il territorio nazionale.
La giuria, a valle della presentazione fatta dai 13 team candidati, ha valutato tutti i progetti e selezionato i 10 di maggiore interesse relativamente alle aree di applicazione specificate nel bando nell’ambito della sostenibilità ambientale nel settore energetico: Green Technologies, E-mobility, Energy storage, Sensoristica e Internet of Things, Soluzioni smart per la manutenzione degli asset elettrici, soluzioni/tecnologie al servizio della rete elettrica, Energy harvesting, Tool e sensori di analisi e misurazione dell’inquinamento, Monitoraggio e analisi della crescita della vegetazione.
Tra i requisiti specificati nel bando, un livello di Technology Readiness Level (TRL) compreso tra 2 e 5 e un componente del team con meno di 35 anni.
Al termine del periodo di incubazione, a maggio, la Giuria premierà il progetto più promettente con un voucher di 50mila euro in servizi di accelerazione e go-to market.
La formula adottata per questa Call of Ideas punta a valorizzare progetti in grado di offrire soluzioni innovative e sostenibili a supporto della transizione energetica in atto.
“Abbiamo ampliato le aree di interesse di questa edizione della Call con la consapevolezza che le azioni di un’Azienda come Terna, orientata all’innovazione tecnologica, debbano essere finalizzate alla protezione e al sostegno delle risorse del territorio“, ha detto Catia Bastioli, presidente Terna.
Per Carlo Mango, CEO Cariplo Factory, “il successo in termini di partecipazione e la qualità dei progetti testimoniano come Next Energy sia l’iniziativa di riferimento in Italia per talenti, innovatori e startup del settore Energy. Con il supporto degli incubatori partner, diffusi su tutto il territorio nazionale, i dieci progetti selezionati iniziano un percorso di crescita che sarà accompagnato non solo da Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory, ma da tutte le startup che appartengono alla grande community di Next Energy”.
Le 10 start up selezionate
BLOCKIT
BlockIt vuole cambiare la concezione di datacenter come edificio energivoro, ad elevato impatto ambientale e generalmente posto lontano dai centri abitati, trasformandolo in una risorsa in grado di essere implementata all’interno di quartieri, così da fornire un servizio di teleriscaldamento per i cittadini. BlockIt ha quindi l’obiettivo di riutilizzare l’energia che ad oggi viene dispersa in ambiente. Ciò avviene attraverso una tecnologia ad immersione (Immersion Cooling technology) in grado di ridurre sia i consumi elettrici di un datacenter di circa il 35% che la superficie occupata di circa 10 volte.
Innovazione: Il focus attuale è ridurre i consumi dei datacenter e la concentrazione di potenza di calcolo. L’innovazione è il riutilizzo del 100% del calore dissipato dall’hardware che è convogliato ad utenze termiche tramite teleriscaldamento. Il consumo di elettricità dei server diventerà un servizio per le utenze termiche e queste ultime erogheranno un servizio di raffrescamento per i datacenter.
CREON
Creon vuole sviluppare un sistema di illuminazione per spazi esterni ad uso privato e pubblico energeticamente autosufficiente grazie a celle a combustibile microbiologiche (MFC) integrate nel prodotto che sfruttano l’attività batterica del sottosuolo per produrre corrente elettrica.
Innovazione: Creon, sfruttando la tecnologia delle celle a combustibile microbiologiche, ha realizzato un dispositivo che sfrutta la biochimica del metabolismo anaerobico batterico per generare corrente continua. E’ un metodo di produzione sostenibile e non inquinante, che non produce scarti e che trae passivamente energia dai processi che avvengono comunemente in natura.
CRYPTOLAB
Cryptolab si occupa principalmente di sicurezza informatica on line per quanto riguarda sia l’home banking che il cloud computing. Ha sviluppato un algoritmo innovativo di crittografia omomorfica che consente agli amministratori dei cloud storage, i server sui quali vengono depositati i dati e i file di chi utilizza il cloud computing, di lavorare sui dati e fare calcoli su di essi, senza avere però la possibilità di vederli e di “leggerli”.
Innovazione: Cryptolab ha sviluppato una tecnologia di encryption, browsing e searching su dati criptati. E’ in grado di criptare, collezionare, memorizzare e trasferire i dati, via internet, mantenendoli sempre criptati. Inoltre, è in grado di effettuare ricerche all’interno di files criptati senza doverli decriptare. Il motore di ricerca che opera all’interno dei dati criptati è stato denominato Crypto-SearchEngine e trova applicazione in diversi ambiti della Cyber Security.
NEXUS QUBEE
Nexus ha sviluppato Qubee, un sensore per la misurazione della qualità dell’aria indoor. Ha la forma di una lampada di design con LED multicolore con sensori che monitorano costantemente la qualità dell’aria. Il colore del LED cambia in base alla qualità dell’aria: verde se buona, giallo se mediocre, rosso se pessima. I dati provenienti dai sensori possono essere controllati e visualizzati in tempo reale attraverso un’APP.
Innovazione: Qubee ha un sensore per la qualità dell’aria indoor che misura VOC e CO2; il tutto è controllato da un microcontrollore con connessione WiFi e Bluetooth integrata. Il circuito è stato completamente sviluppato e progettato in-house, così come l’APP di controllo. Per applicazioni outdoor è stato previsto l’utilizzo di connettività LoRa e sensori con range più elevati per applicazioni da esterno.
PREINVEL
Preinvel ha sviluppato una tecnologia di filtraggio atta a ridurre le emissioni di polveri e inquinanti. La soluzione proposta è costituita da un condotto con delle sezioni che permettono la formazione di zone di depressione capaci di risucchiare delle polveri e far uscire aria pulita e filtrata. È stato pertanto progettato un filtro fluidodinamico capace di garantire livelli di riduzione delle emissioni di polveri, micropolveri ed inquinanti.
Innovazione: Il filtro permette l’abbattimento di inquinanti e polveri industriali inferiori ad 1 micron, riuscendo a separare le polveri inferiori ai 10 micron in un serbatoio e quelle superiori (marcopolveri) in un secondo serbatoio permettendo così un eventuale riutilizzo nel ciclo produttivo.
SOLQUBE
Solqube ha sviluppato un impianto solare portatile 3D da 1 kW in un metro cubo per alimentare ambienti chiusi grazie ai pannelli fotovoltaici a doppia interfaccia. Tali pannelli brevettati vengono disposti verticalmente anziché orizzontalmente catturando così più luce e risparmiano lo spazio occupato dell’80% rispetto ad un sistema solare 2D.
Innovazione: I pannelli solari contengono superfici riflettenti che consentono di riflettere la luce tra i pannelli adiacenti, aumentando l’efficienza complessiva del sistema.
VT ENERGY INNOVATION
VT Energy Innovation sviluppa l’innovativo progetto FNX che unisce la tecnologia fotovoltaica a concentrazione CPV con un nuovo concetto d’inseguimento solare, coperto da brevetto PCT. Il risultato è la possibilità di una installazione del sistema su tetti in grado di sviluppare una maggiore quantità di energia.
Innovazione: Il progetto FNX, usufruendo dell’unione tra la tecnologia CPV e l’inseguimento tangenziale, vanta una produzione di energia annua maggiore rispetto ai sistemi tradizionali a parità di spazio occupato, permettendo anche l’installazione del sistema sui tetti. Inoltre permetterà la produzione di energia termica, un sotto prodotto che può essere sfruttato dall’utente andando così ad aumentare l’efficienza di tutto il complesso energetico.
WINDCITY
Windcity ha sviluppato e prodotto V-Stream, una turbina a geometria variabile. La tecnologia è composta da mini-turbine auto-adattive capaci di generare di energia da vento e acqua. La soluzione di Windcity può rappresentare una nuova frontiera nelle energie rinnovabili, perché garantisce una produzione energetica ottimale e adattiva rispetto alle caratteristiche della risorsa naturale. Inoltre, la dimensione di V-Stream consente l’utilizzo di queste fonti di energia anche in contesti urbani.
Innovazione: L’innovazione di Windcity, protetta da brevetto, è legata alla capacità delle turbine di adattarsi alle variabilità della natura, grazie a: 1. Configurazione omnidirezionale della turbina; 2. Geometria variabile completamente passiva, quindi con controllo sensor-less; 3. Geometria variabile integrata in raggio ed in passo delle pale: la turbina lavora su una intera famiglia di curve di coppia, a differenza della curva singola dei rotori tradizionali.
WISAIR
Wiseair ha creato un vaso smart in grado di monitorare la qualità dell’aria attraverso un sensore montato in esso, alimentato direttamente da una tecnologia innovativa di conversione di energia, sviluppata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Il sensore della qualità dell’aria è connesso a un circuito elettronico in grado di misurare e trasmettere in modo wireless i dati sulla qualità dell’aria al database centrale in tempo reale.
Innovazione: Il dispositivo fa uso di una Plant Microbial Fuel Cell (PMFC): un sistema bioelettrochimico in grado di convertire l’energia chimica in eccesso rilasciata dalle radici della pianta in corrente elettrica utile. Il valore estetico intrinseco del prodotto, unito alla totale autonomia di funzionamento sono i principali punti di forza che ne permetteranno una diffusione capillare nei contesti urbani.
WEEDEA
Weedea ha sviluppato Secure Shelter, un servizio web per l’analisi e la visualizzazione di dati di monitoraggio strutturale statico e dinamico di edifici e infrastrutture. Il sistema consiste in sensori che inviano dati in tempo reale. Tali dati vengono analizzati da algoritmi di intelligenza artificiale in grado di rilevare anomalie nella sanità strutturale dell’edificio, inviando notifiche ai gestori e amministratori.
Innovazione: La piattaforma sfrutta i recenti sviluppi nel settore del Machine Learning e del Data Mining per fornire strumenti per l’analisi di serie temporali e il rilevamento autonomo delle anomalie strutturali. L’architettura della piattaforma web utilizza tecnologie in grado di acquisire, gestire e analizzare grandi moli di dati, algoritmi per l’analisi, clusterizzazione e classificazione dei dati.
fonte: www.qualenergia.it