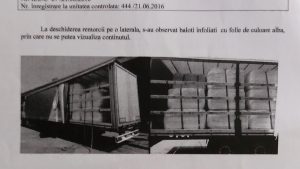Il focus della relazione semestrale gennaio-giugno 2019 della Direzione Investigativa Antimafia nazionale
E’ stata da poco pubblicata la consueta relazione semestrale relativa alla prima parte del 2019, della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nazionale.
Nell’articolato documento prodotto dalla DIA è contenuto un interessantissimo focus sul tema “mafia e rifiuti”. Nel focus si evidenzia come già da alcuni decenni le organizzazioni criminali hanno compreso la reale portata del business derivante dalla loro infiltrazione nel ciclo dei rifiuti a fronte di un ampio margine di impunità rispetto ad altri settori criminali.
Questa consapevolezza è sinteticamente espressa nella frase “Trasi munnizza e n’iesci oro” tratta da una intercettazione telefonica di tre decenni fa. Il senso di quella frase – declinata, nel tempo, non solo in siciliano e in altri dialetti, dal nord al sud del Paese, ma anche in perfetto italiano e in diverse lingue straniere – viene ancora oggi rinvenuto, nelle attività tecniche quotidianamente svolte in tema di criminalità ambientale.
estratto del focus “Mafia & rifiuti” dalla Relazione della DIA
Il Focus si pone l’obiettivo di analizzare l’intera filiera di gestione dei rifiuti, mettendola in relazione (grazie a dati di fatto emersi in indagini ed operazioni di servizio) con l’infiltrazione della criminalità organizzata, per cercare di individuare gli snodi più a rischio, affinché le Autorità preposte possano eventualmente intervenire sul ciclo dei rifiuti. Il rapporto sottolinea come oggi si registra, nel profilo criminale, un modus operandi quasi sempre sovrapponibile, indipendentemente dal contesto territoriale in cui si opera, caratterizzato da una tale specializzazione da consentire, in caso di necessità, l’immediata rimodulazione delle condotte e delle rotte dei rifiuti.
La lunghissima filiera dei rifiuti (produzione – assegnazione dei servizi – raccolta – trasporto – trattamento – smaltimento) vede la contestuale presenza di diversi “attori” – gli enti pubblici che assegnano i servizi di raccolta, i produttori dei rifiuti, gli intermediari, i trasportatori, gli impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti, i laboratori di analisi e gli smaltitori.
Un ruolo fondamentale viene svolto dalla figura del produttore del rifiuto, cioè l’imprenditore che ha la necessità di disfarsi dei quantitativi prodotti dalla propria azienda. Non di rado la scelta d’impresa, tesa ad economizzare sui costi e ad imporsi sul mercato, coincide con la volontà di liberarsi illegalmente dei rifiuti per abbattere i costi di produzione e acquisire, così, una posizione di vantaggio rispetto ad altre aziende che, con trasparenza ed onestà, affrontano tutti gli oneri previsti dalle disposizioni di legge. Ma tutti gli altri attori coinvolti nel ciclo dei rifiuti presentano criticità analizzate in dettaglio dal rapporto.
Il focus approfondisce nella prima parte gli aspetti criminogeni della complessa filiera dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi – compresi i recenti casi che hanno visto, a macchia di leopardo sul territorio nazionale, numerosi incendi presso aree periferiche e capannoni – tenendo presenti le criticità registrate, negli ultimi decenni, in primo luogo in Campania, punto nodale delle problematiche connesse ai reati ambientali.
Successivamente l’analisi si estende alle altre regioni, a cominciare da quelle a tradizionale presenza mafiosa, basandosi sulle inchieste concluse, nel tempo, dalla DIA e dalle Forze di polizia, sui provvedimenti di scioglimento degli enti locali e sulle interdittive antimafia, che danno conto della complessa azione di contrasto, nel
profilo preventivo e repressivo, sviluppata in tale settore negli ultimi anni.
Già nel dicembre 1994, Legambiente e l’Arma dei carabinieri, con l’Istituto di ricerca “Eurispes”, presentarono il primo Rapporto sulla criminalità ambientale in Italia. In quell’occasione, venne coniato il termine “ecomafia” che entrò cinque anni più tardi nei dizionari della lingua italiana.
La DIA osserva che “il crimine ambientale è un fenomeno in preoccupante estensione proprio perché coinvolge, trasversalmente, interessi diversificati. Il prodotto di tali comportamenti illeciti interferisce sull’ambiente e sull’integrità fisica e psichica delle persone, ledendone la qualità della vita, con conseguenti rilevanti costi sociali.”
Già da quella ricerca emergeva uno scenario preoccupante sull’illegalità ambientale nel nostro Paese e sul ruolo che giocava in questo settore la criminalità organizzata
di tipo mafioso, soprattutto nel meridione d’Italia. Era un quadro che raccontava di rifiuti speciali pericolosi che, dal nord, finivano smaltiti illegalmente nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia), in quei territori cioè dove maggiore era il controllo da parte delle organizzazioni criminali.
fonte: https://www.snpambiente.it