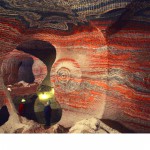La combustione di combustibili fossili ha ricevuto la maggior parte dell'attenzione nel dibattito sul cambiamento climatico, che ha portato a progressi vitali. La transizione in rapida evoluzione all'energia solare ed eolica è estremamente importante. Ma circa due terzi delle emissioni di gas serra provengono dai processi lineari di estrazione, estrazione, produzione e smaltimento dei prodotti di consumo.

Il sistema lineare dispendioso ed ecologicamente catastrofico è stato sviluppato nel 20 ° secolo specificamente per arricchire le aziende che hanno sgranato i loro profitti estraendo più risorse naturali - petrolio per produrre plastica, minerale per metallo e legno per carta - senza essere ritenute responsabili del danno ambientale hanno causato. Hanno anche incrementato i profitti, a grandi spese del pubblico, producendo prodotti non per una longevità ottimale, ma con l'obiettivo che diventassero presto obsoleti o fossero cestinati dopo un singolo utilizzo. Ciò, a sua volta, ha costretto l'estrazione aggiuntiva di risorse naturali per ogni nuovo prodotto fabbricato. Come rivelerò più ampiamente nel primo capitolo, l'idea che i prodotti e il loro imballaggio debbano essere gettati via con noncuranza dopo un utilizzo piuttosto che riparati, riutilizzati, o riciclato è stato impiantato nella coscienza pubblica attraverso campagne pubblicitarie. Così era il fascino di "scambiare" con nuovi prodotti prima che fosse necessario sostituirli. All'insaputa dei contribuenti, le aziende responsabili di ciò sono state in grado di ridurre queste spese su di noi; molti dei peggiori trasgressori, come gli estrattori di combustibili fossili, hanno insidiosamente fatto pressioni e guadagnato centinaia di miliardi di dollari in sussidi federali. Il pubblico ha inconsapevolmente pagato miliardi di dollari delle tasse per sovvenzionare lo sviluppo e la crescita delle industrie che hanno beneficiato dell'economia del prendere-fare-sprecare.come gli estrattori di combustibili fossili, hanno insidiosamente fatto pressioni e guadagnato centinaia di miliardi di dollari in sussidi federali. Il pubblico ha inconsapevolmente pagato miliardi di dollari delle tasse per sovvenzionare lo sviluppo e la crescita delle industrie che hanno beneficiato dell'economia del prendere-fare-sprecare. come gli estrattori di combustibili fossili, hanno insidiosamente fatto pressioni e guadagnato centinaia di miliardi di dollari in sussidi federali. Il pubblico ha inconsapevolmente pagato miliardi di dollari delle tasse per sovvenzionare lo sviluppo e la crescita delle industrie che hanno beneficiato dell'economia del prendere-fare-sprecare.
Non c'è motivo per cui dovremmo continuamente pagare una tariffa per l'estrazione di una risorsa naturale ogni volta che utilizziamo un prodotto o per il suo smaltimento dopo averlo utilizzato. Negli ultimi 75 anni siamo stati indotti a pagare costi inutili, mentre la terra, l'aria e l'acqua che possediamo collettivamente sono state spogliate.
Il danno arrecato al pianeta e alle nostre società sta diventando sorprendentemente chiaro. Il cambiamento climatico sta progredendo ancora più rapidamente del previsto. Siccità più frequenti e gravi stanno contribuendo a incendi boschivi sempre più devastanti. Le imponenti esplosioni non solo rilasciano enormi volumi di carbonio nell'atmosfera, ma riducono anche drasticamente il volume di carbonio che le foreste decimate estraggono dall'aria e distruggono le case di centinaia di migliaia di persone ogni anno. Le foreste pluviali, che sono i più potenti estrattori di carbonio, si stanno esaurendo al ritmo di circa 31.000 miglia quadrate all'anno. La ricerca mostra che sia l'ondata di caldo record che ha colpito l'Europa nell'estate del 2020 sia le piogge torrenziali della tempesta tropicale Imelda, che ha causato gravi inondazioni in Texas a settembre, sono state intensificate dai cambiamenti climatici. Le Nazioni Unite stimano che la scarsità d'acqua legata al clima affliggerà i due terzi della popolazione mondiale entro il 2025.
Per molte comunità in tutto il mondo, gli effetti sono già stati devastanti e sono stati avvertiti in modo sproporzionato nelle aree più povere e dalle popolazioni indigene. Come ha rivelato la quarta valutazione nazionale del clima, emessa dal governo federale degli Stati Uniti, le persone che vivono nei quartieri più poveri del paese subiscono la maggiore esposizione sia all'inquinamento che ai danni alla proprietà a causa di eventi meteorologici estremi. Le fabbriche che emettono tossine sono concentrate vicino ai quartieri poveri. Ad esempio, Fortune ha riferito che nella sezione West Louisville di Louisville, Kentucky, che è al primo posto per scarsa qualità dell'aria nelle città americane di medie dimensioni, l'80% della popolazione è nera e l'aria è contaminata da 56 strutture che vomitano tossine. I residenti di West Louisville vivono in media 12.5 anni in meno rispetto ai residenti bianchi dei quartieri ricchi della città.
Per quanto riguarda i popoli indigeni, le Nazioni Unite hanno riferito sugli effetti ad ampio raggio dell'incombente carenza d'acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai nell'Himalaya; siccità e punire la deforestazione nelle aree dell'Amazzonia popolate da gruppi indigeni; l'esaurimento di renne, caribù, foche e pesci da cui fanno affidamento le popolazioni artiche e l'espansione delle dune di sabbia e la siccità che colpiscono l'allevamento di bovini e capre nel bacino africano del Kalahari.
Non c'è niente di efficiente nel cestinare circa 42 libbre di prodotti elettronici all'anno per americano, quando così tanti di quegli articoli potrebbero essere rinnovati e rivenduti.
Tuttavia, anche se le prove della devastazione sono aumentate, il degrado delle risorse è aumentato negli ultimi dieci anni. Un terzo del suolo terrestre è già scomparso e se gli attuali tassi di esaurimento continuano, il pianeta si esaurirà tra 60 anni. Il tasso di estinzione delle specie sta accelerando, con circa il 20% degli animali terrestri uccisi dal 1900, il 40% delle specie di anfibi e 1 milione di specie ora minacciate di estinzione. Come ha rivelato un flusso costante di foto orribili di balene, delfini e tartarughe marine che vengono trascinati sulla riva con lo stomaco pieno zeppo di plastica, i nostri oceani sono devastati dai rifiuti di plastica. Avendo scoperto che la plastica si scompone in microunità, i ricercatori hanno scoperto che si sono fatti strada in ogni angolo del pianeta e anche nella nostra acqua potabile. Come ha affermato il presidente della Piattaforma intergovernativa di politica scientifica delle Nazioni Unite sulla biodiversità e i servizi ecosistemici in merito a una valutazione allarmante della biodiversità globale del 2020, "Stiamo erodendo le fondamenta stesse delle nostre economie, dei mezzi di sussistenza, della sicurezza alimentare, della salute e della qualità della vita in tutto il mondo".
Di fronte a prove inequivocabili del danno che hanno causato, molte delle società di combustibili fossili, minerarie e manifatturiere, nonché la maggior parte dei grandi proprietari di discariche, hanno combattuto furiosamente contro tutte le misure di riparazione. Ho avuto una visione in prima fila a Recyclebank ea New York City della subdola con cui hanno diffuso bugie e ostacolato il cambiamento. Ho visto come i progressi nell'espansione e nel miglioramento del riciclaggio e nella riduzione dell'uso di materiali degradanti per l'ambiente siano stati ostacolati. Quando il sindaco Michael Bloomberg e io abbiamo proposto di vietare il polistirolo, ad esempio, siamo stati attaccati con una campagna di disinformazione. Nel bel mezzo della crisi del COVID-19, la coalizione pro-plastica ha spudoratamente promosso l'affermazione del tutto infondata che i sacchetti riutilizzabili avrebbero diffuso il virus, approfittando di quella che vedevano come un'opportunità per ribaltare i divieti dei sacchetti di plastica.(La copertura della stampa di questo problema può essere ricondotta a un comunicato stampa del gruppo di lobbying chiamato inganno l'American Progressive Bag Alliance.)
I sostenitori del sistema "prendi-fai-rifiuti" hanno caratterizzato l'economia lineare come il mercato libero ottimamente efficiente. Ma non c'è niente di efficiente nel fatto che circa il 90% della plastica, prodotta con l'uso di una grande quantità di energia, finisce per ammuffire lentamente nelle discariche, quando gran parte di essa potrebbe essere riciclata. (Come vedremo, molte grandi aziende chiedono a gran voce di comprarlo.) Non c'è niente di efficiente nel cestinare circa 42 libbre di prodotti elettronici - la parte in più rapida crescita del flusso di rifiuti - per ogni americano ogni anno, quando così tanti di quelli gli articoli potrebbero essere rinnovati e rivenduti. Non c'è niente di efficiente nel 40 percento del cibo acquistato dagli americani che va sprecato, gran parte di esso viene scaricato quando è ancora buono da mangiare.
fonte: www.greenbiz.com/
=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz
=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria